Ballare al volante, ballare al cinema
13-09-2017, 16:4021tw, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, fb2020, musicaPermalinkBaby Driver (Edgar Wright, 2017).
C'è gente che balla là in strada. Lo fanno di nascosto, non li riconosci - se non dalle cuffiette, e da come tamburellano sul volante al semaforo. Non lo fanno per esprimersi o per esporsi o per piacere a sé stessi: lo fanno e basta, sono nati così, non smetteranno finché gli batte un cuore. Non sono più allegri di te, tutt'altro: c'è chi ha un fischio nella testa, o un dolore che non passa, o un grido che gli urla in testa, una canzone da dimenticare suonandoci sopra migliaia di altre canzoni. C'è gente che balla al volante, e non sono gli autisti peggiori.
Già ai tempi di Hot Fuzz era abbastanza chiaro quanto Edgar Wright fosse affezionato a quei luoghi comuni del cinema d'azione che apparentemente stava parodiando. Come quello di Tarantino il suo è un cinema al cubo, che vive di riferimenti di riferimenti, e della gioia di saperli rimettere in scena. Baby Driver è una variazione d'autore su un tema rigoroso: man mano che la storia va avanti i margini d'azione si restringono, certi snodi della trama sono quasi tappe obbligate e Wright non fa nulla per occultarcele, anzi è come se le sottolineasse (continua su +eventi!)
La svolta probabilmente è una strana scena in un parcheggio, dove un personaggio che non rivedremo più fa un lungo e discorso sulla carne di maiale, che non ha altro senso che farti pensare a certe vecchie messe in scena di Guy Ritchie - forse è una parodia, forse un omaggio (c'è differenza?) È il momento in cui Jamie Foxx, fino a quel momento quasi un cameo, prende in mano il film e apparentemente lo deraglia. Da lì in poi qualcosa si inceppa, ma non è forse quello che succede in tutti i film sulle rapine? C'è un piano perfetto e a un certo punto qualcosa che va storto. Anche Baby, che nella prima mezz'ora sembrava infallibile, di lì a poco non riuscirà più a far partire una macchina. Ci sarà ancora molta azione, e le canzoni continueranno a ritmarla, ma la freschezza iniziale è andata persa e non poteva che finire così. Baby Driver non è un film sulla perdita dell'innocenza - il personaggio di Ansel Elgort rimane immacolato anche quando si macchia di sangue - ma su un altro sintomo della crescita: la fine del senso di onnipotenza. Il musical si interrompe, le macchine non seguono più il groove, tutto crolla e chi ha deciso di seguirti, o in un momento di debolezza, di coprirti, forse ha commesso il suo più grande errore.
Baby Driver ha una trama molto semplice, portata avanti da personaggi la cui biografia si potrebbe scrivere su un tovagliolo. Questo lo aggiungo per chi nei giorni scorsi si è lamentato, per esempio, della scarsa profondità dei personaggi di Dunkirk - allora, forse è meglio rammentare che al cinema le storie durano in media due ore, nelle quali l'approfondimento dei personaggi non è sempre la priorità. Se davvero è quel che vi interessa, forse è meglio se restate a casa e vi leggete un libro - oppure vi sparate una stagione di una serie in venti puntate dove di sicuro ci sarà tanto spazio per approfondire i personaggi, sviscerarli, ribaltarli e ricomporli a piacere - viene il sospetto che chi trova il cinema superficiale, oggi, si stia aspettando qualcosa che al cinema più di tanto non si può trovare. E che da parte sua lo stesso cinema di intrattenimento stia prendendo un'altra direzione - che poi è una banale strategia di sopravvivenza: visto che non si può rivaleggiare con la serialità, si tende all'estremo opposto: alla rapidità, alla stilizzazione. Baby Driver e Dunkirk sono due film diversissimi, ma accomunati dalla volontà esibita di essere oggetti cinematografici. In entrambi i casi la colonna sonora è fondamentale. Nel caso di Baby Driver, Wright mette a frutto la vecchia lezione di Tarantino: se c'è una cosa che piace agli spettatori in sala, è scoprire o riscoprire qualche vecchia canzone. Perché è vero che c'è gente che balla ai semafori: ma anche in sala, quando si spengono le luci. Baby Driver è al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (20:10, 22:40); ai Portici di Fossano (21:15); al Cinemà di Savigliano (20:20, 22:30).
C'è gente che balla là in strada. Lo fanno di nascosto, non li riconosci - se non dalle cuffiette, e da come tamburellano sul volante al semaforo. Non lo fanno per esprimersi o per esporsi o per piacere a sé stessi: lo fanno e basta, sono nati così, non smetteranno finché gli batte un cuore. Non sono più allegri di te, tutt'altro: c'è chi ha un fischio nella testa, o un dolore che non passa, o un grido che gli urla in testa, una canzone da dimenticare suonandoci sopra migliaia di altre canzoni. C'è gente che balla al volante, e non sono gli autisti peggiori.
Certi film partono talmente forte che è già tanto se non vanno a sbattere. Se dopo un po' sbandano, se forano una gomma e arrivano ai titoli di coda un po' ammaccati, è comunque un piazzamento. Baby Driver parte mollando il freno a mano e sgommando in quinta: infila una delle strade più trafficate di Hollywood (il canovaccio sull'autista delle rapine) ma trovandosi una corsia tutta personale (stavolta l'autista vive in simbiosi con le sue cuffiette, in un mondo tutto suo che va a tempo con la sua playlist). Almeno per mezz'ora gira tutto che è un piacere, con certe controsterzate che strappano l'applauso. Poi comincia a perdere colpi, ma appunto: era previsto. Al punto che viene quasi il dubbio che l'effetto sia voluto, o quanto meno calcolato: che da un certo momento in poi il film stia mettendo in scena proprio la difficoltà di mantenere le attese.
Già ai tempi di Hot Fuzz era abbastanza chiaro quanto Edgar Wright fosse affezionato a quei luoghi comuni del cinema d'azione che apparentemente stava parodiando. Come quello di Tarantino il suo è un cinema al cubo, che vive di riferimenti di riferimenti, e della gioia di saperli rimettere in scena. Baby Driver è una variazione d'autore su un tema rigoroso: man mano che la storia va avanti i margini d'azione si restringono, certi snodi della trama sono quasi tappe obbligate e Wright non fa nulla per occultarcele, anzi è come se le sottolineasse (continua su +eventi!)
La svolta probabilmente è una strana scena in un parcheggio, dove un personaggio che non rivedremo più fa un lungo e discorso sulla carne di maiale, che non ha altro senso che farti pensare a certe vecchie messe in scena di Guy Ritchie - forse è una parodia, forse un omaggio (c'è differenza?) È il momento in cui Jamie Foxx, fino a quel momento quasi un cameo, prende in mano il film e apparentemente lo deraglia. Da lì in poi qualcosa si inceppa, ma non è forse quello che succede in tutti i film sulle rapine? C'è un piano perfetto e a un certo punto qualcosa che va storto. Anche Baby, che nella prima mezz'ora sembrava infallibile, di lì a poco non riuscirà più a far partire una macchina. Ci sarà ancora molta azione, e le canzoni continueranno a ritmarla, ma la freschezza iniziale è andata persa e non poteva che finire così. Baby Driver non è un film sulla perdita dell'innocenza - il personaggio di Ansel Elgort rimane immacolato anche quando si macchia di sangue - ma su un altro sintomo della crescita: la fine del senso di onnipotenza. Il musical si interrompe, le macchine non seguono più il groove, tutto crolla e chi ha deciso di seguirti, o in un momento di debolezza, di coprirti, forse ha commesso il suo più grande errore.
Baby Driver ha una trama molto semplice, portata avanti da personaggi la cui biografia si potrebbe scrivere su un tovagliolo. Questo lo aggiungo per chi nei giorni scorsi si è lamentato, per esempio, della scarsa profondità dei personaggi di Dunkirk - allora, forse è meglio rammentare che al cinema le storie durano in media due ore, nelle quali l'approfondimento dei personaggi non è sempre la priorità. Se davvero è quel che vi interessa, forse è meglio se restate a casa e vi leggete un libro - oppure vi sparate una stagione di una serie in venti puntate dove di sicuro ci sarà tanto spazio per approfondire i personaggi, sviscerarli, ribaltarli e ricomporli a piacere - viene il sospetto che chi trova il cinema superficiale, oggi, si stia aspettando qualcosa che al cinema più di tanto non si può trovare. E che da parte sua lo stesso cinema di intrattenimento stia prendendo un'altra direzione - che poi è una banale strategia di sopravvivenza: visto che non si può rivaleggiare con la serialità, si tende all'estremo opposto: alla rapidità, alla stilizzazione. Baby Driver e Dunkirk sono due film diversissimi, ma accomunati dalla volontà esibita di essere oggetti cinematografici. In entrambi i casi la colonna sonora è fondamentale. Nel caso di Baby Driver, Wright mette a frutto la vecchia lezione di Tarantino: se c'è una cosa che piace agli spettatori in sala, è scoprire o riscoprire qualche vecchia canzone. Perché è vero che c'è gente che balla ai semafori: ma anche in sala, quando si spengono le luci. Baby Driver è al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (20:10, 22:40); ai Portici di Fossano (21:15); al Cinemà di Savigliano (20:20, 22:30).
Comments (1)
Giù al tappeto negli anni Ottanta
09-09-2017, 03:04Bob Dylan, cinema, concerti, fb2020, musica, OttantaPermalink
Knocked Out Loaded (1986)
 |
| Il film andò male ai botteghini, secondo gli esperti anche a causa dei baffi di Gregory Peck. "I tuoi baffi ci sono costati milioni", gli avrebbe detto un produttore. |
Mi è venuta in mente questa cosa mentre ridavo un'occhiata a uno dei documenti più penosi che un dylanita possa reperire su Youtube - qualcuno avrà già indovinato. Mettiamola così: qual è l'evento più glorioso nella storia del rock degli anni Ottanta, quello che segna uno spartiacque che è ancora visibile da qui, oggi? Senza dubbio il Live Aid, proprio nel bel mezzo del decennio: estate 1985. È la fine ufficiale del cinismo punk e post-punk; l'apparizione abbastanza improvvisa di una nuova sensibilità più filantropica che politica. I nuovi eroi da palcoscenico non vogliono soltanto vendere dischi ed essere adorati dal pubblico pagante: vogliono essere buoni. Salvare il mondo. Proprio lo sporco mondo che fino a qualche anno fa andava bruciato, improvvisamente nel 1985 diventa cosa sacra e degna di essere salvata. Bob Geldof è il profeta, Bono il Messia, Freddy Mercury il ladrone pentito eccetera eccetera. Ma chi è che fino all'ultimo momento cercò di rovinare la festa? Senza cattiveria, ma con l'intuitiva ostinazione di chi sembra essere nato per mettere a disagio la gente alle cerimonie? Un aiutino: in fondo alla scaletta, nel set di Philadelphia, c'era il grande Bob Dylan.
Anche se forse non se ne rendeva conto. Non era il solo: il ive Aid esplose in maniera abbastanza imprevista. Fino a pochi giorni prima ne parlavano soltanto gli addetti ai lavori e il giorno dopo sui quotidiani era diventato lo show del secolo. Dylan arrivò sul set senza una band, con una vaghissima idea di cosa fosse stato organizzato e perché, in uno dei periodi più confusi della sua carriera; ma invece di fare la cosa più semplice (portarsi una chitarra, un'armonica, suonare la fottuta Blowing in the Wind e buonanotte - magari con Peter, Paul e Mary che si erano riuniti per l'occasione) decise di accollarsi Keith Richards e Ron Wood, in un momento in cui i Rolling Stones sembravano separati in casa: Mick Jagger aveva appena duettato con Tina Turner sullo stesso palco. L'approccio è quello di tre amici che dopo l'ammazzacaffè si fanno prestare le chitarre e strimpellano la prima cosa che gli viene in mente. Il problema è che i tre amici sono Bob-Coscienza-della-Sua-Generazione e i due chitarristi della band più famosa del mondo: a presentarli c'è Jack Nicholson e a guardarli strimpellare il mondo intero. Insomma forse presero la cosa un po' sottogamba. A causa del peso dei loro nomi erano stati inseriti in scaletta verso la fine: non solo il pubblico era esausto, ma dietro le quinte c'era già chi brindava e festeggiava (oppure il coro di USA For Africa che stava facendo le prove: ognuno la racconta diversa e ritiene che gli ubriachi fossero gli altri). Wood e Richards sono abituati a capirsi al volo, ma dovrebbero prima capire cosa vuol fare Dylan, che sta in mezzo, non riesce a sentirsi in spia e rompe addirittura una corda - al che Wood gli presta la sua chitarra e in attesa del rimpiazzo resta sul palco a gesticolare come un ragazzino. Dietro c'è un gran baccano. Blowing in the Wind stavolta è veramente fottuta, chitarre scordate, uno strazio.
 |
| Gregory Peck, negli anni di KO Loaded, faceva Lincoln nella serie TV "Il buio e il grigio" (e com'è ovvio ricordava terribilmente il capitano Achab). |
Dicevo che in quel film Gregory Peck fa il pistolero che non ne può più - attraversa il deserto perché dall'altra parte c'è una donna che amava, addirittura un figlio che non ha mai visto. Tutto quello che vorrebbe è sistemarsi in qualche fattoria. Ma i ragazzini, i ragazzini non lo lasciano in pace. Lo sfidano, si fanno ammazzare, e a quel punto naturalmente salta fuori qualche altro ragazzino che deve vendicare l'amico, il fratello, il cognato: non finisce mai.
La breve apparizione di Dylan al Live Aid si potrebbe anche liquidare così: credeva di essere a una festicciola, si fidava di amici in realtà confusi quasi quanto lui, nessuno gli aveva spiegato che era la vedette finale di un Grande Evento Storico. Insomma un equivoco spiacevole. E però la scaletta suggerisce che non fosse del tutto inconsapevole. Come al solito la cambiò fino all'ultimo momento. Ron Wood racconta che mentre saliva sul palcoscenico lo mandò nel panico proponendo all'improvviso di intonare All I Really Want to Do: una filastrocca che forse i due Stones si erano dimenticati, ma che per Dylan vent'anni prima aveva rappresentato il primo dei tanti disimpegni: quello dal movimento politico. Al Live Aid alla fine Dylan non cantò "voglio solo essere vostro amico", ma la storia di Hollis Brown, il contadino del Midwest che stermina la famiglia e si suicida per la fame. Una scelta non banale e apparentemente appropriata a una sera in cui si raccoglievano fondi per l'Etiopia, senonché al termine Dylan buttò lì che magari un paio di milioni dell'incasso si sarebbero potuti stornare "per pagare l'ipoteca su alcune fattorie che i contadini di qui devono alle banche". Tirava aria di crisi anche nel Midwest rurale: il pubblico della mondovisione magari non ci aveva fatto caso, Dylan sì. Qualche mese dopo Neil Young organizzò addirittura un Farm Aid, che molti considerano direttamente ispirato dalle parole di Dylan: quest'ultimo in quell'occasione si preparò per bene con gli Heartbreakers e fece uno show di ottimo livello. Invece, nella sera in cui si teneva a battesimo il Rock Buono, Dylan arrivò ubriaco come una vecchia rockstar (con una scorta di vecchie rockstar altrettanto ubriache); non urlò "America First!" ma ci andò vicino, e prima di massacrare Blowin' in the Wind inflisse ai due Stones e al pubblico un altro brano del passato remoto, When the Ship Comes In - vi ricordate in quale altra occasione, a dispetto di ogni ragionevolezza, aveva cercato di rovinare una festa con la stessa canzone? La marcia di Washington, esatto. E ora non c'era più Joan Baez a metterci una pezza, ma Ron Wood a fare air guitar. Magari è solo una coincidenza. Ma dopo Washington l'aveva cantata dal vivo soltanto altre due volte; non la tentava da vent'anni e dopo il Live Aid l'avrebbe accantonata per sempre. È un pezzo antipatizzante, che dice che la Salvezza arriva all'improvviso e non fa prigionieri: non è un pranzo di gala né un concertone benefico. Chi ne è degno sarà salvato, gli altri affogheranno. Amen.
E così Gregory Peck attraversava il deserto e arrivava in questa città di compensato - sai quelle cittadine western montate negli studios - e ovviamente la sua vecchia fiamma non voleva parlargli, e il figlio non sapeva chi fosse: e qualcuno aveva un conto in sospeso, o voleva soltanto farsi un nome. Ma forse sarebbe meglio che cominciassi a parlare di Knocked Out Loaded, il disco che Dylan pubblicò un anno dopo il Live Aid, ma che aveva già iniziato a registrare un anno prima, sempre un po' qua e un po' là senza un'idea chiara. Ai tempi pensavo che "knocked out loaded" significasse "carico di knocked out", come un pugile pronto a mandare al tappeto l'avversario: insomma un bel titolo combattivo, ecco un disco che se non state attenti vi prende a pugni! Invece significa l'esatto contrario: allude a un KO ricevuto, si può tradurre "suonato", "al tappeto". Forse non avevo mai fatto caso che verso la fine Dylan canta proprio "I was knocked out and loaded in the naked night". È che forse non ci ero mai arrivato, verso la fine. E dire che è un disco abbastanza breve. È il suo miglior pregio. Stiamo del resto parlando di un disco costruito attorno agli scarti di Empire Burlesque, le canzoni che non era riuscito a terminare in tempo per la scadenza del 1985, integrate con altri esperimenti per lo più infruttuosi del 1986. Siamo insomma al raschio del barile: qualcosa di buono ancora vien su, ma che fatica.
E infatti Gregory Peck, quando alla fine riesce a parlare alla sua ex, cala la maschera e le dice che ha finito con le pistole e i duelli e tutto quanto, e che vuole soltanto sistemarsi. Lei ovviamente è un po' scettica; magari non è la prima volta che lo sente dire: poi nemmeno nei vecchi western in bianco e nero funzionava così, che se dopo dieci anni il pistolero fa un fischio, l'ex ragazza madre è già pronta a perdonargli tutto. Lui se ne rende perfettamente conto, e chiede un anno di tempo. Se tra un anno tornassi, e avessi rigato dritto tutto il tempo, tu me la daresti una possibilità? Capisco che non puoi darmela adesso, e nemmeno promettermela, ma prometti almeno che ci penserai? Messa in questi termini è una proposta che si può dignitosamente accettare - specie se te la propone un pur baffuto Gregory Peck...
Un altro relativo pregio di KO Loaded è la disarmante sincerità. Infidels e Empire erano due dischi carichi di ambizioni, in parte giustificate in parte no. C'erano tentativi di suonare professionale, di suonare sofisticato, di suonare moderno. KO suona soltanto... suonato. È il disco di un tizio che di mestiere vende dischi e fa concerti, e prima di cominciare la stagione dei concerti deve fare uscire un disco: che sia ispirato o no. Voi andate tutti i giorni al lavoro ispirati? Dylan nel 1985/86 quasi mai. Il che non significa che non ci andasse: se uno mette in fila tutte le collaborazioni e le incisioni del periodo scopre che non stava fermo un attimo. Gli USA For Africa, il Live Aid, il Farm Aid, gli Artists United Against Apartheid fondati da "Little" Steven Van Zandt e prodotti da Arthur Baker (Dylan per la verità canta soltanto due versi, ma è stato carino da parte sua partecipare. C'era Miles Davis, i Run DMC, e nel disco c'era anche il primo vero pezzo blues degli U2, Silver and Gold, ma cantato da Bono con due amici d'eccezione tirati a lucido: Keith Richards e Ron Wood!) E poi sessioni con Dave Stewart degli Eurythmics, sessioni con gli Heartbreakers, con Al Kooper e T-Bone Burnett, sessioni con chiunque. A Cameron Crowe che lo intervistava per il libretto di Biograph aveva rivelato, con un certo sprezzo del pericolo, che stava accarezzando l'idea di pubblicare un disco di cover. È un'idea che lo aveva già portato al disastro nel 1970, ma forse chissà, col tempo aveva imparato a concentrarsi anche nel compito di interprete da studio, no?
No (continua sul Post).
A Dunkerque il cinema resiste
06-09-2017, 12:50cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, fb2020, guerra, memoria del 900PermalinkDunkirk (Christopher Nolan, 2017)
Hai mai visto una spiaggia della Manica, quando il mare è così basso che sembra un deserto? Hai visto la schiuma strisciare spinta dal vento? Hai sentito l'urlo degli Stuka, il gemito di chi sta affogando nella stiva di una nave che cola a picco? Hai guardato il cielo e chiuso gli occhi, pensando che stavolta toccava a te? Sai quanto poco dista Dover da Dunkerque, una ritirata da una vittoria, un eroe che lotta per resistere da un vigliacco che ha paura di morire, un congegno meccanico di precisione da un capolavoro? Adesso che sai tutte queste cose, perché le hai viste e le hai sentite in un sogno di una settimana, di un giorno, di novanta minuti - torna pure a casa e scrivi che Dunkirk in fondo non è quel gran film che tutti dicono: che non c'è storia e non ci sono personaggi: solo gelidi meccanismi di attesa che scattano senza pietà per intrappolare gli spettatori. Che Nolan, per carità, regista sublime: ma noi volevamo vedere la Seconda Guerra Mondiale, i tedeschi cattivi, gli inglesi flemmatici, i francesi disperati - e lui anche stavolta è come se si mettesse davanti coi suoi trucchi, con le sue musiche a effetto, coi suoi orologi da sincronizzare. Che tanta tecnica può lasciare freddi, tanta lucidità può dare la vertigine: e che la Dunkerque del tuo cuore alla fine resta ancora quella del lungo piano sequenza di Espiazione.
Ogni sconfitta può sembrare una vittoria, se la inquadri nel modo giusto. Il desiderio condiviso, e comprensibile, di salutare in Dunkirk il film dell'anno, è il rovescio di una constatazione amara: non è che ci siano tutti questi capolavori in giro per le sale ultimamente... (continua su +eventi!) Sia Hollywood che il cinema d'autore europeo sembrano navigare a vista, mentre le corazzate della serialità televisiva dilagano nel bacino dei giovani spettatori (quelli che se non si fanno una sensibilità cinematografica adesso, tra cinque anni in sala non verranno più: o al massimo per vedere la maxipuntata di un prodotto seriale come un cinecomic). Dunkirk è, tra le altre cose, un disperato manifesto di vitalità del cinema: non tanto per il feticismo della pellicola 70mm, ma per la sintassi così orgogliosamente antitelevisiva. In questo ricorda un film apparentemente diversissimo, Gravity: si tratta di due film brevi, senza tempi morti, che chiedono allo spettatore una specie di apnea: fai un bel respiro e ci risentiamo tra un'ora e mezza. Nolan ci promette lacrime, sudore e sangue (in realtà pochissimo), ma ci dice che la tv non è invincibile, che il cinema resisterà, perché c'è qualcosa che soltanto il cinema può fare.
E però il cinema non è solo Nolan: non sei obbligato a condividere le sue ossessioni; ti è concesso restare diffidente nei confronti di un orologiaio che concepisce ogni film come un meccanismo di precisione. Non tutti vengono perfetti: quando oscillano un po' sbilenchi puoi criticarne i difetti più evidenti, irridere le ambizioni eccessive del progettista. Altre volte sembrano girare a meraviglia, al punto che hai la sensazione che non si fermeranno mai. In questo caso puoi sempre obiettare che non c'è niente di così profondo in un meccanismo che funziona; è vero, c'è un momento vero la fine del film in cui l'ansia per la sorte dei personaggi cede il posto a una strana soddisfazione pre-intellettuale, il sollievo di chi vede un puzzle completarsi tessera dopo tessera, il piacere che si prova a unire i puntini e scoprire il senso del disegno. Non è esattamente quel tipo di sensazione che ci si aspetta di provare mentre l'Inghilterra lotta per la libertà del mondo, ma è qualcosa che rende i film di Nolan diversi da tutti gli altri, e non è poco. Nel momento in cui tutti sembrano considerarci spugne emozionali, da imbevere e strizzare a piacere, lui almeno lavora su stimoli diversi. Alla fine ci strizza anche lui, ma qualcosa rimane. Su quella spiaggia, ci siamo stati. Per una settimana, per un giorno, per un'ora. Abbiamo visto la marea riportare i compagni a riva, abbiamo provato a saltare la fila, abbiamo creduto di potercela fare remando fino a Dover: abbiamo deciso che non entreremo mai più in una camera stagna. E intanto, dall'altra parte, ci siamo chiesti fino a che punto potevamo spingerci senza spia nel serbatoio e senza un sonar per gli U-Boot; il punto in cui il coraggio sarebbe diventato irresponsabilità e follia. Magari Nolan non è tutto il cinema, ma il cinema ha parecchio bisogno di lui. Al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (20:20, 21:30, 22:40); Fiamma di Cuneo (21:00); ai Portici di Fossano (21:15), al Cinemà di Savigliano (20:20, 22:30).
 |
| Bon voyage. |
 |
| Nell'ultimo momento c'è chi si tappa le orecchie e chi prende la mira. |
Ogni sconfitta può sembrare una vittoria, se la inquadri nel modo giusto. Il desiderio condiviso, e comprensibile, di salutare in Dunkirk il film dell'anno, è il rovescio di una constatazione amara: non è che ci siano tutti questi capolavori in giro per le sale ultimamente... (continua su +eventi!) Sia Hollywood che il cinema d'autore europeo sembrano navigare a vista, mentre le corazzate della serialità televisiva dilagano nel bacino dei giovani spettatori (quelli che se non si fanno una sensibilità cinematografica adesso, tra cinque anni in sala non verranno più: o al massimo per vedere la maxipuntata di un prodotto seriale come un cinecomic). Dunkirk è, tra le altre cose, un disperato manifesto di vitalità del cinema: non tanto per il feticismo della pellicola 70mm, ma per la sintassi così orgogliosamente antitelevisiva. In questo ricorda un film apparentemente diversissimo, Gravity: si tratta di due film brevi, senza tempi morti, che chiedono allo spettatore una specie di apnea: fai un bel respiro e ci risentiamo tra un'ora e mezza. Nolan ci promette lacrime, sudore e sangue (in realtà pochissimo), ma ci dice che la tv non è invincibile, che il cinema resisterà, perché c'è qualcosa che soltanto il cinema può fare.
 |
| Sangue e nafta |
Comments (1)
Biografami questo
02-09-2017, 02:25Bob Dylan, musicaPermalinkBiograph (1985: cofanetto con materiale registrato dal 1962 al 1981).
Nel mezzo della notte ti sveglia una cattiva notizia. Qualcuno (al telefono?) ti sta dicendo che Percy, il tuo amico Percy, è in grossi guai. Novantanove anni di carcere! Anche se è notte fonda, scrivi al giudice che sarai al tribunale appena possibile. Il giorno dopo eccoti alla sbarra: cos'è successo? Un incidente, sulla statale, quattro morti, lui era al volante. Omicidio stradale. Va bene, ma novantanove anni? Percy, lo conosco meglio di me stesso, non farebbe male a una mosca! Ma ci sono i testimoni. Posso almeno ricorrere in appello? Troppo tardi. Se ne vada per favore, la seduta è tolta.
Di tante canzoni che ha scritto Dylan, la cosa più simile a un incubo l'ha registrata nel 1964. Si chiama Percy's Song e non è così strano che non l'abbia inclusa in The Times They Are A-changin'. Non solo per la durata - sette interminabili minuti. Che ci avrebbe fatto uno schizzo kafkiano in un album di canzoni d'amore e di protesta? Ma gli incubi invecchiano meglio dei proclami e dei madrigali - in effetti gli incubi non invecchiano, al limite si nascondono nelle fessure; e quando Dylan da qualche parte in un cassetto la ritrovò, Percy's Song era angosciosa e irrisolta come il primo giorno. Forse ai tempi di The Times gli sembrava la sua canzone più antica, più vicina al mistero delle antiche ballate irlandesi da cui mutua la melodia. Nel 1985, quando uscì su Biograph, era una mera curiosità che serviva a rendere più speziato il più grosso Greatest Hits mai pubblicato. A quel punto Percy era già uscita dai cassetti grazie ai Fairport Convention, che ne avevano stemperato l'angoscia con la melodia. Oggi Percy è una delle canzoni più rappresentative del catalogo dylaniano. Potrebbe averla registrata nel 1964, come nel 1994, come ieri. Gli incubi non invecchiano.
- Lay Lady Lay (1969) - Baby, Let Me Follow You Down (1962) - If Not for You (1970) - I'll Be Your Baby Tonight (1968) - I'll Keep It with Mine (1964). Il primo lato del primo disco potrebbe essere una storia d'amore. Lay Lady Lay è un modo molto cinematografico di cominciare, già sul materasso... poi con Baby Let Me Follow comincia il flashback.

In inglese, Biograph non vuol dire biografia - sì, anch'io c'ero cascato, e invece no. Per il dizionario Webster on line "biograph" è soltanto un verbo: "biografare". Io biografo, tu biografi, il tale è biografato. Ma all'inizio del Novecento c'era anche il sostantivo, ed era una specie di sinonimo per "cinematografo". L'American Mutoscope and Biograph Company, fondata nel 1895, realizzò più di 3000 corti e 15 lungometraggi, prima di fondersi con la concorrente Edison. È la compagnia nella quale si fece le ossa D.W. Griffith.
Se potessimo mettere il primo disco di Biograph sul piatto, ritroveremmo il Dylan del 1969, che mentre cerca di rendere credibile una svolta country, azzecca un'atmosfera inedita con un brano fatto di slide guitar, bongo e campanaccio. Da lì a poco siamo nel 1962, sui verdi pascoli dell'università di Harvard, Dylan si sta facendo insegnare da Eric Von Schmidt un nuovo giro di accordi. Siamo nel 1970, è passato a salutarlo George Harrison per confermargli che i Beatles si sono davvero sciolti per sempre e per lavorare insieme a una canzone. Siamo nel 1968, la polizia irrompe nelle università e spara agli studenti che non vogliono partire per il Vietnam, ma Dylan vuole soltanto cantare languido I'll Be Your Baby Tonight. Siamo nel 1964, Dylan incontra Nico e le regala I'll Keep It with Mine. Siamo in qualsiasi posto, in qualsiasi momento.
- Mixed-Up Confusion (1962) - Tombstone Blues (1965) - The Groom's Still Waiting at the Altar (1981) - Most Likely You Go Your Way (Live, 1974) - Like a Rolling Stone (1965) - Jet Pilot (1965). È decisamente un lato blues.
 Mixed-Up Confusion è in assoluto il primo singolo pubblicato da Dylan, nel dicembre del 1962, e a sorpresa è un rock'n'roll. Una specie. Un esperimento. Non funzionò e dopo poco la Columbia lo ritirò dal commercio - o forse non si diede la pena di commerciarlo troppo. Lo stesso Dylan ha ricordi molto vaghi di tutta la faccenda: un mattino gli telefonano di venire alla Columbia a incidere un singolo con una band. Lui non ha un pezzo pronto e lo scrive sul taxi. Il suo primo disco acustico aveva venduto qualche migliaio di copie, la Columbia non sapeva ancora esattamente cosa fare di lui. Si saranno detti: proviamo il rockabilly (per accorgersi, magari a master già incisi, che in effetti il tizio aveva difficoltà ad andare a tempo con la band). Jet Pilot nel 1985 aveva vent'anni esatti e doveva proprio sembrare un frammento estratto da un cassetto per tappare un buco. Una singola strofa di uno di quei rock-blues torrenziali che nel 1965 gli venivano facili come respirare: l'istantanea di un donnone che fa impazzire tutti i ragazzi del quartiere, tutti piloti da jet che la puntano come un cacciabombardiere - ma se potessero avvicinarsi un po' alla carlinga si accorgerebbero che "non è una donna, è un uomo"! Oggi è rilevante in quanto primo rock in assoluto su un travestito (in anticipo su Lola dei Kinks, che però ebbero il fegato di pubblicarla): veramente troppo poco per assegnare a Dylan una qualche sensibilità queer.
Mixed-Up Confusion è in assoluto il primo singolo pubblicato da Dylan, nel dicembre del 1962, e a sorpresa è un rock'n'roll. Una specie. Un esperimento. Non funzionò e dopo poco la Columbia lo ritirò dal commercio - o forse non si diede la pena di commerciarlo troppo. Lo stesso Dylan ha ricordi molto vaghi di tutta la faccenda: un mattino gli telefonano di venire alla Columbia a incidere un singolo con una band. Lui non ha un pezzo pronto e lo scrive sul taxi. Il suo primo disco acustico aveva venduto qualche migliaio di copie, la Columbia non sapeva ancora esattamente cosa fare di lui. Si saranno detti: proviamo il rockabilly (per accorgersi, magari a master già incisi, che in effetti il tizio aveva difficoltà ad andare a tempo con la band). Jet Pilot nel 1985 aveva vent'anni esatti e doveva proprio sembrare un frammento estratto da un cassetto per tappare un buco. Una singola strofa di uno di quei rock-blues torrenziali che nel 1965 gli venivano facili come respirare: l'istantanea di un donnone che fa impazzire tutti i ragazzi del quartiere, tutti piloti da jet che la puntano come un cacciabombardiere - ma se potessero avvicinarsi un po' alla carlinga si accorgerebbero che "non è una donna, è un uomo"! Oggi è rilevante in quanto primo rock in assoluto su un travestito (in anticipo su Lola dei Kinks, che però ebbero il fegato di pubblicarla): veramente troppo poco per assegnare a Dylan una qualche sensibilità queer.
- The Times They Are a-Changin' (1964) - Blowin' in the Wind (1963) - Masters of War (1963) - The Lonesome Death of Hattie Carroll (1964) - Percy's Song (1964). (Se almeno Biograph fosse un caos cronologico totale, uno si metterebbe il cuore in pace: avrà mescolato le canzoni come carte, ok. E invece ci sono intere sequenze che un senso ce l'hanno, ad esempio la seconda facciata del primo disco è tutta di grandi cavalli di battaglia acustici del '63-'64. Come quando la funzione shuffle di uno smartphone sembra volerti dire qualcosa).
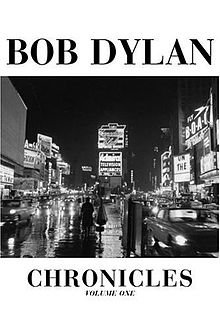 Ci sono vari modi di scrivere una biografia. Il più noioso è senz'altro partire dall'inizio, come David Copperfield: "Vengo al mondo", e proseguire nell'unica direzione consentita. Esistono numerose biografie di Dylan in commercio: cominciano tutte con lui che viene al mondo a Duluth, Minnesota. Anche questa cosa che sto scrivendo alla fine sembrerà una biografia, almeno dal disco più antico a quello appena uscito. E poi esiste l'autobiografia che Dylan ha iniziato a scrivere e che non completerà mai (tutte le autobiografie sono incomplete, se uno ci riflette). Si chiama Chronicles I e comincia con lui che arriva negli studi della Witmark nel 1961. Indugia un po' nei localini del Village finché a un certo punto volti la pagina ed è una rockstar in crisi d'identità, nel 1970: orripilato dalla scena del festival di Woodstock e spaventato dagli hippie che gli entrano in casa. Volti un'altra pagina e sei nel 1986, Dylan si è fatto male a una mano e considera la possibilità di non suonare mai più dal vivo, di non scrivere mai più una canzone. Un'altra pagina ed è di nuovo nei localini del Village. Che senso ha? Nessuno, Dylan semplicemente non è David Copperfield. Ha buttato giù le prime cose che gli venivano in mente finché non ha messo assieme abbastanza pagine. Proprio come quando incide i dischi, già. E non ha messo i capitoli in ordine: non lo ha mai fatto, nemmeno nei suoi Greatest Hits, uno più caotico dell'altro. Perché per Bob Dylan evidentemente il tempo non esiste.
Ci sono vari modi di scrivere una biografia. Il più noioso è senz'altro partire dall'inizio, come David Copperfield: "Vengo al mondo", e proseguire nell'unica direzione consentita. Esistono numerose biografie di Dylan in commercio: cominciano tutte con lui che viene al mondo a Duluth, Minnesota. Anche questa cosa che sto scrivendo alla fine sembrerà una biografia, almeno dal disco più antico a quello appena uscito. E poi esiste l'autobiografia che Dylan ha iniziato a scrivere e che non completerà mai (tutte le autobiografie sono incomplete, se uno ci riflette). Si chiama Chronicles I e comincia con lui che arriva negli studi della Witmark nel 1961. Indugia un po' nei localini del Village finché a un certo punto volti la pagina ed è una rockstar in crisi d'identità, nel 1970: orripilato dalla scena del festival di Woodstock e spaventato dagli hippie che gli entrano in casa. Volti un'altra pagina e sei nel 1986, Dylan si è fatto male a una mano e considera la possibilità di non suonare mai più dal vivo, di non scrivere mai più una canzone. Un'altra pagina ed è di nuovo nei localini del Village. Che senso ha? Nessuno, Dylan semplicemente non è David Copperfield. Ha buttato giù le prime cose che gli venivano in mente finché non ha messo assieme abbastanza pagine. Proprio come quando incide i dischi, già. E non ha messo i capitoli in ordine: non lo ha mai fatto, nemmeno nei suoi Greatest Hits, uno più caotico dell'altro. Perché per Bob Dylan evidentemente il tempo non esiste.
- Lay Down Your Weary Tune (1963) - Subterranean Homesick Blues (1964) - I Don't Believe You (1966) - Visions of Johanna (Live, 1966) - Every Grain of Sand (1981). (Per esempio: secondo me questa facciata non ha nessun senso. Oppure: L'Eden primigenio, la caduta negli inferi sotterranei, e la redenzione! Ma immagino che se pescassi cinque canzoni di Dylan a caso potrei individuare una storia anche più credibile).
Certe canzoni riescono a stupirti anche al millesimo ascolto (continua sul Post).
Di tante canzoni che ha scritto Dylan, la cosa più simile a un incubo l'ha registrata nel 1964. Si chiama Percy's Song e non è così strano che non l'abbia inclusa in The Times They Are A-changin'. Non solo per la durata - sette interminabili minuti. Che ci avrebbe fatto uno schizzo kafkiano in un album di canzoni d'amore e di protesta? Ma gli incubi invecchiano meglio dei proclami e dei madrigali - in effetti gli incubi non invecchiano, al limite si nascondono nelle fessure; e quando Dylan da qualche parte in un cassetto la ritrovò, Percy's Song era angosciosa e irrisolta come il primo giorno. Forse ai tempi di The Times gli sembrava la sua canzone più antica, più vicina al mistero delle antiche ballate irlandesi da cui mutua la melodia. Nel 1985, quando uscì su Biograph, era una mera curiosità che serviva a rendere più speziato il più grosso Greatest Hits mai pubblicato. A quel punto Percy era già uscita dai cassetti grazie ai Fairport Convention, che ne avevano stemperato l'angoscia con la melodia. Oggi Percy è una delle canzoni più rappresentative del catalogo dylaniano. Potrebbe averla registrata nel 1964, come nel 1994, come ieri. Gli incubi non invecchiano.
- Lay Lady Lay (1969) - Baby, Let Me Follow You Down (1962) - If Not for You (1970) - I'll Be Your Baby Tonight (1968) - I'll Keep It with Mine (1964). Il primo lato del primo disco potrebbe essere una storia d'amore. Lay Lady Lay è un modo molto cinematografico di cominciare, già sul materasso... poi con Baby Let Me Follow comincia il flashback.

In inglese, Biograph non vuol dire biografia - sì, anch'io c'ero cascato, e invece no. Per il dizionario Webster on line "biograph" è soltanto un verbo: "biografare". Io biografo, tu biografi, il tale è biografato. Ma all'inizio del Novecento c'era anche il sostantivo, ed era una specie di sinonimo per "cinematografo". L'American Mutoscope and Biograph Company, fondata nel 1895, realizzò più di 3000 corti e 15 lungometraggi, prima di fondersi con la concorrente Edison. È la compagnia nella quale si fece le ossa D.W. Griffith.
Se potessimo mettere il primo disco di Biograph sul piatto, ritroveremmo il Dylan del 1969, che mentre cerca di rendere credibile una svolta country, azzecca un'atmosfera inedita con un brano fatto di slide guitar, bongo e campanaccio. Da lì a poco siamo nel 1962, sui verdi pascoli dell'università di Harvard, Dylan si sta facendo insegnare da Eric Von Schmidt un nuovo giro di accordi. Siamo nel 1970, è passato a salutarlo George Harrison per confermargli che i Beatles si sono davvero sciolti per sempre e per lavorare insieme a una canzone. Siamo nel 1968, la polizia irrompe nelle università e spara agli studenti che non vogliono partire per il Vietnam, ma Dylan vuole soltanto cantare languido I'll Be Your Baby Tonight. Siamo nel 1964, Dylan incontra Nico e le regala I'll Keep It with Mine. Siamo in qualsiasi posto, in qualsiasi momento.
 Mixed-Up Confusion è in assoluto il primo singolo pubblicato da Dylan, nel dicembre del 1962, e a sorpresa è un rock'n'roll. Una specie. Un esperimento. Non funzionò e dopo poco la Columbia lo ritirò dal commercio - o forse non si diede la pena di commerciarlo troppo. Lo stesso Dylan ha ricordi molto vaghi di tutta la faccenda: un mattino gli telefonano di venire alla Columbia a incidere un singolo con una band. Lui non ha un pezzo pronto e lo scrive sul taxi. Il suo primo disco acustico aveva venduto qualche migliaio di copie, la Columbia non sapeva ancora esattamente cosa fare di lui. Si saranno detti: proviamo il rockabilly (per accorgersi, magari a master già incisi, che in effetti il tizio aveva difficoltà ad andare a tempo con la band). Jet Pilot nel 1985 aveva vent'anni esatti e doveva proprio sembrare un frammento estratto da un cassetto per tappare un buco. Una singola strofa di uno di quei rock-blues torrenziali che nel 1965 gli venivano facili come respirare: l'istantanea di un donnone che fa impazzire tutti i ragazzi del quartiere, tutti piloti da jet che la puntano come un cacciabombardiere - ma se potessero avvicinarsi un po' alla carlinga si accorgerebbero che "non è una donna, è un uomo"! Oggi è rilevante in quanto primo rock in assoluto su un travestito (in anticipo su Lola dei Kinks, che però ebbero il fegato di pubblicarla): veramente troppo poco per assegnare a Dylan una qualche sensibilità queer.
Mixed-Up Confusion è in assoluto il primo singolo pubblicato da Dylan, nel dicembre del 1962, e a sorpresa è un rock'n'roll. Una specie. Un esperimento. Non funzionò e dopo poco la Columbia lo ritirò dal commercio - o forse non si diede la pena di commerciarlo troppo. Lo stesso Dylan ha ricordi molto vaghi di tutta la faccenda: un mattino gli telefonano di venire alla Columbia a incidere un singolo con una band. Lui non ha un pezzo pronto e lo scrive sul taxi. Il suo primo disco acustico aveva venduto qualche migliaio di copie, la Columbia non sapeva ancora esattamente cosa fare di lui. Si saranno detti: proviamo il rockabilly (per accorgersi, magari a master già incisi, che in effetti il tizio aveva difficoltà ad andare a tempo con la band). Jet Pilot nel 1985 aveva vent'anni esatti e doveva proprio sembrare un frammento estratto da un cassetto per tappare un buco. Una singola strofa di uno di quei rock-blues torrenziali che nel 1965 gli venivano facili come respirare: l'istantanea di un donnone che fa impazzire tutti i ragazzi del quartiere, tutti piloti da jet che la puntano come un cacciabombardiere - ma se potessero avvicinarsi un po' alla carlinga si accorgerebbero che "non è una donna, è un uomo"! Oggi è rilevante in quanto primo rock in assoluto su un travestito (in anticipo su Lola dei Kinks, che però ebbero il fegato di pubblicarla): veramente troppo poco per assegnare a Dylan una qualche sensibilità queer.- The Times They Are a-Changin' (1964) - Blowin' in the Wind (1963) - Masters of War (1963) - The Lonesome Death of Hattie Carroll (1964) - Percy's Song (1964). (Se almeno Biograph fosse un caos cronologico totale, uno si metterebbe il cuore in pace: avrà mescolato le canzoni come carte, ok. E invece ci sono intere sequenze che un senso ce l'hanno, ad esempio la seconda facciata del primo disco è tutta di grandi cavalli di battaglia acustici del '63-'64. Come quando la funzione shuffle di uno smartphone sembra volerti dire qualcosa).
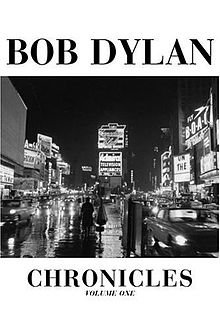 Ci sono vari modi di scrivere una biografia. Il più noioso è senz'altro partire dall'inizio, come David Copperfield: "Vengo al mondo", e proseguire nell'unica direzione consentita. Esistono numerose biografie di Dylan in commercio: cominciano tutte con lui che viene al mondo a Duluth, Minnesota. Anche questa cosa che sto scrivendo alla fine sembrerà una biografia, almeno dal disco più antico a quello appena uscito. E poi esiste l'autobiografia che Dylan ha iniziato a scrivere e che non completerà mai (tutte le autobiografie sono incomplete, se uno ci riflette). Si chiama Chronicles I e comincia con lui che arriva negli studi della Witmark nel 1961. Indugia un po' nei localini del Village finché a un certo punto volti la pagina ed è una rockstar in crisi d'identità, nel 1970: orripilato dalla scena del festival di Woodstock e spaventato dagli hippie che gli entrano in casa. Volti un'altra pagina e sei nel 1986, Dylan si è fatto male a una mano e considera la possibilità di non suonare mai più dal vivo, di non scrivere mai più una canzone. Un'altra pagina ed è di nuovo nei localini del Village. Che senso ha? Nessuno, Dylan semplicemente non è David Copperfield. Ha buttato giù le prime cose che gli venivano in mente finché non ha messo assieme abbastanza pagine. Proprio come quando incide i dischi, già. E non ha messo i capitoli in ordine: non lo ha mai fatto, nemmeno nei suoi Greatest Hits, uno più caotico dell'altro. Perché per Bob Dylan evidentemente il tempo non esiste.
Ci sono vari modi di scrivere una biografia. Il più noioso è senz'altro partire dall'inizio, come David Copperfield: "Vengo al mondo", e proseguire nell'unica direzione consentita. Esistono numerose biografie di Dylan in commercio: cominciano tutte con lui che viene al mondo a Duluth, Minnesota. Anche questa cosa che sto scrivendo alla fine sembrerà una biografia, almeno dal disco più antico a quello appena uscito. E poi esiste l'autobiografia che Dylan ha iniziato a scrivere e che non completerà mai (tutte le autobiografie sono incomplete, se uno ci riflette). Si chiama Chronicles I e comincia con lui che arriva negli studi della Witmark nel 1961. Indugia un po' nei localini del Village finché a un certo punto volti la pagina ed è una rockstar in crisi d'identità, nel 1970: orripilato dalla scena del festival di Woodstock e spaventato dagli hippie che gli entrano in casa. Volti un'altra pagina e sei nel 1986, Dylan si è fatto male a una mano e considera la possibilità di non suonare mai più dal vivo, di non scrivere mai più una canzone. Un'altra pagina ed è di nuovo nei localini del Village. Che senso ha? Nessuno, Dylan semplicemente non è David Copperfield. Ha buttato giù le prime cose che gli venivano in mente finché non ha messo assieme abbastanza pagine. Proprio come quando incide i dischi, già. E non ha messo i capitoli in ordine: non lo ha mai fatto, nemmeno nei suoi Greatest Hits, uno più caotico dell'altro. Perché per Bob Dylan evidentemente il tempo non esiste.- Lay Down Your Weary Tune (1963) - Subterranean Homesick Blues (1964) - I Don't Believe You (1966) - Visions of Johanna (Live, 1966) - Every Grain of Sand (1981). (Per esempio: secondo me questa facciata non ha nessun senso. Oppure: L'Eden primigenio, la caduta negli inferi sotterranei, e la redenzione! Ma immagino che se pescassi cinque canzoni di Dylan a caso potrei individuare una storia anche più credibile).
Certe canzoni riescono a stupirti anche al millesimo ascolto (continua sul Post).
Fa un po' male, ma poi (il razzismo)
30-08-2017, 16:18dialoghi, migranti, razzismiPermalink"Ma hai sentito la storia del mediatore culturale?"
"Come facevo a non sentirla? Sei colonne su Libero".
"Ma come si fa a scrivere una cosa del genere?"
"Nel giorno in cui un missile nordcoreano ha attraversato lo spazio aereo giapponese".
"È un atto peggio ma solo all'inizio, dio mio".
"E poi mezzo Texas sott'acqua, il vertice europeo sui migranti..."
"Ma come si fa a credere a una cosa del genere".
"Eppure Libero aveva in prima pagina soltanto la stronzata di un mediatore culturale - in pratica il dipendente di una cooperativa - definito "capo musulmano"".
"Cioè secondo te la notizia è che Libero ci faccia un titolo?"
"Non un titolo. Il titolo di apertura. A tutta pagina. Per la scemenza di un tizio su facebook. Che diventa miracolosamente la tesi di un capo musulmano".
"Non è una semplice scemenza. Era una stronzata orribile, maschilista, portatrice di una visione arcaica..."
"Più che arcaica forse consolatoria".
"Consolatoria?"
"L'idea che una donna non soffra durante lo stupro. Sembra un'autocensura. Non posso credere che qualcuno soffra per così tanto tempo, e così decido che non è vero, che non sta soffrendo. Più che da una cultura arcaica, credo che sia il risultato di uno choc culturale. Un maschilista puro perché dovrebbe preoccuparsi se la donna soffre o no?"
"Ti stai infilando in una fessura pericolosissima, te lo dico".
"Ma no, è che quando incontro una nozione falsa, mi chiedo sempre da dove salta fuori. Oggi si tende a pensare che le fake news servano a mandare avanti un'agenda politica, o semplicemente ad attirare attenzione e clic. Ma le nozioni false le abbiamo sempre avute, prima della politica e prima dei clic. La maggior parte serviva a proteggerci".
"A proteggerci?"
"Dov'è il nonno? È andato in cielo".
"Serviva a proteggerci?"
"Magari non funzionava, ma non te la raccontavano per altri motivi. Fa molto male? No, solo all'inizio, poi passa".
"Stai cercando di giustificare..."
"Sto cercando di capire".
"Non è che puoi passare la vita a cercare di capire gli ignoranti".
"Ma è proprio quello che dovremmo..."
"No. Non funziona così. Anche perché gli ignoranti sono troppi. Non ce la faremmo mai. Devono essere loro a fare un passo avanti".
"Ma che significa, non è mica un match noi contro loro. Siamo tutti ignoranti di qualcosa. Usiamo tutti qualche falsa nozione per proteggerci".
"Fammi un esempio".
"Ogni agosto, hai notato che a ogni fine di agosto esce una notizia ambientata sulla spiaggia che riassume il nostro approccio stagionale al problema dei migranti? Due anni fa, la foto di quel bambino siriano annegato sul bagnasciuga".
"Non era una falsa nozione".
"Era una foto tra tante, riassumeva un problema generale e complesso, simboleggiò una specie di svolta: la Merkel cambiò atteggiamento, tutti cambiarono atteggiamento - molti perlomeno - per un po' prevalse la linea dell'accoglienza. L'anno scorso, sempre su una spiaggia, il ladro di bambini".
"Me l'ero dimenticato".
"Anche quella volta, paginone di Libero. Tutto rapidamente sgonfiatosi, non c'era stato nessun tentato furto di nessun bambino. Ma riassumeva l'aria che stava tirando. Quest'anno il capo musulmano che insegna su facebook la meccanica dello stupro".
"Riassume la situazione?"
"Serve a difenderci".
"Ma cosa stai dicendo?"
"Vuoi la notizia vera? Quella che non ha dato Libero, e che anche i giornali rispettabili sono un po' restii a comunicare? Per risolvere la cosiddetta emergenza immigrazione, in due mesi abbiamo probabilmente lasciato annegare trentamila persone".
"Forse un po' meno..."
"Non è stato difficile: abbiamo lasciato che la libera informazione criminalizzasse le ONG, e poi le abbiamo fatte sostituire da una banda di pirati che abbiamo deciso di chiamare guardia costiera libica".
"Lo so".
"Nel frattempo abbiamo preso accordi col capotribù che almeno a Tripoli ha preso il posto di Gheddafi, e che istituirà campi di concentramento disumani quanto quelli di Gheddafi. Anche se la Libia continua a essere un po' instabile e quindi, in concerto con l'Unione Europe che plaude al nostro spirito di iniziativa, stiamo pianificando di finanziare campi di concentramento più a monte, nel Sahel".
"So anche questo, ma..."
"In questo modo magari l'estate prossima i trentamila morti moriranno così tanto lontano, o lungo una una filiera talmente sviluppata e complessa, che non ce ne accorgeremo neppure, il che ci farà sentire meno assassini e forse farà vincere le elezioni contro i razzisti ignoranti, noi razzisti consapevoli e pianificatori".
"Senti, ho capito, mi rendo conto che è terribile, ma non andrà così".
"No?"
"Capisco che in questo momento tu possa sentirti..."
"Un po' assassino?"
"Diciamo che siamo tutti colpevoli... di una situazione orribile che..."
"Che si poteva evitare".
"Però non puoi esagerare. Non serve a niente esagerare".
"Sto esagerando?"
"Trentamila morti ogni estate, per esempio. Non è vero".
"È una stima".
"È solo la sottrazione tra gli sbarcati dell'anno scorso e quelli di quest'anno. E può darsi che davvero l'unica causa della differenza, quest'anno, sia che sono annegati. Non c'erano più navi disposte a soccorrerli, e li abbiamo lasciati annegare".
"Abbiamo fatto sì che fossero lasciati annegare".
"È successo. Ma l'anno prossimo non saranno di nuovo trentamila".
"Perché no?"
"Ma è una questione di buonsenso, insomma... quelli che partivano quest'anno, pensavano che sarebbe stato facile come l'anno scorso. Ma l'anno prossimo... ora che lo sanno... partiranno in meno".
"Cioè la strage sarà servita da deterrente".
"Purtroppo sì".
"Ma come fai a saperlo?"
"È buonsenso".
"O forse è un istinto autoprotettivo".
"Cosa?"
"Mi stai dicendo che dopo un po' smette di fare male".
"Non capisco".
"Il massacro. All'inizio fa male, ma dopo la gente si abitua e alla fine magari gode anche un po'".
"Facciamo che non ti sento".
"Come facevo a non sentirla? Sei colonne su Libero".
"Ma come si fa a scrivere una cosa del genere?"
"Nel giorno in cui un missile nordcoreano ha attraversato lo spazio aereo giapponese".
"È un atto peggio ma solo all'inizio, dio mio".
"E poi mezzo Texas sott'acqua, il vertice europeo sui migranti..."
"Ma come si fa a credere a una cosa del genere".
"Eppure Libero aveva in prima pagina soltanto la stronzata di un mediatore culturale - in pratica il dipendente di una cooperativa - definito "capo musulmano"".
"Cioè secondo te la notizia è che Libero ci faccia un titolo?"
"Non un titolo. Il titolo di apertura. A tutta pagina. Per la scemenza di un tizio su facebook. Che diventa miracolosamente la tesi di un capo musulmano".
"Non è una semplice scemenza. Era una stronzata orribile, maschilista, portatrice di una visione arcaica..."
"Più che arcaica forse consolatoria".
"Consolatoria?"
"L'idea che una donna non soffra durante lo stupro. Sembra un'autocensura. Non posso credere che qualcuno soffra per così tanto tempo, e così decido che non è vero, che non sta soffrendo. Più che da una cultura arcaica, credo che sia il risultato di uno choc culturale. Un maschilista puro perché dovrebbe preoccuparsi se la donna soffre o no?"
"Ti stai infilando in una fessura pericolosissima, te lo dico".
"Ma no, è che quando incontro una nozione falsa, mi chiedo sempre da dove salta fuori. Oggi si tende a pensare che le fake news servano a mandare avanti un'agenda politica, o semplicemente ad attirare attenzione e clic. Ma le nozioni false le abbiamo sempre avute, prima della politica e prima dei clic. La maggior parte serviva a proteggerci".
"A proteggerci?"
"Dov'è il nonno? È andato in cielo".
"Serviva a proteggerci?"
"Magari non funzionava, ma non te la raccontavano per altri motivi. Fa molto male? No, solo all'inizio, poi passa".
"Stai cercando di giustificare..."
"Sto cercando di capire".
"Non è che puoi passare la vita a cercare di capire gli ignoranti".
"Ma è proprio quello che dovremmo..."
"No. Non funziona così. Anche perché gli ignoranti sono troppi. Non ce la faremmo mai. Devono essere loro a fare un passo avanti".
"Ma che significa, non è mica un match noi contro loro. Siamo tutti ignoranti di qualcosa. Usiamo tutti qualche falsa nozione per proteggerci".
"Fammi un esempio".
"Ogni agosto, hai notato che a ogni fine di agosto esce una notizia ambientata sulla spiaggia che riassume il nostro approccio stagionale al problema dei migranti? Due anni fa, la foto di quel bambino siriano annegato sul bagnasciuga".
"Non era una falsa nozione".
"Era una foto tra tante, riassumeva un problema generale e complesso, simboleggiò una specie di svolta: la Merkel cambiò atteggiamento, tutti cambiarono atteggiamento - molti perlomeno - per un po' prevalse la linea dell'accoglienza. L'anno scorso, sempre su una spiaggia, il ladro di bambini".
"Me l'ero dimenticato".
"Anche quella volta, paginone di Libero. Tutto rapidamente sgonfiatosi, non c'era stato nessun tentato furto di nessun bambino. Ma riassumeva l'aria che stava tirando. Quest'anno il capo musulmano che insegna su facebook la meccanica dello stupro".
"Riassume la situazione?"
"Serve a difenderci".
"Ma cosa stai dicendo?"
"Vuoi la notizia vera? Quella che non ha dato Libero, e che anche i giornali rispettabili sono un po' restii a comunicare? Per risolvere la cosiddetta emergenza immigrazione, in due mesi abbiamo probabilmente lasciato annegare trentamila persone".
"Forse un po' meno..."
 |
| Dati fieramente elaborati dal Ministero degli Interni Li aggiornano tutti i giorni! |
"Lo so".
"Nel frattempo abbiamo preso accordi col capotribù che almeno a Tripoli ha preso il posto di Gheddafi, e che istituirà campi di concentramento disumani quanto quelli di Gheddafi. Anche se la Libia continua a essere un po' instabile e quindi, in concerto con l'Unione Europe che plaude al nostro spirito di iniziativa, stiamo pianificando di finanziare campi di concentramento più a monte, nel Sahel".
"So anche questo, ma..."
"In questo modo magari l'estate prossima i trentamila morti moriranno così tanto lontano, o lungo una una filiera talmente sviluppata e complessa, che non ce ne accorgeremo neppure, il che ci farà sentire meno assassini e forse farà vincere le elezioni contro i razzisti ignoranti, noi razzisti consapevoli e pianificatori".
"Senti, ho capito, mi rendo conto che è terribile, ma non andrà così".
"No?"
"Capisco che in questo momento tu possa sentirti..."
"Un po' assassino?"
"Diciamo che siamo tutti colpevoli... di una situazione orribile che..."
"Che si poteva evitare".
"Però non puoi esagerare. Non serve a niente esagerare".
"Sto esagerando?"
"Trentamila morti ogni estate, per esempio. Non è vero".
"È una stima".
"È solo la sottrazione tra gli sbarcati dell'anno scorso e quelli di quest'anno. E può darsi che davvero l'unica causa della differenza, quest'anno, sia che sono annegati. Non c'erano più navi disposte a soccorrerli, e li abbiamo lasciati annegare".
"Abbiamo fatto sì che fossero lasciati annegare".
"È successo. Ma l'anno prossimo non saranno di nuovo trentamila".
"Perché no?"
"Ma è una questione di buonsenso, insomma... quelli che partivano quest'anno, pensavano che sarebbe stato facile come l'anno scorso. Ma l'anno prossimo... ora che lo sanno... partiranno in meno".
"Cioè la strage sarà servita da deterrente".
"Purtroppo sì".
"Ma come fai a saperlo?"
"È buonsenso".
"O forse è un istinto autoprotettivo".
"Cosa?"
"Mi stai dicendo che dopo un po' smette di fare male".
"Non capisco".
"Il massacro. All'inizio fa male, ma dopo la gente si abitua e alla fine magari gode anche un po'".
"Facciamo che non ti sento".
Comments (21)
Aspettando il re, trovando una mamma
30-08-2017, 02:1821tw, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, fb2020PermalinkAspettando il re (A Hologram for the King, Tom Tykwer, 2016)
Un giorno potresti ritrovarti a vivere in una baracca dall'altra parte del mondo.
Un giorno potresti ritrovarti dietro il volante di un'enorme automobile, in una bella casa, con una bella moglie.
Un giorno potresti chiederti: ma come ci sono arrivato?
Certi film - li riconoscevi dalla locandina - servivano soprattutto a viaggiare. Per il pubblico si trattava di un'alternativa low budget a viaggi veri che non si poteva permettere: film-safari con zebre e rinoceronti e selvaggi. Certi film funzionavano così. Aspettando il re sembra voler perpetuare la tradizione, individuando in Tom Hanks l'Homo Occidentalis per eccellenza, in perenne crisi esistenziale ed economica, e calandolo in una delle mete turistiche tuttora più difficili per gli occidentali: l'Arabia Saudita (ricostruita in Egitto). La prima scena dice tutto: unico non-musulmano su un aereo di linea, mentre gli altri pregano il loro Dio Hanks sogna di vivere nel video di Once in a Lifetime, Talking Heads. Lo seguiremo in un albergo, nel fatiscente cantiere di un nuovo polo tecnologico che è ovviamente un luogo di smarrimento metafisico oltre che una metafora delle vacue velleità delle dinastie dei petrodollari. Insieme a lui cercheremo di capire come si può passare anche solo qualche giorno in un Paese in cui in teoria è vietato bere alcool; grazie a lui daremo una sbirciatina alle festicciole delle ambasciate europee e addirittura riusciremo per qualche istante a intrufolarci alla Mecca, città proibita agli infedeli. Non ci capiremo un granché, proprio come succede ai turisti veri, ma alla fine ci sentiremo comunque arricchiti. Non troveremo Dio ma magari l'amore (caccia via), proprio come in quei vecchi film con gli esploratori biondi e le dive un po' esotiche. Quest'ultima cosa magari non era prevista nell'omonimo libro di Dave Eggers, ma evidentemente lo sceneggiatore e regista Tom Tykwer ne sentiva l'esigenza.
A Hologram è l'ultima aggiunta al suo catalogo, sempre più simile al risultato di un esperimento surrealista: estrarre sei film a caso da Imdb e immaginare che li abbia girati tutti lo stesso autore. Nel suo caso sono usciti: Lola corre, l'ultima sceneggiatura di Kieslowski (ambientata in Italia!), Profumo, un thriller con Clive Owen e Naomi Watts, e poi un fecondo sodalizio con le sorelle Wachowski, con cui ha realizzato Cloud Atlas e la serie Sense8. Dopodiché avrebbe davvero potuto girare qualsiasi cosa, noir thailandesi o documentari sull'Amazzonia. In questo senso A Hologram è un viaggio deludente, non tanto per la destinazione, ma per il punto di vista che sceglie di adottare che è quello dell'occidentale in assoluto più standard e spaesato: l'Americano... (continua su +eventi!)
La storia del manager in trasferta, oberato dai sensi di colpa per aver collaborato alla delocalizzazione e allo smantellamento del Made in USA, sembrava già un po' datata quando uscì il libro - cinque anni fa: ora, con la disoccupazione statunitense in costante calo, suona sinistramente affine a certe tirate elettorali di Trump. All'angoscia vagamente beckettiana evocata da Eggers, Tykwer sovrappone la sensibilità paranoide che ha mutuato dalle sorelle Wachowski; in un paesaggio che è già surreale di suo, tra deserti e grattacieli, non serve molto per suggerire che il venditore di ologrammi Hanks sia vittima di un gigantesco scherzo, un meta-ologramma. Ma chi si aspetta un finale sconvolgente e rivelatore si prepara a una delusione: a un certo punto è come se sulla sceneggiatura fosse caduto un po' di zucchero, se non un'intera zuccheriera. Tykwer sembra sinceramente preoccupato non soltanto per il suo protagonista stanco e disperato, ma per tutti i cinquantenni che lo hanno seguito per più di un'ora, condividendone ansie e disagi a dire la verità più americani che universali (il college della figlia, status irrinunciabile!)
Alla fine non si tratta più di portare in viaggio gli spettatori, ma di confortarli: quella cisti non è necessariamente un tumore, quell'affanno è più panico che infarto; gli affari possono andare male, non è la fine del mondo: e anche i matrimoni, ma se guardi bene da qualche parte c'è già qualcuno disposto a medicarti e consolarti. È un film che in sostanza smette di guardarsi intorno e comincia a cercare la mamma: ma almeno la trova incarnata nelle forme antihollywoodiane di Sarita Choudhury. Vent'anni fa era la Tara di Kamasutra: oggi ne ha cinquanta, è una bellissima signora e non è affatto difficile capire perché l'uomo-Tom Hanks si senta attratto da lei. Quello che alla fine della visione rimane non spiegato è cosa possa aver trovato lei in un americano spaurito e senza direzione. Nei film di una volta sarebbe stata una domanda inutile: l'uomo bianco era affascinante in quanto bianco. Aspettando il re è al cinema Monviso di Cuneo da giovedì 31 agosto a martedì 5 settembre alle 21.
Un giorno potresti ritrovarti a vivere in una baracca dall'altra parte del mondo.
Un giorno potresti ritrovarti dietro il volante di un'enorme automobile, in una bella casa, con una bella moglie.
Un giorno potresti chiederti: ma come ci sono arrivato?
Certi film - li riconoscevi dalla locandina - servivano soprattutto a viaggiare. Per il pubblico si trattava di un'alternativa low budget a viaggi veri che non si poteva permettere: film-safari con zebre e rinoceronti e selvaggi. Certi film funzionavano così. Aspettando il re sembra voler perpetuare la tradizione, individuando in Tom Hanks l'Homo Occidentalis per eccellenza, in perenne crisi esistenziale ed economica, e calandolo in una delle mete turistiche tuttora più difficili per gli occidentali: l'Arabia Saudita (ricostruita in Egitto). La prima scena dice tutto: unico non-musulmano su un aereo di linea, mentre gli altri pregano il loro Dio Hanks sogna di vivere nel video di Once in a Lifetime, Talking Heads. Lo seguiremo in un albergo, nel fatiscente cantiere di un nuovo polo tecnologico che è ovviamente un luogo di smarrimento metafisico oltre che una metafora delle vacue velleità delle dinastie dei petrodollari. Insieme a lui cercheremo di capire come si può passare anche solo qualche giorno in un Paese in cui in teoria è vietato bere alcool; grazie a lui daremo una sbirciatina alle festicciole delle ambasciate europee e addirittura riusciremo per qualche istante a intrufolarci alla Mecca, città proibita agli infedeli. Non ci capiremo un granché, proprio come succede ai turisti veri, ma alla fine ci sentiremo comunque arricchiti. Non troveremo Dio ma magari l'amore (caccia via), proprio come in quei vecchi film con gli esploratori biondi e le dive un po' esotiche. Quest'ultima cosa magari non era prevista nell'omonimo libro di Dave Eggers, ma evidentemente lo sceneggiatore e regista Tom Tykwer ne sentiva l'esigenza.
 |
| Vogliamo anche ricordare come avevano conciato Tom Hanks in Cloud Atlas. |
La storia del manager in trasferta, oberato dai sensi di colpa per aver collaborato alla delocalizzazione e allo smantellamento del Made in USA, sembrava già un po' datata quando uscì il libro - cinque anni fa: ora, con la disoccupazione statunitense in costante calo, suona sinistramente affine a certe tirate elettorali di Trump. All'angoscia vagamente beckettiana evocata da Eggers, Tykwer sovrappone la sensibilità paranoide che ha mutuato dalle sorelle Wachowski; in un paesaggio che è già surreale di suo, tra deserti e grattacieli, non serve molto per suggerire che il venditore di ologrammi Hanks sia vittima di un gigantesco scherzo, un meta-ologramma. Ma chi si aspetta un finale sconvolgente e rivelatore si prepara a una delusione: a un certo punto è come se sulla sceneggiatura fosse caduto un po' di zucchero, se non un'intera zuccheriera. Tykwer sembra sinceramente preoccupato non soltanto per il suo protagonista stanco e disperato, ma per tutti i cinquantenni che lo hanno seguito per più di un'ora, condividendone ansie e disagi a dire la verità più americani che universali (il college della figlia, status irrinunciabile!)
Alla fine non si tratta più di portare in viaggio gli spettatori, ma di confortarli: quella cisti non è necessariamente un tumore, quell'affanno è più panico che infarto; gli affari possono andare male, non è la fine del mondo: e anche i matrimoni, ma se guardi bene da qualche parte c'è già qualcuno disposto a medicarti e consolarti. È un film che in sostanza smette di guardarsi intorno e comincia a cercare la mamma: ma almeno la trova incarnata nelle forme antihollywoodiane di Sarita Choudhury. Vent'anni fa era la Tara di Kamasutra: oggi ne ha cinquanta, è una bellissima signora e non è affatto difficile capire perché l'uomo-Tom Hanks si senta attratto da lei. Quello che alla fine della visione rimane non spiegato è cosa possa aver trovato lei in un americano spaurito e senza direzione. Nei film di una volta sarebbe stata una domanda inutile: l'uomo bianco era affascinante in quanto bianco. Aspettando il re è al cinema Monviso di Cuneo da giovedì 31 agosto a martedì 5 settembre alle 21.
Sintetico negli anni Ottanta
25-08-2017, 01:24Bob Dylan, musica, OttantaPermalinkEmpire Burlesque (1985)
ABBASSATE-QUELLA-CAZZO-DI-BATTERIA-ELETTRONICA.
Where the charity is supposed to cover up a multitude of sins... Nel gennaio del 1985, mentre stava già disordinatamente mettendo da parte incisioni per il nuovo album, Dylan atterrò nella base segreta californiana in cui gli USA for Africa stavano lavorando al singolo benefico We Are the World. Il video in cui cerca di incidere la sua parte è un documento toccante. Dylan è circondato da musicisti immensi – a spiegargli lo spartito c'è Lionel Richie (coautore del brano con Michael Jackson); ad accompagnarlo al piano c'è appena appena Stevie Wonder. Mentre cerca di non steccare troppo sull'attacco, come può Dylan non pensare: che ci faccio qui? Chi voglio prendere in giro? La tonalità è troppo alta per me, io non posso cantare a questi livelli, io sono solo Bob Dylan. Quincy Jones lo incoraggia: vai, questa era ottima. “Se lo dici tu”... QJ probabilmente aveva messo a fuoco il problema: Dylan avrebbe potuto anche cantare meglio di così, ma non sarebbe sembrato più Dylan. Dylan più che un cantante è un funambolo: la gente non vuole sentirlo cantare bene, la gente vuole vederlo oscillare sulle corde non solo vocali; la gente vuole e non vuole vederlo precipitare.
La prima cosa che pensi quando tiri fuori Empire Burlesque è: che razza di giacca, che razza di anni.
La prima cosa che senti quando premi play: un coretto. Sono tornati i coretti. Usciremo mai da questi anni Ottanta?
Dopodiché parte quel CAZZO DI BATTERIA ELETTRONICA.
I saw thousands who could have overcome the darkness... Dopo la fine del mondo (sarebbbe più preciso dire durante la fine del mondo), una parte della coscienza dell'umanità ha trovato rifugio in un mini-universo artificiale contenuto nella memoria virtuale di un supercomputer, dove il tempo scorre molto più rapidamente (milioni di anni virtuali ogni secondo terrestre). Gli umani-bot che vivono in questo universo sono copie virtuali di persone che erano vive nel momento in cui la notte è venuta cadendo sulla Terra. Per non impazzire al pensiero, nei milioni di anni virtuali che restano a loro disposizione hanno deciso di fingere di essere umani reali, nel mondo reale. In particolare hanno scelto di rivivere il secolo 1950-2050, un periodo storico molto drammatico e interessante ma senza troppe guerre mondiali, e soprattutto facile da ricostruire, grazie alla quantità di materiale anche audiovisivo nelle banche dati – anche se qualcosa si era perso nei backup, per esempio un intero disco del celebre Bob Dylan, un disco per fortuna non imperdibile, inciso proprio a metà degli anni Ottanta.
Gli studiosi-bot lo hanno ricostruito in base a una serie di congetture, nello stesso modo in cui si ricostruisce un tempio greco a partire da un capitello: hanno preso qualche scarto dai due dischi precedenti e dai due successivi e lo hanno rimontato tenendo conto del sound che andava in quel momento storico (quella CAZZO DI BATTERIA ELETTRONICA). Hanno anche creato una copertina, ottenuta sovrapponendo a un'immagine di Dylan nel 1985 un outfit che poteva andare di moda in quel periodo – la giacca l'hanno presa da un telefilm. Il risultato è stato molto criticato dagli altri studiosi-bot. “Bob Dylan non è una funzione matematica”, sostengono. “Non è che puoi fissare sulla retta x lo Zeitgeist, sulla retta y la sua vita personale, e pensare di incontrarlo all'incrocio delle coordinate”: un'obiezione tutto sommato sensata, anche se è buffo che provenga da dei bot.
Altri hanno obiettato che sì, probabilmente il vero Empire Burlesque era molto diverso – ma non necessariamente migliore; che immaginare come avrebbe potuto suonare un disco di Dylan a metà anni Ottanta è un esercizio utile a capire la nostra idea di Dylan e degli anni Ottanta, ma che più di tanto non cambia la traiettoria complessiva: se fosse stato un disco davvero importante avrebbe lasciato più segni di sé. Invece doveva essere uno di quei dischi che nessuno ascoltava più di tre volte – tranne i dylaniti all'ultimo stadio, alla ricerca disperata di qualche motivo per sostenere che non fosse un brutto disco, dai, che fosse sottovalutato. Ma anche solo per sottovalutarlo bisognava ascoltarlo.
Never gonna be the same again. Riconosciamoglielo: tra tanti difetti, Dylan non ha mai avuto quello della prevedibilità. Anche Empire Burlesque (quello vero?) a suo modo è una sorpresa. Già dalla copertina, con quella grafica. E poi gli arrangiamenti, con QUELLA CAZZO DI BATTERIA ELETTRONICA. Eppure in un qualche modo Empire non è imprevedibile come dovrebbe essere. Sembra davvero simile al risultato di un esperimento mentale: che disco avrebbe potuto realizzare BD se nel 1985 avesse ceduto di schianto alle tendenze del momento? Vediamo. Per quanto riguarda i testi, suggerirei di ripartire da Infidels togliendo quello sciovinismo che ai fan non era andato giù (a questo punto della sua carriera Dylan non può permettersi di perdere quello zoccolo duro di fan che gli è rimasto); ridurre di un 60% le reminiscenze bibliche, riempire i buchi con qualche battuta da film di Bogart, dopotutto l'immaginario di Dylan è quello di vostro padre se vostro padre aveva 40 anni negli anni '80... aumentare un po' il tasso di Apocalisse, e spolverare di zucchero sentimentale, ché alle porte c'è un secondo matrimonio. Il sound? Raccogliere un po' del r'n'b messo da parte ai tempi di Shot of Love, aggiungere qualche spruzzo di Sly e Robbie che erano ancora nei dintorni, anche Mick Taylor perché no (Knopfler no perché sai che hanno litigato), non lesinare coi synth e puntellare il tutto con QUELLA CAZZO DI BATTERIA ELETTRONICA che il quasi-produttore, Arthur Baker, prende in prestito dai New Order.
(Per quanto possa sembrare irresponsabile l'idea di affidare il suono di un disco di Bob Dylan al produttore dei New Order, beh, sono i tipici esperimenti che si facevano in quel periodo. I Talking Heads che vanno a cercare Brian Eno, i Ramones che si accollano Phil Spector, David Bowie con Nile Rodgers, era un periodo in cui rimescolare le carte era quasi obbligatorio e molto spesso funzionava. Indovinate qual è l'unico grande artista con cui non ha davvero funzionato).
I'm gonna get my coat, I feel the breath of a storm. Persino la giacca, quella giacca ha un senso. Immagina Bob Dylan, quarantenne negli anni Ottanta, che decide di aggiornarsi al gusto dei tempi: che giacca si sarebbe messo indosso, almeno per il tempo di un videoclip e di una posa? Qualcosa che avrebbe potuto indossare il protagonista di un serial che Bob Dylan avrebbe potuto seguire in tv nel 1985 – capisci che non può essere che Miami Vice. Nel 1985 tutti i duri della musica volevano recitare in Miami. Frank Zappa fa un cameo. Little Richard! Miles Davis! Dylan probabilmente era troppo timido per fare una telefonata, figurati se Michael Mann non gli avrebbe trovato un ruolo da boss taciturno. O da pappa scorbutico. O da ispettore della narco – marcissimo ovviamente.
If you want somebody you can trust, trust yourself. C'è già capitato di notare come i dischi migliori di Dylan siano stati prodotti in due tempi. Il primo, apparentemente infruttuoso, è quello della sperimentazione: una fase in cui Dylan prova tante cose con tanti musicisti diversi e poi magari butta via tutto. Poi c'è il secondo tempo, quello in cui mette a fuoco quello che vuole fare, magari licenzia i musicisti e ne assume degli altri, scrive un paio di capolavori e incide il tutto in pochi giorni o poche ore. Questo secondo tempo, Dylan non riesce sempre a trovarlo. Ma Empire forse è il primo caso in cui ci rinuncia proprio. L'inizio di una fase (già preannunciata da Shot of Love) in cui i dischi di Dylan non saranno più oggetti dotati di un'identità, ma raccolte più o meno eterogenee di materiale inciso qua e là durante l'anno. L'elenco di session e di musicisti convocati dà il mal di mare. Ci sono un paio di Rolling Stones (in momenti diversi), un paio di elementi della E Street Band che accompagnavano i dischi migliori di Bruce Springsteen, mentre con Dylan non riusciranno a venire a capo di When the Night Comes Falling. Ci sono Sly e Robbie, un po' dei Lone Justice, c'è il caro vecchio Al Kooper ma suona solo la chitarra in un pezzo c'è pure Dave Stewart degli Eurythmics che passava di lì e non ha suonato niente: in compenso ha girato il video di When the Night Comes Falling e si è imbucato sul set come chitarrista – perché no, dopotutto? Non potrebbe averlo prodotto lui, Empire Burlesque: non ha la stessa piaciona oscillazione tra syinth e chitarre distorte dei dischi più venduti degli Eurythmics? Prendi Missionary Man: ci sono tutti gli ingredienti di Empire. Il rocchenroll, la corista scatenata, la CAZZO DI BATTERIA SINTETICA, perfino l'armonica. Salvo che è tutto miscelato a meraviglia, mentre Empire come dire, Empire sembra l'intruglio che ti versa un vecchio zio barman a cui sei affezionato, ma sai che ti servirà una serata intera a mandarlo giù.
I'll go along with the charade until I can think my way out. Ho scoperto che sul retro del singolo americano Tight Connection to My Heart c'è addirittura un brano di Street-Legal... (continua sul Post, con altri simpatici video e gif animate).
(Il disco precedente: Real Live
Il disco successivo: Biograph)
ABBASSATE-QUELLA-CAZZO-DI-BATTERIA-ELETTRONICA.
***
Where the charity is supposed to cover up a multitude of sins... Nel gennaio del 1985, mentre stava già disordinatamente mettendo da parte incisioni per il nuovo album, Dylan atterrò nella base segreta californiana in cui gli USA for Africa stavano lavorando al singolo benefico We Are the World. Il video in cui cerca di incidere la sua parte è un documento toccante. Dylan è circondato da musicisti immensi – a spiegargli lo spartito c'è Lionel Richie (coautore del brano con Michael Jackson); ad accompagnarlo al piano c'è appena appena Stevie Wonder. Mentre cerca di non steccare troppo sull'attacco, come può Dylan non pensare: che ci faccio qui? Chi voglio prendere in giro? La tonalità è troppo alta per me, io non posso cantare a questi livelli, io sono solo Bob Dylan. Quincy Jones lo incoraggia: vai, questa era ottima. “Se lo dici tu”... QJ probabilmente aveva messo a fuoco il problema: Dylan avrebbe potuto anche cantare meglio di così, ma non sarebbe sembrato più Dylan. Dylan più che un cantante è un funambolo: la gente non vuole sentirlo cantare bene, la gente vuole vederlo oscillare sulle corde non solo vocali; la gente vuole e non vuole vederlo precipitare.
***
La prima cosa che pensi quando tiri fuori Empire Burlesque è: che razza di giacca, che razza di anni.
La prima cosa che senti quando premi play: un coretto. Sono tornati i coretti. Usciremo mai da questi anni Ottanta?
Dopodiché parte quel CAZZO DI BATTERIA ELETTRONICA.
***
 |
| Sono il Dritto di Miami, Mister Bob. |
Gli studiosi-bot lo hanno ricostruito in base a una serie di congetture, nello stesso modo in cui si ricostruisce un tempio greco a partire da un capitello: hanno preso qualche scarto dai due dischi precedenti e dai due successivi e lo hanno rimontato tenendo conto del sound che andava in quel momento storico (quella CAZZO DI BATTERIA ELETTRONICA). Hanno anche creato una copertina, ottenuta sovrapponendo a un'immagine di Dylan nel 1985 un outfit che poteva andare di moda in quel periodo – la giacca l'hanno presa da un telefilm. Il risultato è stato molto criticato dagli altri studiosi-bot. “Bob Dylan non è una funzione matematica”, sostengono. “Non è che puoi fissare sulla retta x lo Zeitgeist, sulla retta y la sua vita personale, e pensare di incontrarlo all'incrocio delle coordinate”: un'obiezione tutto sommato sensata, anche se è buffo che provenga da dei bot.
Altri hanno obiettato che sì, probabilmente il vero Empire Burlesque era molto diverso – ma non necessariamente migliore; che immaginare come avrebbe potuto suonare un disco di Dylan a metà anni Ottanta è un esercizio utile a capire la nostra idea di Dylan e degli anni Ottanta, ma che più di tanto non cambia la traiettoria complessiva: se fosse stato un disco davvero importante avrebbe lasciato più segni di sé. Invece doveva essere uno di quei dischi che nessuno ascoltava più di tre volte – tranne i dylaniti all'ultimo stadio, alla ricerca disperata di qualche motivo per sostenere che non fosse un brutto disco, dai, che fosse sottovalutato. Ma anche solo per sottovalutarlo bisognava ascoltarlo.
***
Never gonna be the same again. Riconosciamoglielo: tra tanti difetti, Dylan non ha mai avuto quello della prevedibilità. Anche Empire Burlesque (quello vero?) a suo modo è una sorpresa. Già dalla copertina, con quella grafica. E poi gli arrangiamenti, con QUELLA CAZZO DI BATTERIA ELETTRONICA. Eppure in un qualche modo Empire non è imprevedibile come dovrebbe essere. Sembra davvero simile al risultato di un esperimento mentale: che disco avrebbe potuto realizzare BD se nel 1985 avesse ceduto di schianto alle tendenze del momento? Vediamo. Per quanto riguarda i testi, suggerirei di ripartire da Infidels togliendo quello sciovinismo che ai fan non era andato giù (a questo punto della sua carriera Dylan non può permettersi di perdere quello zoccolo duro di fan che gli è rimasto); ridurre di un 60% le reminiscenze bibliche, riempire i buchi con qualche battuta da film di Bogart, dopotutto l'immaginario di Dylan è quello di vostro padre se vostro padre aveva 40 anni negli anni '80... aumentare un po' il tasso di Apocalisse, e spolverare di zucchero sentimentale, ché alle porte c'è un secondo matrimonio. Il sound? Raccogliere un po' del r'n'b messo da parte ai tempi di Shot of Love, aggiungere qualche spruzzo di Sly e Robbie che erano ancora nei dintorni, anche Mick Taylor perché no (Knopfler no perché sai che hanno litigato), non lesinare coi synth e puntellare il tutto con QUELLA CAZZO DI BATTERIA ELETTRONICA che il quasi-produttore, Arthur Baker, prende in prestito dai New Order.
(Per quanto possa sembrare irresponsabile l'idea di affidare il suono di un disco di Bob Dylan al produttore dei New Order, beh, sono i tipici esperimenti che si facevano in quel periodo. I Talking Heads che vanno a cercare Brian Eno, i Ramones che si accollano Phil Spector, David Bowie con Nile Rodgers, era un periodo in cui rimescolare le carte era quasi obbligatorio e molto spesso funzionava. Indovinate qual è l'unico grande artista con cui non ha davvero funzionato).
***
I'm gonna get my coat, I feel the breath of a storm. Persino la giacca, quella giacca ha un senso. Immagina Bob Dylan, quarantenne negli anni Ottanta, che decide di aggiornarsi al gusto dei tempi: che giacca si sarebbe messo indosso, almeno per il tempo di un videoclip e di una posa? Qualcosa che avrebbe potuto indossare il protagonista di un serial che Bob Dylan avrebbe potuto seguire in tv nel 1985 – capisci che non può essere che Miami Vice. Nel 1985 tutti i duri della musica volevano recitare in Miami. Frank Zappa fa un cameo. Little Richard! Miles Davis! Dylan probabilmente era troppo timido per fare una telefonata, figurati se Michael Mann non gli avrebbe trovato un ruolo da boss taciturno. O da pappa scorbutico. O da ispettore della narco – marcissimo ovviamente.
***
 |
| Primo timido tentativo di coreografia. |
Charlize Theron pesta Berlino
22-08-2017, 00:3721tw, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, fb2020, nostalgia, OttantaPermalinkAtomica bionda (Atomic blonde, David Leitch, 2017).
Immagina per un attimo che gli USA e l'URSS avessero vinto la Seconda Guerra Mondiale, spartendosi l'Europa in due blocchi, a est e a ovest di Berlino; a quel punto avrebbero avuto entrambi la bomba atomica e quindi non avrebbero più potuto dichiararsi guerra. Immagina, come conseguenza, un lungo periodo di tregua armata, in cui alle grandi battaglie di massa si sarebbero sostituiti degli scontri simbolici - come ai tempi dei duelli epici, Paride contro Menelao, gli Orazi contro i Curiazi. Gli eroi protagonisti di questi combattimenti, uomini e donne esperti in ogni arte di combattimento e in ogni sotterfugio, li avremmo chiamati "spie", anche se alla fine non è che avrebbero spiato un granché - più che altro si sarebbero spiati a vicenda, in un gioco a somma zero. Qualche scrittore molto presto si sarebbe messo a raccontare le loro straordinarie avventure, senza preoccuparsi di esagerare. Ne sarebbe derivata tutta una letteratura epica, e poi naturalmente romanzi e film, che a furia di nutrirsi dello stesso immaginario che coltivavano avrebbero reso questa Europa immaginaria in un qualche modo concreta, più coerente di quella vera: un sogno ma tutt'altro che effimero, come la Grecia dei miti o il Far West, sognati da miliardi di persone. Al punto che ne avremmo avuto nostalgia, e un puerile desiderio di averci vissuto davvero, invece di vivere in... già, dove abbiamo vissuto noi?
Charlize Theron, nel 1989 in cui crollò il Muro, aveva 14 anni. Adesso ne ha più di quaranta ed è una diva di serie A. Da cosa si capisce? Dalle botte che prende. Certo, ne dà anche parecchie. Atomica Bionda è tra l'altro il film in cui la vediamo uccidere i cattivi a mani nude. Ed è credibile: si fa una certa fatica viceversa a immaginare che un attore possa sopravvivere ai colpi che la Theron tira aiutandosi con quel che trova sul momento - un portachiavi, un fornellino elettrico, un tacco che per un attimo ti aspetti nasconda un qualsiasi gadget da James Bond e invece no, è un semplice tacco neanche troppo appuntito. Ma quello che fa davvero la differenza tra Atomica e altri film di spie più o meno seri (negli ultimi anni c'è stata una renaissance del genere, anche se il pubblico non sembra sempre entusiasta) sta nei lividi, nel sangue; nell'occhio nero con cui il suo personaggio si presenta ai suoi capi e al pubblico all'inizio del film; nel ghiaccio che usa per alleviare il dolore. Nell'abolizione di quella convenzione cinematografica per cui dopo una botta bene assestata l'avversario resta al tappeto in coma vigile - no, in Atomica bionda o muori o ti rialzi, e pare che morire non sia poi così facile.
L'ufficio stampa ci aveva preventivamente spiegato che la Theron, mentre si allenava a incassare sul set, "vomitava praticamente tutti i giorni", che a un certo punto ha perso un dente. Atomica Bionda è un progetto suo: è stata la sua società di produzione a scegliere la graphic novel, a farla riscrivere su misura (la protagonista del fumetto non era nemmeno bionda), a convincere il secondo regista di John Wick ad abbandonare John Wick 2 per girare un film non così diverso. Atomica Bionda è un film voluto, interpretato e scolpito a mani nude sulla carne viva da Charlize Theron, e la cosa non avrebbe dovuto stupirmi così tanto - se solo riuscissi a liberarmi dalla mia prediletta immagine mentale della Theron, che è ancora quella della bambolona riccioluta che sta con Keanu Reeves all'inizio dell'Avvocato del diavolo; se almeno riuscissi a ricordare che la stessa bambolona, in quello stesso film, si trasformava in qualcosa di totalmente diverso, un corpo già slavato e dolente - allora potrei rendermi conto che Atomica Bionda non è semplicemente il film dell'ennesimo divo/a che passata la soglia dei 40 anni (50 per i maschi) si mette a cercare nei ruoli action una seconda giovinezza: che è anche il punto di arrivo coerente di un'attrice che ha sempre lavorato sul proprio corpo, riempiendolo e svuotandolo, rompendolo e riparandolo (continua su +eventi!)
Qualcosa di simile a quello che ha fatto negli ultimi anni Scarlett Johansson? O forse l'esatto contrario. La Johansson lavora per sottrazione: toglie il volto, toglie la pelle, toglie il corpo, come se volesse domandare al pubblico: cosa ti piace di me davvero? La Theron non toglie niente, incassa tutto. A ben vedere lo ha sempre fatto, e ora che può scegliersi i ruoli lo farà ancora di più. Atomica Bionda è un film centrato su di lei, plasmato su di lei, ambientato in una Berlino anni Ottanta che malgrado ogni sforzo filologico sembra finta; messa in scena da scrittori, fotografi e trovarobe scrupolosi ma che sembrano non averli vissuti, quegli anni, né a Berlino né in Europa né sul pianeta Terra: sembrano alieni arrivati almeno dieci anni dopo, molto coscienziosi eppure la loro ricostruzione suona falsa lo stesso. È difficile spiegare perché. Ci si sente come si sarebbe sentito Buffalo Bill davanti ai primi film western, ammesso che ne abbia mai visti.
 |
| Che cast però. |
 |
| Speriamo sia make up. |
L'ufficio stampa ci aveva preventivamente spiegato che la Theron, mentre si allenava a incassare sul set, "vomitava praticamente tutti i giorni", che a un certo punto ha perso un dente. Atomica Bionda è un progetto suo: è stata la sua società di produzione a scegliere la graphic novel, a farla riscrivere su misura (la protagonista del fumetto non era nemmeno bionda), a convincere il secondo regista di John Wick ad abbandonare John Wick 2 per girare un film non così diverso. Atomica Bionda è un film voluto, interpretato e scolpito a mani nude sulla carne viva da Charlize Theron, e la cosa non avrebbe dovuto stupirmi così tanto - se solo riuscissi a liberarmi dalla mia prediletta immagine mentale della Theron, che è ancora quella della bambolona riccioluta che sta con Keanu Reeves all'inizio dell'Avvocato del diavolo; se almeno riuscissi a ricordare che la stessa bambolona, in quello stesso film, si trasformava in qualcosa di totalmente diverso, un corpo già slavato e dolente - allora potrei rendermi conto che Atomica Bionda non è semplicemente il film dell'ennesimo divo/a che passata la soglia dei 40 anni (50 per i maschi) si mette a cercare nei ruoli action una seconda giovinezza: che è anche il punto di arrivo coerente di un'attrice che ha sempre lavorato sul proprio corpo, riempiendolo e svuotandolo, rompendolo e riparandolo (continua su +eventi!)
 |
| Queste cose nei miei anni Ottanta non si vedevano! (maledizione). |
Non è una questione di dettagli, quelli sono tutti al posto giusto, eppure... metti Sofia Boutella. È brava, ha quella sua bellezza insolita che ricorda qualche vecchia esotica Bond girl; il suo ruolo ha un senso, eppure sembra lo stesso lì per caso. Prendi James McAvoy. È bravo. È sempre stato bravo. Ma può essere un veterano del MI6 a Berlino nel 1989? Qualcosa non va e non è il taglio dei capelli, né il giaccone, né qualsiasi altro dettaglio. È che un tizio così, negli anni Ottanta che mi ricordo io, non esisteva. Il suo modo di muoversi, di raccontarsela, di mantenere un'apparenza giovanile in una storia che non lo prevede... Così come non esisteva ancora, negli Ottanta che ricordo io, il lesbismo soft patinato di Atomica bionda, che dieci anni dopo era già un luogo comune. Non che abbia molta importanza: prima o poi era inevitabile che gli Ottanta diventassero un decennio immaginario, come gli anni Venti dei film di Gangster e l'Ottocento del Far West - un mondo fantastico ottenuto sovrapponendo gli oggetti trovati qua e là nei mercatini: la breakdance sulle note di 99 Luftballons, i New Order e Siouxsie. Non c'è neanche da prendersela, se non col tempo che passa e si lascia sempre più alle spalle i nostri ricordi: ma passa anche se ce la prendiamo. Forse dovremmo andare anche noi in palestra, prendere a pugni un attrezzo finché non va al tappeto, o non ci andiamo noi. Atomica bionda è un film di spie che si prendono a mazzate e Charlize Theron è la più tosta di tutte. Il cast è clamoroso. Tra una scena d'azione e l'altra c'è anche una trama non troppo stupida, anche se al cinema, con la musica a palla, è un po' difficile seguirla. Le mazzate invece si sentono benissimo. Al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (20:10, 22:40); al Vittoria di Bra (20:00, 22:30); al Multilanghe di Dogliani (21:30) e all'Italia di Saluzzo (20:00, 22:15).
Comments (1)
Nella vecchia fattoria di Maggie
18-08-2017, 17:06Bob Dylan, concerti, musica, OttantaPermalink
Real Live (1984)
Non sono io.No, no, no, non sono io, babe.
Non sono io quello che cerchi, babe (migliaia di persone al Wembley di Londra, 27 luglio 1984).
Non sono io quello che cerchi, babe (migliaia di persone al Wembley di Londra, 27 luglio 1984).
Di tutte le svolte improvvise e contraddittorie che hanno segnato la carriera di Dylan, ce n'è una che avviene in poco meno di un minuto, un minuto ridicolo, tragico e imbarazzante. Comincia con una nota dissonante, il che è molto dylaniano. Il nostro eroe sta suonando con i Plugz, un gruppo postpunk ispanocaliforniano, voglio ripeterlo: è un gruppo postpunk ispanocaliforniano col quale sta provando intensivamente da alcune settimane. Che fine hanno fatto i turnisti superprofessonali di Infidels? Accantonati. E i cori gospel? Sono passati appena tre anni, sembra una vita. I Plugz stanno stravolgendo un paio di brani del disco uscito pochi mesi prima che Dylan in teoria dovrebbe promuovere - in pratica sembra volerlo fare a pezzi. È il momento dell'assolo di armonica; Dylan si stacca di dosso la chitarra senza che il sound complessivo ne risenta, afferra un'armonica, l'accosta al microfono nel pugno, comincia a soffiare, ma l'effetto è quello di un clacson di un autobus che nemmeno il postpunk può assorbire incolume. Che sta succedendo? Gli avevano preparato l'armonica sbagliata. Chissà quante volte gli era capitato - del resto secondo voi Dylan si preoccupa di spiegare quale armonica vuole a portata di mano, o in che chiave ha intenzione di suonare la prossima canzone? Il problema è che stavolta sta succedendo in diretta tv nazionale, al David Letterman Show. E per quanto sia solo un piccolo imprevisto della diretta, che quasi nulla toglie alla freschezza dell'esibizione; per quanto lo stesso Letterman alla fine arrivi a stringere la mano a Dylan e a proporgli di tornare da lui "ogni giovedì sera", strappando al mostro sacro una risata, la verità è che abbiamo appena assistito a una delle svolte più nette e tristi della storia di Bob Dylan. Il pendolo stavolta è oscillato in un istante, il brevissimo flirt di Bob col post-punk finisce qui.
E dire che sarebbe bastato così poco - l'armonica giusta al posto giusto? Fino a pochi minuti prima sembrava felice: una telecamera lo aveva sorpreso mentre alzava addirittura un pugno chiuso con entusiasmo da combattente. Stava massacrando Jokerman con la stessa furia con cui nel '74 insieme alla Band aveva affondato Lay Lady Lay, ma il risultato era molto più convincente. Dylan sembrava staccarsi dalle secche dei Dire Straits per avvicinarsi ai promontori dei Talking Heads, dove forse non avrebbe potuto approdare, eppure... Quei ragazzi ispanocaliforniani avrebbero potuto essere suoi figli - in effetti, se non fosse stato per i dischi punk e new wave che ascoltava il suo figlio maggiore, non li avrebbe mai reclutati - ma avevano la grinta giusta per abbattere il Dylansauro e assistere al parto di un mostro nuovo. E invece.
E dire che sarebbe bastato così poco - l'armonica giusta al posto giusto? Fino a pochi minuti prima sembrava felice: una telecamera lo aveva sorpreso mentre alzava addirittura un pugno chiuso con entusiasmo da combattente. Stava massacrando Jokerman con la stessa furia con cui nel '74 insieme alla Band aveva affondato Lay Lady Lay, ma il risultato era molto più convincente. Dylan sembrava staccarsi dalle secche dei Dire Straits per avvicinarsi ai promontori dei Talking Heads, dove forse non avrebbe potuto approdare, eppure... Quei ragazzi ispanocaliforniani avrebbero potuto essere suoi figli - in effetti, se non fosse stato per i dischi punk e new wave che ascoltava il suo figlio maggiore, non li avrebbe mai reclutati - ma avevano la grinta giusta per abbattere il Dylansauro e assistere al parto di un mostro nuovo. E invece.
E invece l'armonica era quella sbagliata, Dylan si ritrovò in un attimo sperduto sul set mentre i Plugz continuavano a darci dentro, impassibili, come i professionisti che ancora non erano, ma che quel giorno sarebbero potuti diventare. Qui si potrebbe anche inserire una digressione sul concetto di professionismo, su quanto permei la cultura nordamericana e abbia relativamente smorzato la carica nichilista del primo punk britannico; è un concetto contro il quale Dylan ha combattuto da una vita, scrivendo e cantando canzoni piene di trappole per i virtuosi, canzoni incantabili e insuonabili; eppure anche Dylan non è mai riuscito a liberarsi del tutto dall'imperativo morale del professionismo, dall'ansia della prestazione, dalla vergogna del fiasco. Forse mentre distruggeva Jokerman a pugno chiuso dal vivo ci stava riuscendo; ma l'armonica stonata era troppo anche per lui. Ufficialmente lo show andò bene. Letterman si congratulò, e su Youtube ci sono ancora fan che lasciano un pollice alto e definiscono quel mezzo minuto di panico da armonica una straordinaria epifania televisiva. Ma Dylan, lo abbiamo visto, non è un gran fan di sé stesso. Fa anzi un po' fatica a riascoltarsi, odia la diretta televisiva e ai Plugz, dopo le strette di mano e i saluti, disse soltanto: vi chiamo lunedì. Lo stanno ancora aspettando.
Non lavorerò più per la fattoria di Maggie (Bob Dylan, 1965; ma anche 1976; ma anche 1978; ma anche 1984).
Tre mesi dopo era in tour in Europa, un doppio show con Santana, roba da riempire gli stadi da calcio (in alcune date arrivò anche Joan Baez, ma litigarono e non si sono più rivisti, credo, da allora). Ad accompagnarlo una band di professionisti, tra cui spicca Mick Taylor (l'ex rolling stone è l'unica conferma della super-formazione di Infidels) e Ian McLagan, già (ex Small Faces e Faces). Tutti coetanei affidabili in giro dagli anni Sessanta, nessun ragazzino. Ma nemmeno coriste. In compenso c'è il coro del pubblico - tante grazie, è un live - sì, ma siamo in quella fase post-BobMarleyana in cui i live devono documentare anche l'interazione della star col pubblico, che è sempre più vasto, (non si sentono più voci e fischi, ma un boato indistinto) eppure sembra sempre più disciplinato: è un pubblico-massa ma è anche un pubblico-strumento con una partitura da seguire. Dylan non è che si metta a sollecitarlo a colpi di "Yooo-ooooh", come Marley (o Sting), né lo asseconda come Baglioni, ma gli permette per la prima volta di cantare un ritornello da solo, e di tutti i ritornelli possibili sceglie It Ain't Me. Così su Real Live abbiamo la possibilità di sentire ventimila inglesi che cantano all'unisono: Non sono io, babe. No, no, no, non sono io babe, quello che stai cercando. Quanti in quel momento avranno fatto caso all'ironia?
Sull'erba dello stadio della nazionale inglese c'era gente che lo seguiva ormai da vent'anni: quattro lustri passati a sentirlo cantare che non avrebbe più lavorato per la Fattoria di Maggie. All'inizio magari Maggie erano gli hipster del folk metropolitano che pretendevano che Dylan non giocasse con le chitarre elettriche, o l'industria musicale che pretendeva da lui due dischi all'anno, o il movimento dei diritti civili che voleva arruolarlo come tamburino. In seguito avevano cantato I ain't gonna work for Maggie's Farm i ragazzi americani che non volevano andare in Vietnam e quelli britannici che protestavano contro il governo di Margareth, "Maggie" Thatcher. L'avevano incisa persino gli Specials. L'avrebbero suonata dal vivo anche gli U2. E Dylan nell'estate 1984 poteva forse esimersi? Così in Real Live lo sentiamo cantare, per la duecentoventesima volta dal vivo, che non ha intenzione di lavorare più per quella fattoria (220 non è un numero a caso). No More! Anche in questo caso, l'ironia sembra inconsapevole, o al limite svagata come può essere svagato l'attore che recita per la 220sima volta la stessa barzelletta - sarebbe strano se la trovasse ancora divertente.
Real Live è uno di quei dischi che ti domandi se Dylan si ricorda di averli pubblicati. Uno degli articoli del suo catalogo di cui è più facile dimenticarsi, così com'è difficile dimenticarsi di quel tour (che pure fu il primo in cui calò in Italia). In quell'estate del 1984 Dylan non cantava né troppo male né particolarmente bene; gli arrangiamenti non erano né postpunk come quelli sperimentati al Letterman Show, né gospel, né barocchi come ai tempi del World Tour, né fracassoni come quelli della Revue. È un robusto rock da stadio, impreziosito da una gloriosa ospitata di Carlos Santana in Tombstone Blues. È uno di quei dischi live che all'inizio passa quasi inosservato, ma poi invecchia in modo dignitoso. Come nel caso di At Budokan e Hard Rain, c'è una specie di difficoltà iniziale da superare, che facilmente poteva irrigidire i primi recensori: nei primi brani Dylan deve ancora scaldarsi, e non lo aiuta il fatto di dover cantare per la duecentesima volta che Abramo deve uccidere suo figlio sull'Highway 61, e che non ha intenzione di ripresentarsi a quella maledetta fattoria. (E sta succedendo qualcosa e non sai cos'è, figurati: dopo vent'anni ancora stai lì a domandarti cosa succede, Mr Jones?) Uno ovviamente può anche retoricamente chiedersi: ma ha senso pubblicare un live del genere, il quarto in dieci anni?
Un senso c'è sempre, almeno dal punto di vista commerciale... (continua sul Post)
Ignoranti e felici, il film
14-08-2017, 03:0521tw, blog, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, fb2020, film italiani bruttini, internetPermalinkBeata ignoranza (Massimiliano Bruno, 2017)
Riuscireste a vivere due mesi senza connessioni internet? Sì, ma sarebbe un po' scomodo. Se non aveste mai usato internet, riuscireste a diventarne dipendenti nel giro di una settimana? È abbastanza improbabile. Ve li immaginate Giallini e Gassman professori di liceo, uno tecnopatico e l'altro entusiasta digitale, che si scambiano i ruoli? Uhm, in realtà no. Ecco, beh, non ci sono riusciti neanche gli sceneggiatori di Beata ignoranza: non esattamente gli ultimi arrivati, eppure.
In questi giorni sulla mia bacheca Facebook non fanno che parlare di Sarahah. Da quel che ho capito si tratta di un social network che ti consente di ricevere e mandare messaggi anonimi agli altri utenti. Lo ripeto perché secondo me è fortissimo: in questi giorni stanno tutti provando un nuovo servizio on line che - straordinaria novità! - ti fa sentire l'ebrezza di ricevere e mandare messaggi anonimi. Sono quelle cose che mi fanno sentire decrepito, perché mi ricordo ancora bene quando tutta internet era così, un posto di anonimi che si mandavano messaggi (l'anno scorso Facebook mi ha sospeso perché il mio secondo nome non gli risultava) (in effetti il mio secondo nome, tra Leonardo e il mio cognome, era Blogspot, e finché non l'ho cancellato non mi ha riaperto l'account, che evidentemente deve combaciare con quello che risulta all'anagrafe, il che è abbastanza inquietante: avrei potuto sbattere la porta e andarmene, ma la verità è che senza il mio account Facebook ormai farei persino fatica a lavorare) (sì, a lavorare a scuola).
Ho tirato fuori Sarahah e Facebook non perché non abbia voglia di parlare del film - alla fine è un film interessante, per quanto sballato - sembra concepito da qualcuno vecchio come me, salvo che dopo essersi preso male coi blog anonimi verso il 2004 ha chiuso il pc per sempre e non ha più cambiato la sua idea di internet. E nel 2016 ci ha scritto un film. In cui Marco Giallini interpreta un professore che non è mai stato on line in vita sua e per carità, esistono, ne conosciamo tutti, è più che giusto mostrarli nei film. Questo professore dall'oggi al domani, per una scommessa, viene dotato di adsl, di account sociali e quant'altro ed evidentemente anche di amici e followers, perché dopo una settimana sta già chattando a tutt'andare. Un po' curioso, ma si sa che nelle commedie si esagera, no? L'idea portante del film doveva essere appunto questa: mostrare un tizio che diventa dipendente da internet nel giro di pochi giorni (mentre il suo rivale speculare, Gassman, dovrebbe fare il percorso inverso). Era una idea interessante? Magari sì, ma a un certo punto qualcosa dev'essere andato storto, e basta vedere dieci minuti di film per accorgersene.
È un film veramente strano. Sembra essere stato masticato, risputato e rimesso nel vassoio da un cameriere impassibile - che purtroppo è Massimiliano Bruno, da cui sembra ovvio aspettarsi di più. Per dire: tutto comincia con una scena in cui Gassman e Giallini litigano in classe - davanti ai loro studenti! che riprendono tutto col cellulare! Dovrebbe essere lo snodo fondamentale, la crisi da cui scaturisce tutta la storia, epperò in quel momento i due attori principali non sono credibili. Si prendono a male parole, ma c'è qualcosa che stona ed è strano, è chiaro che nessuno dei due è Lawrence Olivier, ma qui sono davvero al di sotto dei loro standard professionali. Più tardi scopriremo che l'effetto era voluto: non stanno litigando davvero, bensì stanno rimettendo in scena un loro litigio precedente; cioè stanno recitando nel ruolo di due attori. Ma non sono bravi attori - cioè, no, Giallini e Gassman sono ottimi attori, ma i loro personaggi no, sono due ex filodrammatici, insomma se uno ha la pazienza di aspettare 80 minuti scopre che all'inizio stavano recitando bene il ruolo di chi recita male. Il problema è che al cinema è anche una questione di imprinting: se tu all'inizio vedi dei cani, ci resti male, e la tua voglia di dare una chance al film ne risente.
Da quel litigio parte la scommessa: Gassman deve rinunciare a smartphone e adsl, Giallini deve cominciare a usarli. Ora non importa tanto che lo sforzo degli autori di rendere una sfida del genere credibile porti viceversa il film nel Reame del Più Contorto Inverosimile (la figlia di uno dei due, non è chiaro di quale, fa la regista! e decide di fare un documentario sulla sfida! Appassionante, no?) Il guaio è che appunto il film sembra scritto da qualcuno che si è disintossicato da internet una decina di anni fa e da allora lo guarda un po' da lontano, con sospetto, come i vegani trascinati in un ristorante di pesce. C'è un preside tutto orgoglioso perché il suo liceo è diventato "smart" grazie all'adozione del registro elettronico! Che roba, eh? Peccato che il registro elettronico sia obbligatorio in tutte le scuole pubbliche da un paio d'anni. Ma più in generale: quali sono le cose che facciamo quotidianamente, oggi, grazie a internet? Le prime che mi vengono in mente: usiamo le mappe stradali. Recensiamo qualsiasi cosa. Manteniamo i contatti con gente che avremmo perso di vista da un pezzo. Incontriamo gente che non avremmo mai potuto conoscere, con la quale condividiamo interessi. Possiamo lavorare a Ferragosto, anche se siamo al mare, come sto facendo io. E i giovani, mi dicono, guardano molto più porno (continua su +eventi...)
Giallini non consulta mappe, porno men che meno, non compra né vende né scrive recensioni (si prende solo venti secondi per stroncare Tripadvisor in toto), non riallaccia nessun contatto, non si pone neanche il problema di come usare internet nel suo ambito professionale. Però si mette a giocare con un suo allievo ripetente a uno sparatutto per playstation. Da professore a gamer in punto in bianco... e va bene, le commedie esagerano. Che altro fa? Corteggia una sua collega... con un nick anonimo. Nel 2017. Non so. È come usare la macchina per attraversare la strada. Se non avessi mai usato facebook, qual è la prima cosa che farei? Storicamente, un sacco di gente cercava gli ex compagni del liceo, e poi è restata perché ha trovato vecchi amici e se ne fa di nuovi. Non sarebbe stato più credibile che Giallini si mettesse a cercare vecchie fiamme, o scoprisse anime gemelle a migliaia di chilometri di distanza? Devi usare facebook per scrivere i bigliettini? Qualcuno lo usa ancora così?
Secondo me no, ma forse non ha nemmeno così senso discuterne. Credo che i primi ad aver capito che la premessa non funzionava sono stati gli stessi autori, che probabilmente hanno riprovato a riscriverlo, a ritagliarlo, a rimontarlo, e poi forse c'era una scadenza in ballo e semplicemente hanno lasciato che Giallini e Gassman gigionassero a piacere, in barba a qualsiasi vaga pretesa di verosimiglianza (si odiano da una vita, non si vedono da 25 anni e al primo problema uno ospita l'altro in casa). Il risultato è un film molto più borisiano di Boris - o magari dello stesso genere del film nel film di Boris, Natale con la Casta: ci sono sequenze quasi surreali, a volte anche molto sofisticate, che portano avanti una trama risibile; situazioni drammatiche ai limiti della tragedia e oltre buttate lì come se fossero gag da cartone animato (a un certo punto esplode una casa); siparietti scolastici che in qualsiasi scuola vera provocherebbero ispezioni e licenziamenti (nella scuola di Beata ignoranza è prassi comune schiaffeggiare gli studenti); c'è persino lo spettro di una defunta moglie amante e madre interpretata proprio da Carolina Crescentini, icona di Boris. Ci sono, soprattutto, un paio di caratteristi che si fanno le canne dall'inizio alla fine del film, il che non è affatto inverosimile, anzi, ma assume un senso preciso nel momento in cui ci rendiamo conto che in realtà sono i due personaggi più lucidi: come se il film fosse visto secondo il loro punto di vista e probabilmente è andata davvero così. Probabilmente c'era un'idea interessante che stava evolvendosi in un film inutile, una scadenza importante che cominciava a mettere ansia, qualcuno che aveva parecchia maria in casa e ha iniziato a distribuirne, e così insomma alla fine ne è uscito un film un po' così. Però simpatico. Gli attori sono molto simpatici. Non si capisce nemmeno chi vince la scommessa, cioè si capisce che la scommessa non era così importante, l'importante è voler bene a chi ami anche se non fa sempre figli con te. Inoltre farsi le canne è meglio che andare su facebook, e vabbe', non è il messaggio più reazionario del mondo in fin dei conti. Dai dai dai.
Beata ignoranza si può vedere gratis a Bra il 17 agosto in via Sobrero, alle 21:30, in occasione della Rassegna itinerante di cinema d'autore. Altrimenti il 25 agosto a Limone Piemonte (ore 21:15). Oppure su Youtube a partire da €3,99.
Riuscireste a vivere due mesi senza connessioni internet? Sì, ma sarebbe un po' scomodo. Se non aveste mai usato internet, riuscireste a diventarne dipendenti nel giro di una settimana? È abbastanza improbabile. Ve li immaginate Giallini e Gassman professori di liceo, uno tecnopatico e l'altro entusiasta digitale, che si scambiano i ruoli? Uhm, in realtà no. Ecco, beh, non ci sono riusciti neanche gli sceneggiatori di Beata ignoranza: non esattamente gli ultimi arrivati, eppure.
In questi giorni sulla mia bacheca Facebook non fanno che parlare di Sarahah. Da quel che ho capito si tratta di un social network che ti consente di ricevere e mandare messaggi anonimi agli altri utenti. Lo ripeto perché secondo me è fortissimo: in questi giorni stanno tutti provando un nuovo servizio on line che - straordinaria novità! - ti fa sentire l'ebrezza di ricevere e mandare messaggi anonimi. Sono quelle cose che mi fanno sentire decrepito, perché mi ricordo ancora bene quando tutta internet era così, un posto di anonimi che si mandavano messaggi (l'anno scorso Facebook mi ha sospeso perché il mio secondo nome non gli risultava) (in effetti il mio secondo nome, tra Leonardo e il mio cognome, era Blogspot, e finché non l'ho cancellato non mi ha riaperto l'account, che evidentemente deve combaciare con quello che risulta all'anagrafe, il che è abbastanza inquietante: avrei potuto sbattere la porta e andarmene, ma la verità è che senza il mio account Facebook ormai farei persino fatica a lavorare) (sì, a lavorare a scuola).
 |
| La vignetta più riprodotta del New Yorker è del 1993. Dice: "Su internet, nessuno sa che sei un cane". |
È un film veramente strano. Sembra essere stato masticato, risputato e rimesso nel vassoio da un cameriere impassibile - che purtroppo è Massimiliano Bruno, da cui sembra ovvio aspettarsi di più. Per dire: tutto comincia con una scena in cui Gassman e Giallini litigano in classe - davanti ai loro studenti! che riprendono tutto col cellulare! Dovrebbe essere lo snodo fondamentale, la crisi da cui scaturisce tutta la storia, epperò in quel momento i due attori principali non sono credibili. Si prendono a male parole, ma c'è qualcosa che stona ed è strano, è chiaro che nessuno dei due è Lawrence Olivier, ma qui sono davvero al di sotto dei loro standard professionali. Più tardi scopriremo che l'effetto era voluto: non stanno litigando davvero, bensì stanno rimettendo in scena un loro litigio precedente; cioè stanno recitando nel ruolo di due attori. Ma non sono bravi attori - cioè, no, Giallini e Gassman sono ottimi attori, ma i loro personaggi no, sono due ex filodrammatici, insomma se uno ha la pazienza di aspettare 80 minuti scopre che all'inizio stavano recitando bene il ruolo di chi recita male. Il problema è che al cinema è anche una questione di imprinting: se tu all'inizio vedi dei cani, ci resti male, e la tua voglia di dare una chance al film ne risente.
Da quel litigio parte la scommessa: Gassman deve rinunciare a smartphone e adsl, Giallini deve cominciare a usarli. Ora non importa tanto che lo sforzo degli autori di rendere una sfida del genere credibile porti viceversa il film nel Reame del Più Contorto Inverosimile (la figlia di uno dei due, non è chiaro di quale, fa la regista! e decide di fare un documentario sulla sfida! Appassionante, no?) Il guaio è che appunto il film sembra scritto da qualcuno che si è disintossicato da internet una decina di anni fa e da allora lo guarda un po' da lontano, con sospetto, come i vegani trascinati in un ristorante di pesce. C'è un preside tutto orgoglioso perché il suo liceo è diventato "smart" grazie all'adozione del registro elettronico! Che roba, eh? Peccato che il registro elettronico sia obbligatorio in tutte le scuole pubbliche da un paio d'anni. Ma più in generale: quali sono le cose che facciamo quotidianamente, oggi, grazie a internet? Le prime che mi vengono in mente: usiamo le mappe stradali. Recensiamo qualsiasi cosa. Manteniamo i contatti con gente che avremmo perso di vista da un pezzo. Incontriamo gente che non avremmo mai potuto conoscere, con la quale condividiamo interessi. Possiamo lavorare a Ferragosto, anche se siamo al mare, come sto facendo io. E i giovani, mi dicono, guardano molto più porno (continua su +eventi...)
Giallini non consulta mappe, porno men che meno, non compra né vende né scrive recensioni (si prende solo venti secondi per stroncare Tripadvisor in toto), non riallaccia nessun contatto, non si pone neanche il problema di come usare internet nel suo ambito professionale. Però si mette a giocare con un suo allievo ripetente a uno sparatutto per playstation. Da professore a gamer in punto in bianco... e va bene, le commedie esagerano. Che altro fa? Corteggia una sua collega... con un nick anonimo. Nel 2017. Non so. È come usare la macchina per attraversare la strada. Se non avessi mai usato facebook, qual è la prima cosa che farei? Storicamente, un sacco di gente cercava gli ex compagni del liceo, e poi è restata perché ha trovato vecchi amici e se ne fa di nuovi. Non sarebbe stato più credibile che Giallini si mettesse a cercare vecchie fiamme, o scoprisse anime gemelle a migliaia di chilometri di distanza? Devi usare facebook per scrivere i bigliettini? Qualcuno lo usa ancora così?
Secondo me no, ma forse non ha nemmeno così senso discuterne. Credo che i primi ad aver capito che la premessa non funzionava sono stati gli stessi autori, che probabilmente hanno riprovato a riscriverlo, a ritagliarlo, a rimontarlo, e poi forse c'era una scadenza in ballo e semplicemente hanno lasciato che Giallini e Gassman gigionassero a piacere, in barba a qualsiasi vaga pretesa di verosimiglianza (si odiano da una vita, non si vedono da 25 anni e al primo problema uno ospita l'altro in casa). Il risultato è un film molto più borisiano di Boris - o magari dello stesso genere del film nel film di Boris, Natale con la Casta: ci sono sequenze quasi surreali, a volte anche molto sofisticate, che portano avanti una trama risibile; situazioni drammatiche ai limiti della tragedia e oltre buttate lì come se fossero gag da cartone animato (a un certo punto esplode una casa); siparietti scolastici che in qualsiasi scuola vera provocherebbero ispezioni e licenziamenti (nella scuola di Beata ignoranza è prassi comune schiaffeggiare gli studenti); c'è persino lo spettro di una defunta moglie amante e madre interpretata proprio da Carolina Crescentini, icona di Boris. Ci sono, soprattutto, un paio di caratteristi che si fanno le canne dall'inizio alla fine del film, il che non è affatto inverosimile, anzi, ma assume un senso preciso nel momento in cui ci rendiamo conto che in realtà sono i due personaggi più lucidi: come se il film fosse visto secondo il loro punto di vista e probabilmente è andata davvero così. Probabilmente c'era un'idea interessante che stava evolvendosi in un film inutile, una scadenza importante che cominciava a mettere ansia, qualcuno che aveva parecchia maria in casa e ha iniziato a distribuirne, e così insomma alla fine ne è uscito un film un po' così. Però simpatico. Gli attori sono molto simpatici. Non si capisce nemmeno chi vince la scommessa, cioè si capisce che la scommessa non era così importante, l'importante è voler bene a chi ami anche se non fa sempre figli con te. Inoltre farsi le canne è meglio che andare su facebook, e vabbe', non è il messaggio più reazionario del mondo in fin dei conti. Dai dai dai.
Beata ignoranza si può vedere gratis a Bra il 17 agosto in via Sobrero, alle 21:30, in occasione della Rassegna itinerante di cinema d'autore. Altrimenti il 25 agosto a Limone Piemonte (ore 21:15). Oppure su Youtube a partire da €3,99.
Comments (4)














