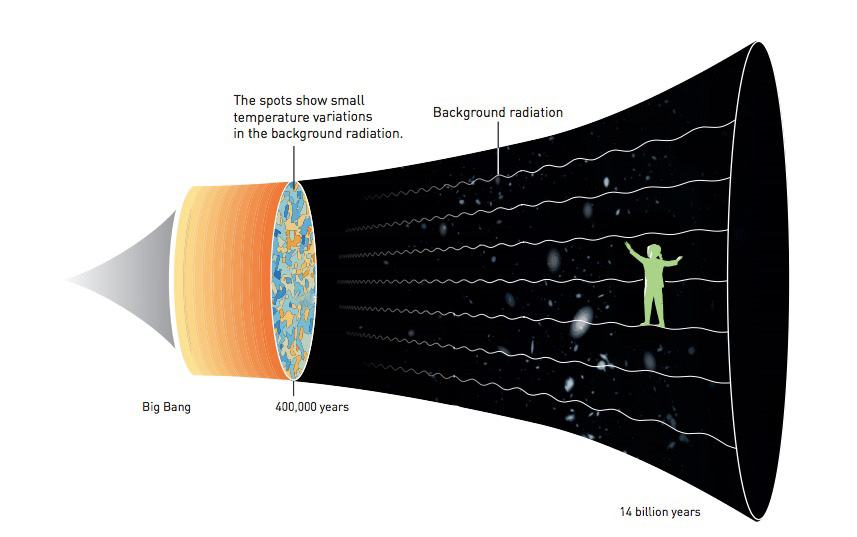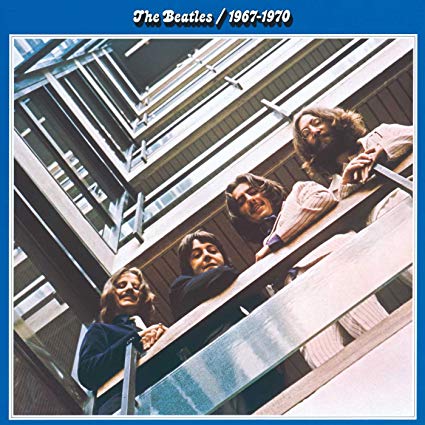Le canzoni dei Beatles (#30-21)
30-07-2020, 02:21beatles, musicaPermalinkBuongiorno a tutti, ormai siamo in dirittura d'arrivo. A proposito, secondo voi qual è il disco migliore dei Beatles? Perché Sgt Pepper, ci avete fatto caso? È ancora in gara con un pezzo soltanto. Mentre Revolver, per dire, ne ha tre. Ma anche Rubber Soul ne ha tre. Anche Abbey Road. Invece Help! ne ha quattro. Buffo, vero?
Ricordo a tutti che la classifica non la faccio io, anzi io mi dissocio formalmente, è la media di tutte le classifiche redatte dai giornalisti musicali, credo che li assumano soltanto se dimostrano di non percepire la differenza tra Il flauto magico e una mietitrebbia.
Puntate precedenti: (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#200-181), (#180-166), (#165-156), (#155-146), (#145-136), (#135-121), (#120-111), (#110-96), (#95-86), (#85-76), (#75-66), (#65-56), (#55-46), (#45-36)
30. Nowhere Man (Lennon-McCartney, Rubber Soul, 1965).
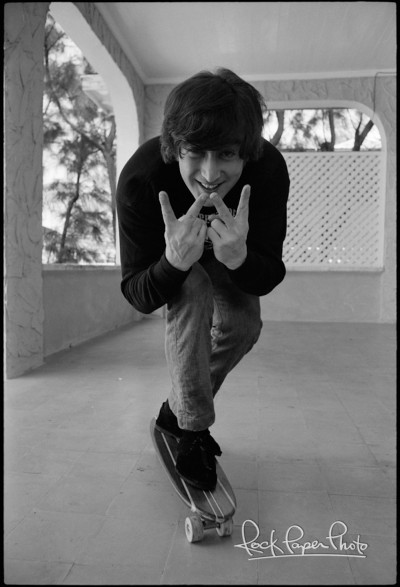 Uomo di Nessun Dove, il mondo aspetta i tuoi ordini. Quando lo andò a trovare qualche mese dopo, nella sua villa di Weybridge, la giornalista Maureen Cleave trovò un John Lennon sospeso tra inquietudine e apatia, isolato dal mondo in un villino ingombro di elettrodomestici e gadget di cui si era stancato a volte prima di scartarli. Lennon non poteva rinunciare a dire spiritosaggini – era il suo personaggio – e a un certo punto gli scappò detto che non vedeva molto futuro per il cristianesimo, forse non sarebbe sopravvissuto neanche ai Beatles. Una battuta a cui in Inghilterra nessuno fece caso, ma che ripresa dalla stampa americana alla vigilia di un tour scatenò una delle prime shitstorm di cui la storia del costume sia a conoscenza: minacce di morte, roghi di dischi, eccetera. L'intervista della Cleave è passata alla storia per quella battuta, ma rimane anche un bell'esercizio su quello che stava per diventare un topos giornalistico: il ritratto della giovane rockstar alienata. La stanza dei giocattoli, le auto di lusso che Lennon compra e rivende perché ha paura di spendere tutti i soldi che guadagna, salvo ricomprarle subito dopo... è tutto già così perfetto e familiare da seminare un dubbio: non è che Lennon stesse recitando, come aveva sempre fatto davanti ai microfoni dei giornalisti? Era davvero così compreso nel suo ruolo di divo con piscina e Rolls Royce, o non stava semplicemente dando al pubblico quello che il pubblico si aspettava da lui, quello che il pubblico si aspetta ancora oggi, un'ostentazione spudorata di status symbol, tratti eccentrici e sintomi di alienazione? Essendo inglese non poteva candidarsi alla Casa Bianca come Kanye West; si limitò a un po' di dissing su Gesù Cristo. Non stava semplicemente fornendo ai fan una specie di tableau vivente del brano che era appena uscito come singolo negli USA, Nowhere Man?
Uomo di Nessun Dove, il mondo aspetta i tuoi ordini. Quando lo andò a trovare qualche mese dopo, nella sua villa di Weybridge, la giornalista Maureen Cleave trovò un John Lennon sospeso tra inquietudine e apatia, isolato dal mondo in un villino ingombro di elettrodomestici e gadget di cui si era stancato a volte prima di scartarli. Lennon non poteva rinunciare a dire spiritosaggini – era il suo personaggio – e a un certo punto gli scappò detto che non vedeva molto futuro per il cristianesimo, forse non sarebbe sopravvissuto neanche ai Beatles. Una battuta a cui in Inghilterra nessuno fece caso, ma che ripresa dalla stampa americana alla vigilia di un tour scatenò una delle prime shitstorm di cui la storia del costume sia a conoscenza: minacce di morte, roghi di dischi, eccetera. L'intervista della Cleave è passata alla storia per quella battuta, ma rimane anche un bell'esercizio su quello che stava per diventare un topos giornalistico: il ritratto della giovane rockstar alienata. La stanza dei giocattoli, le auto di lusso che Lennon compra e rivende perché ha paura di spendere tutti i soldi che guadagna, salvo ricomprarle subito dopo... è tutto già così perfetto e familiare da seminare un dubbio: non è che Lennon stesse recitando, come aveva sempre fatto davanti ai microfoni dei giornalisti? Era davvero così compreso nel suo ruolo di divo con piscina e Rolls Royce, o non stava semplicemente dando al pubblico quello che il pubblico si aspettava da lui, quello che il pubblico si aspetta ancora oggi, un'ostentazione spudorata di status symbol, tratti eccentrici e sintomi di alienazione? Essendo inglese non poteva candidarsi alla Casa Bianca come Kanye West; si limitò a un po' di dissing su Gesù Cristo. Non stava semplicemente fornendo ai fan una specie di tableau vivente del brano che era appena uscito come singolo negli USA, Nowhere Man?
Quando non faceva il matto davanti ai giornalisti e non era in tour da qualche parte, John aveva pur sempre un gruppo da portare avanti. La tabella era sempre quella concordata con Brian Epstein tre anni prima: due album e quattro singoli all'anno. Ormai ci si aspettava che gli album fossero composti tutti di materiale originale, che non si scriveva da solo, per cui no: Lennon non è che non stesse facendo nulla tutto il giorno. Il problema dell'artista (e soprattutto di chi gli vive intorno) è che è quasi impossibile distinguere i momenti in cui sta creando da quelli in cui sta cazzeggiando. Si capisce che gironzolare mezzo fatto per la casa non restituisce una buona impressione di te, ma se sei il tizio che scrive le canzoni di Lennon-McCartney può darsi che sia il modo più proficuo di passare il tempo.Un buon esempio è proprio la leggenda di Nowhere Man: dopo cinque ore passate a cercare una canzone che non gli veniva, Lennon si butta sul letto, comincia a osservare dall'esterno quel sé stesso che si dibatte tra noia e velleità, ed eureka: ecco Nowhere Man. Quando non riesci a trovare niente da dire, puoi sempre mettere in scena te stesso che non riesce a trovare niente. Due anni prima Federico Fellini ci aveva fatto un film: Nowhere Man è l'8 e 1/2 di Lennon.
 Né dobbiamo credere per forza che le ore passate prima di buttarsi a letto fossero state infruttuose: magari le aveva passate ad ascoltare qualche disco d'importazione. In febbraio negli USA era uscito Bringing It All Back Home, il disco in cui Dylan suonava per la prima volta con una band. Ma il brano che probabilmente doveva averlo colpito di più era ancora acustico: si chiamava Mr Tambourine Man. In marzo poi un gruppo californiano aveva pubblicato la sua versione 'elettrica' di Mr Tambourine Man: si facevano chiamare Byrds e le loro chitarre ricordavano smaccatamente la 12 corde usata da George Harrison in Ticket to Ride: insomma se Lennon avesse voluto copiarli, non avrebbe che "riportato tutto a casa".
Né dobbiamo credere per forza che le ore passate prima di buttarsi a letto fossero state infruttuose: magari le aveva passate ad ascoltare qualche disco d'importazione. In febbraio negli USA era uscito Bringing It All Back Home, il disco in cui Dylan suonava per la prima volta con una band. Ma il brano che probabilmente doveva averlo colpito di più era ancora acustico: si chiamava Mr Tambourine Man. In marzo poi un gruppo californiano aveva pubblicato la sua versione 'elettrica' di Mr Tambourine Man: si facevano chiamare Byrds e le loro chitarre ricordavano smaccatamente la 12 corde usata da George Harrison in Ticket to Ride: insomma se Lennon avesse voluto copiarli, non avrebbe che "riportato tutto a casa".
Alcune caratteristiche formali di Nowhere Man si spiegano proprio se si confrontano con quello che stava succedendo negli USA: per la prima volta un bridge compare tre volte (ciononostante la canzone è ancora breve rispetto ai modelli dylaniani). Le chitarre danno la loro versione del jingle-jangle byrdiano: Paul ricorda con soddisfazione di avere costretto i tecnici del suono a oltrepassare i limiti della strumentazione disponibile, facendo passare le chitarre da un amplificatore intermedio per aumentare le frequenze alte oltre il consentito. Persino la scelta di non correggere la lieve dissonanza tra il coro iniziale e gli strumenti in entrata potrebbe essere un tentativo di aggiornarsi al suono 'sporco' che negli USA era l'ultimissima novità – Dylan in studio a volte non si preoccupava nemmeno di accordare la chitarra, e Dylan era la cosa più hip che ci fosse. Si dice che Nowhere Man sia il primo brano dei Beatles che non parli d'amore: in superficie è proprio così, ma dopotutto è una canzone di John su sé stesso: c'è più amore qui che in Day Tripper. Qualche anno più tardi Dylan avrebbe spiegato in un'altra celebre intervista che molte canzoni che credeva di dedicare agli altri, in realtà erano rivolte a sé stesso. Lennon, mentre fissava il soffitto della sua camera da letto di Weybridge, lo aveva già capito.
29. Rain (Lennon-McCartney, lato B di Paperback Writer).
Sempre a Weybridge una sera, dopo essersi rollato un joint, Lennon spinge un bottone perché vuole riascoltare il brano a cui sta lavorando. Viene investito da una canzone mai sentita: eppure è lui che canta, anche se è come se chiamasse da un mondo al di là dello specchio. Rimane perplesso per qualche istante (il joint in mano), prima di capire: ha montato la bobina a rovescio, sta ascoltando l'esatto contrario di quello che ha inciso ad Abbey Road. Niente di così strano, tranne che la canzone gli piaceva di più così.
Il giorno dopo cerca di spiegare ai colleghi e a George Martin che Rain suona meglio alla rovescio. Alla fine Martin acconsentirà ad inserire almeno un frammento invertito della traccia vocale di John nel finale (nei video musicali che vengono girati, John dovrà mimare anche questa traccia invertita). È un episodio famoso forse più di quanto meriti – di tante innovazioni tentate con Rain, la voce alla rovescio è la più appariscente ma la meno incisiva. L'episodio fotografa comunque un John Lennon che dopo tre anni di esperienza vive ancora la sala prove come una stanza di giocattoli da smontare alla ricerca di qualche effetto inatteso e divertente. È anche il sintomo di una resa: su Rain si poteva osare di più perché in fondo era chiaro dall'inizio che sarebbe stato solo un Lato B. È come se dopo il passo falso di Day Tripper, Lennon cominci a ritirarsi in un ghetto creativo: se Paul davvero vende di più, John diventerà l'anima sperimentale della band (il ruolo che in precedenza Harrison aveva iniziato a ritagliarsi).
Rain è un brano che dà sempre l'impressione di restare un po' nascosto – per quanto possa restare nascosto un brano dei Beatles. C'è un motivo semplice: era un lato B, appunto, e Allen Klein non volle inserire lati B nell'antologia ufficiale del periodo 1962-66, il cosiddetto Disco Rosso. Lo spazio c'era, ma in effetti Rain, che pure è il brano in cui Ringo Starr ritiene di avere dato il meglio di sé, non è quel tipo di canzone che metteresti in vetrina. Gli è perfettamente congeniale la sua dimensione di lato B, che oggi non possiamo più percepire: se nei primi anni della Beatlemania il lato B era quello dedicato al lento, verso la metà degli anni Sessanta ormai dedicare tempo all'ascolto dei lati B era la forma di snobismo più a buon mercato cui i giovani consumatori di musica potessero accedere. Il lato B era diventato lo spazio per gli intenditori: se il lato A era la vetrina, il B era il retrobottega dove gli esercenti tenevano da parte per la clientela più affezionata le cose veramente buone o comunque un insolite, non per tutti. E cosa c'era di 'buono ma non per tutti', all'inizio dell'anno di grazia 1966, nel menu dei Beatles? Un brano volutamente sfuocato, compresso, saturato che dà l'impressione di rallentare in corsa finché a un certo punto non è più un'impressione: rallenta davvero. Il ritornello, anche se non ha nulla di specificatamente indiano, comincia a suonare come un mantra.
 Anche l'idea di accelerare o rallentare le tracce vocali e strumentali non l'hanno inventata i Beatles – è sempre stata un'opzione, sin dall'invenzione del fonografo. Alcuni musicologi sono convinti che le registrazioni degli anni '20 di Robert Johnson siano accelerate del 20%: per un secolo tutti gli apprendisti blues e poi rock avrebbero tentato di imitare uno stile molto più svelto del suo. Ma prima dei Beatles era un trucco tenere i dischi più brevi e farli suonare meglio; ai limiti un gioco per divertire i bambini (i Chipmunks prima ancora di diventare personaggi televisivi erano un gruppo vocale che registrava cover accelerate). Con i Beatles il trucco diventa una tecnica, esplorata in tutte le sue potenzialità e a volte persino esibita. In Rain Lennon chiede a Martin di rallentare gli strumenti e accelerargli la voce; del resto è la canzone che parla di un uomo che non vive alla velocità degli altri, e non capisce più l'affanno di chi ancora subisce il tempo atmosferico ("posso mostrarti che è solo uno stato della mente", ok John, io l'ombrello comunque me lo porterei). È l'equivalente musicale di quei video girati in time-lapse in cui una persona quasi ferma si staglia su uno sfondo di persone o automobili che sciama a velocità rapidissima. Sui forum di fotografia qualcuno lo chiama "effetto Koyaanisqatsi", dal nome del celebre film sperimentale che negli anni '80 rese popolare il time-lapse. La progressione armonica è più semplice del solito – come del resto nel brano in vetrina, Paperback Writer: la sperimentazione della coppia Lennon-McCartney si è spostata dagli accordi ai suoni e ai nastri; ormai i loro veri strumenti sono gli amplificatori, gli equalizzatori, i magnetofoni a bobina. Non c'è più nulla che non si possa fare: la pioggia può suonare come il sole, è tutto uno stato della mente.
Anche l'idea di accelerare o rallentare le tracce vocali e strumentali non l'hanno inventata i Beatles – è sempre stata un'opzione, sin dall'invenzione del fonografo. Alcuni musicologi sono convinti che le registrazioni degli anni '20 di Robert Johnson siano accelerate del 20%: per un secolo tutti gli apprendisti blues e poi rock avrebbero tentato di imitare uno stile molto più svelto del suo. Ma prima dei Beatles era un trucco tenere i dischi più brevi e farli suonare meglio; ai limiti un gioco per divertire i bambini (i Chipmunks prima ancora di diventare personaggi televisivi erano un gruppo vocale che registrava cover accelerate). Con i Beatles il trucco diventa una tecnica, esplorata in tutte le sue potenzialità e a volte persino esibita. In Rain Lennon chiede a Martin di rallentare gli strumenti e accelerargli la voce; del resto è la canzone che parla di un uomo che non vive alla velocità degli altri, e non capisce più l'affanno di chi ancora subisce il tempo atmosferico ("posso mostrarti che è solo uno stato della mente", ok John, io l'ombrello comunque me lo porterei). È l'equivalente musicale di quei video girati in time-lapse in cui una persona quasi ferma si staglia su uno sfondo di persone o automobili che sciama a velocità rapidissima. Sui forum di fotografia qualcuno lo chiama "effetto Koyaanisqatsi", dal nome del celebre film sperimentale che negli anni '80 rese popolare il time-lapse. La progressione armonica è più semplice del solito – come del resto nel brano in vetrina, Paperback Writer: la sperimentazione della coppia Lennon-McCartney si è spostata dagli accordi ai suoni e ai nastri; ormai i loro veri strumenti sono gli amplificatori, gli equalizzatori, i magnetofoni a bobina. Non c'è più nulla che non si possa fare: la pioggia può suonare come il sole, è tutto uno stato della mente.
28. Here, There and Everywhere (Lennon-McCartney, Revolver, 1966).
"Per vivere una vita migliore ho bisogno che il mio amore sia qui..." è abbastanza significativo che la canzone che parla della necessità di non separarsi mai dall'amata ("ogni giorno dell'anno") provenga dall'unico Beatle che nel 1966 viveva felicemente scapolo. Mentre John deve "nascondere il suo amore" e ricorrere a giri di parole sempre più immaginifici per cantare le sue avventure senza insospettire Cynthia, Paul è libero di uscire e tornare a casa all'ora che vuole, e se non ha sonno mettersi a fantasticare di come sarebbe bello avere lei in ogni giorno dell'anno. Ci può anche scrivere una canzone senza che nessuno venga a disturbarlo. Ma cosa significa scrivere una canzone? Per Paul è spesso una questione strutturale: si tratta di costruire un piccolo mondo, anche solo un appartamento.
Tra le caratteristiche inconfondibili dei giovane compositore McCartney c'è l'abitudine a variare la progressione armonica nel bel mezzo della strofa creando nell'ascoltatore un effetto sorpresa (i compositori suoi coetanei, se riescono ad azzeccare quattro accordi se li tengono, a volte per sicurezza non li cambiano nemmeno per il ritornello). Here There è l'esempio classico: si annuncia come canzoncina dolce dolce in quattro accordi, una scala ascendente lungo un intervallo di quarta (Sol, La-, Si-, Do) che ci fa desiderare di sbucare sul Re che completerebbe la quinta – e proprio quando ce l'aspettiamo Paul cambia tutto con Fa#-. Bisogna fare caso anche al testo: Paul ha appena detto "changing my life" e il Fa#- imprevisto avviene proprio "with a wave of her hand": scrivere canzoni non significa proprio costruire mondi che possono cambiare con un gesto della mano? È come se a un certo punto mentre ci mostrava il suo ménage immaginario, abbia aperto una porta e ci abbia condotto in una stanza diversa, da cui finalmente si accede al Re sospirato ma ormai inatteso.
E il bridge? È un'altra stanza ancora: per arrivarci si passa da uno strano scalino (Re-Fa-Sib) e quando per un attimo siamo convinti di esserci finalmente accomodati in una confortante 50s progression (Sib, Sol-, Do-), il quarto accordo è un Re7 e non sai più bene se sei nel vestibolo o nel salotto buono. Invece di accendere la luce Paul si è messo a intonare una melodia rétro ("and if she's beside me I know I need never care"); non fai in tempo ad ambientarti ("but to love her is to meet her...") che Paul accende la luce davvero e scopri che sei al punto di partenza! ("everywhere"). E non può non lasciarti ammirato il modo in cui il bridge si appoggia naturalmente sulla strofa successiva, persino dal punto di vista sintattico ("knowing that love is to share": non sono molte le canzoni in cui una frase comincia nel bridge e prosegue nel ritornello). Sei tornato da dove avevi cominciato, ma ora vedi tutto con un occhio diverso. Ci sono canzoni di McCartney che suscitano entusiasmo, affetto, malinconia, diffidenza (persino ripugnanza...): Here, There è la canzone che suscita ammirazione. Lennon la considerava una delle sue preferite non solo di McCartney, ma dei Beatles, e in effetti nel modo in cui il bridge trapassa immediatamente nella strofa riconosciamo un suo vecchio trucco di scena; a sua volta Lennon avrebbe fatto tesoro della principale suggestione di Here There, l'idea di una canzone che si rovescia in sé stessa come una scala di Escher. Il tratto distintivo più appariscente della canzone rimangono comunque i languidi coretti, un richiamo senza vergogna ai numeri dei crooner anni Quaranta. È uno dei rari casi in cui abbia ammesso un ripensamento, quando nel 1984 ripubblicò il brano nella colonna sonora di Give My Regards to Broad Street.
27. You've Got to Hide Your Love Away (Lennon-McCartney, Help!, 1965).
Eccomi qui, con la testa tra le mani. You've Got to Hide, lo dicono tutti, è la canzone in cui Lennon si rifà a Dylan. Diciamo pure che rifà Dylan: il timbro della voce rasenta la caricatura. È l'elemento più dylaniano di una canzone che non somiglia in particolare a nessun brano del Dylan folk – la parentela più probabile è con I Don't Believe You, in Another Side, che comincia con una rima molto simile, "I can't understand / she let go of my hand". In quegli anni la voce di Dylan era una sfida a tutto ciò che si poteva considerare radiofonicamente accettabile (un po' è ancora così: avete sentito per caso qualche brano del suo ultimo disco per radio?) Che i Beatles tentassero di imitarlo non era affatto scontato.
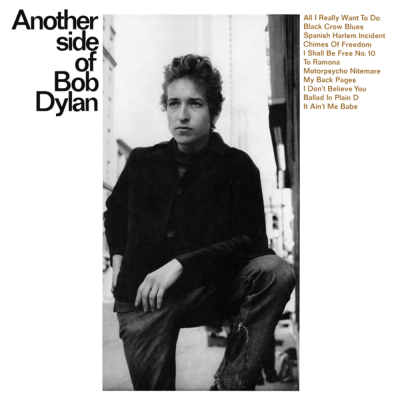 Dylan era un fenomeno di nicchia, anche in Inghilterra (dove la sua svolta rock avrebbe destato le reazioni peggiori nei fan): cominciava a essere un nome importante tra i frequentatori abituali dei negozi di dischi; era già il volto più celebre di quella cosa che di lì a poco si sarebbe cominciata a chiamare Controcultura; esibire i suoi dischi su mensole e tavolini conferiva già a studenti e professionisti un certa credibilità intellettuale. I Beatles, ormai onnipresenti sui media, giocavano in un altro campionato. Dylan avrebbe avuto tutti i motivi per disprezzare quei figurini venuti dal vecchio mondo a profanare la vera essenza dello spirito americano, la sua musica; invece li trovava fantastici sin dal primo momento impazziva proprio per le cose più smaccatamente pop, come I Want to Hold Your Hand, e non vedeva l'ora di incontrarli e fumarci assieme. Lennon dal canto suo avrebbe avuto più di un motivo per riservare a Dylan la stessa diffidenza che riservava ai coetanei che fino a quel momento potevano aspirare soltanto a porzioni della sua fama. Dylan in effetti è il più giovane tra gli autori che hanno avuto un peso rilevante nella sua formazione artistica: l'unico coetaneo che abbia preso a modello.
Dylan era un fenomeno di nicchia, anche in Inghilterra (dove la sua svolta rock avrebbe destato le reazioni peggiori nei fan): cominciava a essere un nome importante tra i frequentatori abituali dei negozi di dischi; era già il volto più celebre di quella cosa che di lì a poco si sarebbe cominciata a chiamare Controcultura; esibire i suoi dischi su mensole e tavolini conferiva già a studenti e professionisti un certa credibilità intellettuale. I Beatles, ormai onnipresenti sui media, giocavano in un altro campionato. Dylan avrebbe avuto tutti i motivi per disprezzare quei figurini venuti dal vecchio mondo a profanare la vera essenza dello spirito americano, la sua musica; invece li trovava fantastici sin dal primo momento impazziva proprio per le cose più smaccatamente pop, come I Want to Hold Your Hand, e non vedeva l'ora di incontrarli e fumarci assieme. Lennon dal canto suo avrebbe avuto più di un motivo per riservare a Dylan la stessa diffidenza che riservava ai coetanei che fino a quel momento potevano aspirare soltanto a porzioni della sua fama. Dylan in effetti è il più giovane tra gli autori che hanno avuto un peso rilevante nella sua formazione artistica: l'unico coetaneo che abbia preso a modello.
A Lennon non interessa copiare una progressione di accordi o altri trucchi del mestiere. La maggior parte continua a portarseli da casa (persino nel ritornello di questo 'pezzo folk' si annida la cara vecchia cadenza I-IV-V di Twist and Shout): gli interessava l'atteggiamento, un modo completamente diverso di porsi nei confronti del pubblico, e che rendeva credibili tutta una nuova gamma di sentimenti che fino a quel momento John non aveva mai tentato di mettere tra i solchi. You've Got to Hide ritrae un innamorato frustrato e senza speranza che in effetti somiglia all'eroe di molte ballate acustiche di Dylan. Ma è proprio a questo livello che possiamo misurare la distanza: per Dylan la frustrazione sentimentale è sempre una questione intima, che al limite può essere condivisa con l'oggetto del proprio amore sfortunato (e delle proprie recriminazioni, che Dylan protrae per strofe e strofe).
Per Lennon questa intimità non esiste: ogni sentimento è un fatto sociale che assume un senso solo se c'è un coro che ascolta, osserva, commenta, e in questo caso gli ride in faccia: ehi, bisogna che quell'amore te lo metti via. Esiste un amore se nessuno lo guarda? You've Got to Hide è il lato oscuro di I Feel Fine: se per essere felici del proprio amore è necessario vantarsi con qualcuno, è proprio l'esistenza di tutti questi qualcuno a rendere insostenibile la situazione in cui l'amore non va in porto. Lennon è circondato da un coro di osservatori in maschera da clown che lo spìano, lo giudicano, lo irridono, lo costringono a coprirsi la faccia e voltarsi verso il muro. La ragazza quasi non c'entra, anzi sembra compassionevole. Una volte gli aveva persino detto "l'amore troverà una strada". (Due anni dopo, alla festa per il lancio di Magical Mystery Tour, Lennon imbarazzerà gli ospiti danzando tutta la sera con Patti Boyd Harrison).
26. Paperback Writer (Lennon-McCartney, singolo del 1966).
 "Gentile signore / gentile signora, leggereste il mio libro?" Nell'anno precedente la Arnoldo Mondadori Editore aveva tentato un esperimento: una collana di libri da vendere non nelle librerie, ma in edicola, in un formato tascabile (o come si dice in inglese, "paperback"). Il romanzo scelto per la prima uscita fu Addio alle armi di Ernest Hemingway, un titolo che le librerie italiane sfoggiavano ormai da vent'anni, ma chissà, forse in questo nuovo formato avrebbe intercettato un pubblico diverso. Sulla fragile copertina in cartoncino campeggiava ben evidente il nome piuttosto pacchiano della nuova collana, "Gli Oscar", nonché l'aspetto più allettante dell'edizione, il prezzo: sole 350 lire! Ne stamparono sessantamila copie, una follia. Finirono in giornata. Scoppiava anche in Italia il boom dei tascabili, "i libri-transistor che fanno biblioteca", si leggeva nel risvolto di copertina. "A casa, in tram, in autobus, in filobus, in metropolitana, in automobile, in taxi... Gli Oscar sono gli Oscar dei libri: si rinnovano ogni settimana, durano tutta la vita". Si sarebbero scollati molto prima, come ognuno di noi ben sa.
"Gentile signore / gentile signora, leggereste il mio libro?" Nell'anno precedente la Arnoldo Mondadori Editore aveva tentato un esperimento: una collana di libri da vendere non nelle librerie, ma in edicola, in un formato tascabile (o come si dice in inglese, "paperback"). Il romanzo scelto per la prima uscita fu Addio alle armi di Ernest Hemingway, un titolo che le librerie italiane sfoggiavano ormai da vent'anni, ma chissà, forse in questo nuovo formato avrebbe intercettato un pubblico diverso. Sulla fragile copertina in cartoncino campeggiava ben evidente il nome piuttosto pacchiano della nuova collana, "Gli Oscar", nonché l'aspetto più allettante dell'edizione, il prezzo: sole 350 lire! Ne stamparono sessantamila copie, una follia. Finirono in giornata. Scoppiava anche in Italia il boom dei tascabili, "i libri-transistor che fanno biblioteca", si leggeva nel risvolto di copertina. "A casa, in tram, in autobus, in filobus, in metropolitana, in automobile, in taxi... Gli Oscar sono gli Oscar dei libri: si rinnovano ogni settimana, durano tutta la vita". Si sarebbero scollati molto prima, come ognuno di noi ben sa.
Nel Regno Unito la situazione era diversa, per il solito motivo che i britannici leggono di più. I paperback esistevano da inizio secolo e un boom delle vendite, se c'era stato, era avvenuto durante la Seconda Guerra, in un momento in cui i lettori si erano trovati più spesso in viaggio, sfollati o al fronte. I paperback erano il regno della letteratura di genere, e avevano spodestato le riviste pulp: gialli, intrighi di spionaggio, "sword and sorcery" (il termine fantasy doveva ancora prendere piede). Il protagonista di Paperback Writer non aspira alla fama di un Hemingway, non cerca l'Oscar: vuole scrivere robaccia che entri nelle case di tutti. Non lo spinge la sete di gloria, né la prospettiva di un guadagno. Non vuole finire come il padre, non vuole lavorare per sempre al Daily Mail. Quello che vuole fare nella vita è scrivere migliaia di pagine alla settimana – it took me years to write, will you take a look? Se riuscisse a farne un mestiere, sarebbe l'uomo più felice sulla terra, (dopo McCartney, ovviamente).
Pungolato dalla zia Lil, che voleva sentire almeno una canzone che non fosse d'amore, Paul ritorna sul sentimento che tutti nel 1966 hanno il diritto di provare, tranne lui: l'ambizione. Ma l'aspirante scrittore-di-tascabili non è animato come la ragazza di Drive My Car dalla fede nel successo finale, bensì da un desiderio irrefrenabile di creare mondi immaginari in cui forse rinchiudersi – anche se alla fine, non importa in quale galassia ambienti la tua saga, per qualche bizzarro motivo ci trovi dentro tuo padre. Proprio come Paul, che da lì a poco comincerà a intravedere l'ombra di "Father McCartney" sui set delle sue canzoni, l'aspirante scrittore di paperback comincia a inventarsi un personaggio ("è la lurida storia di un lurido uomo, e la sua affezionata moglie non lo capisce") e solo dopo un verso si rende conto che è di lui che la favola sta narrando. "Suo figlio lavora per il Daily Mail, è un bel posto fisso, ma lui vuole fare lo scrittore di paperback".
Sul piano musicale, Paul dichiara di voler proseguire l'esperimento già tentato da John con The Word, la canzone su un accordo solo: alla fine ne adopera due ma scarta l'intervallo più tipico, quello di quinta, come se una canzone senza amore non avesse diritto a sbocciarvi. La canzone rimane costretta in un più angusto intervallo di quarta che non si risolve mai – proprio come le richieste del protagonista non trovano mai un riscontro. È come se Paul stesse tentando di operare una sintesi tra le due anime che si erano espresse nel singolo di quattro mesi prima: Paperback è una canzone veloce (forse la più veloce di tutte) basata su un riff, come Day Tripper: come We Can Work It Out s'interrompe all'improvviso per lasciare spazio a un elemento vistosamente non-rock, un mini-coro a cappella che è rimasto a tutt'oggi uno degli stilemi più noti dei Beatles, e che però fino al 1966 non si era ancora sentito – e che anche in seguito i Beatles avrebbero adoperato con parsimonia. Il fatto che abbia lasciato un solco tanto profondo è la prova di quanto suonasse già allora caratteristico. Benché non compaia nessuno strumento classico, contiene già un rimando irresistibile alla 'musica seria': sta a Bach come i paperback stanno ai classici della letteratura. Il coro appare come una parrucca incipriata o una corona d'alloro che si cala all'improvviso sull'aspirante scrittore: il testo non lo dice, ma il coro ce lo fa capire, il ragazzo ha la stoffa. Forse non diventerà mai famoso, ma nella sua stanza, mentre batte a macchina centinaia di lettere al minuto, Paperback Writer è felice.
25. Can't Buy Me Love (Lennon-McCartney, singolo, del 1964, poi in A Hard Day's Night)
“Poi siamo andati in America, abbiamo fatto un giorno di vacanza a Miami ed è stato incredibile. C'era un mucchio di ragazze belle, sexy e abbronzate. Abbiamo fatto un servizio fotografico sulla spiaggia con loro e naturalmente abbiamo proposto loro di uscire con noi. La MG stava per mettere in vendita una sua nuova automobile, una decappottabile, e ce ne prestò una a testa proprio per farsi pubblicità. Ricordo di aver portato a cena una di quelle ragazze con questa automobile, ricordo quella notte in Florida, con le palme che ondeggiavano alla brezza. Un ragazzotto di Liverpool con una bella ragazza così in una decappottabile MG... avrei dovuto scrivere Money Can Buy Me Love, altro che can't!”
D'altro canto, cosa c'è di più swag di cominciare una canzone con "ti comprerò un anello di diamanti, amica mia, se questo ti fa stare bene"? Paul si fa venire in mente una frase del genere a Parigi in una camera di hotel che gli costa più o meno tutto quello che gli rende suonare all'Opéra dopo Sylvie Vartan. Non ha idea di quanto sta guadagnando, non ha idea di quanto sta spendendo, l'unica cosa che ha capito del denaro è che non ci può comprare l'amore ma non ne è nemmeno così sicuro. Però "tutti gli dicono così" (Everybody tells me so), e lui si fida. Can't Buy Me Love è l'apogeo della Beatlemania: lo incidono nell'esatto momento in cui I Wanna Hold Your Hand arriva in cima alla top100 americana. Andrà dritto al primo posto subito dopo I Wanna Hold e She Loves You, nel momento in cui nella stessa top100 ci sono 14 singoli dei Beatles. Nel 1963 tutto questo equivale a un sacco di soldi che Paul non è in grado di contare. Quello che può fare è cavalcare l'onda, comprando mobili e immobili prima che i soldi vengano assorbiti da qualche professionista di management o dagli uomini del fisco. Nel momento in cui in America nascono gruppi fotocopia come i "Beetles", nessuno ha bisogno che il prossimo singolo sia un capolavoro, davvero: e in effetti non lo è.
È anzi un brano atipico, in un momento in cui l'immagine dei Beatles dipendeva da una serie di stilemi molto riconoscibili: erano quelli che cantavano "Yeah Yeah", e Paul qui canta "No no no, no". Erano famosi per i coretti armonizzati in modo molto peculiare, e qui i Quattro, dopo averli incisi, decidono di farne a meno: scelta coraggiosa. Erano riconoscibili per le progressioni imprevedibili, e qui Paul opta nella strofa per uno schietta e prevedibile progressione blues. Suonano una miscela di rock e pop, ma qui Paul sembra avere in mente qualcosa di più classico e swingante, e più tardi si sentirà onorato della versione di Ella Fitzgerald. Come se i Beatles fossero già stanchi della formula che li sta coprendo d'oro – o semplicemente non hanno nient'altro per le mani e bisogna battere il ferro finché è caldo. In fondo poteva finire tutto tanto rapidamente quanto era iniziato, e cosa sarebbe rimasto? La consolante idea che con tutti quei soldi piovuti ed evaporati non avrebbero potuto comprarci un grammo d'amore. O no?
Can't Buy esce su singolo insieme a You Can't Do That: su un lato John si atteggia a maschio possessivo, sull'altro lato Paul spergiura che i soldi non danno la felicità. Suonano credibili entrambi, ma è solo l'inizio del 1964.
24. Blackbird (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968).
Take these broken wings and learn to fly. A Rikikesh come è noto Lennon e McCartney fecero progressi con la meditazione, ma soprattutto col fingerpicking. È emozionante notare come malgrado il maestro fosse lo stesso, i discepoli abbiano sviluppato immediatamente due stili completamente diversi – del resto il fingerpicking è una delle tecniche più idiosincratiche, ognuno ha una mano diversa e la chitarra se ne accorge più di altri strumenti. Se Lennon è più ossessivo, quasi alla ricerca dell'equivalente chitarristico di un mantra, Paul approfitta subito della possibilità di trattare la chitarra come una piccola orchestra, con una chiara ripartizione dei ruoli tra corde basse e acute. Una cosa di cui probabilmente nessuno si sarebbe accorto se Paul non ce l'avesse raccontato è che Blackbird trae ispirazione nientemeno che da da una breve frase della Bourrée in Mi- di Johann Sebastian Bach che John e Paul suonavano alle feste per dimostrare "che non eravamo stupidi come sembravamo". Ma siccome non erano nemmeno così brillanti, la loro Bourrée abortiva spontaneamente dopo otto battute (qualche anno più tardi una versione più completa sarebbe diventata un cavallo da battaglia dei Jethro Tull in concerto).
Quando a Rikikesh Paul scopre le potenzialità polifoniche della chitarra, l'indice della mano sinistra corre istintivamente sui tasti di quella bourée. Ricordiamo che il fingerpicking, che nel giro di pochi anni diventerà un luogo comune della cultura giovanile, nel 1968 era qualcosa di pionieristico che Donovan raccontava di aver appreso in Europa mentre viaggiava in una carovana di gitani. Comporre un brano in questo stile significa letteralmente brevettare diteggiature e accordi che nessuno ha ancora sentito: per qualche anno il segreto di come si suona Blackbird sarà gelosamente custodito e passerà solo da bocca di hippy a orecchio di hippy. Blackbird può approfittare di quell'estetica del non finito che trionfa nel Disco Bianco: qualche anno prima lo stesso Paul avrebbe sentito l'esigenza di annegarla nei violini, com'era successo a Yesterday. Nel 1968 i tempi sono maturi perché sul disco della band più famosa del mondo compaia un breve brano acustico col rumore del battito del piede in sottofondo. Quasi un invito ai chitarristi di tutto il mondo a cimentarcisi: prendete quelle ali spezzate, anzi quelle dita, e spiccate il volo. A parte il merlo ridondante in sottofondo, la stiamo ascoltando come l'ascoltarono le Apple Scruffs, le ragazze che si appostavano tutta la notte davanti all'appartamento di Paul, a cui una sera la suonò dal balcone, come una serenata al contrario (forse anche un invito a farsi una vita).
(Anche stavolta Paul non si risparmia un paio di incongruenze: come si fa a imparare a volare con "ali spezzate"? Come si fa a volare "nella luce di una notte buia e oscura"?).
Un'altra cosa che non potremmo immaginare se Paul non si fosse preoccupato di raccontarcela, è il contenuto politico del brano, che secondo Paul era indirizzato alle lotte degli afroamericani per i diritti civili. Un classico esempio di attribuzione post-rem: anche se Paul fosse in buona fede, esiste davvero una dedica se nessuno si accorge che l'hai fatta? Sarebbe stato il gesto di engagement politico più coraggioso di tutta la traiettoria dei Beatles, salvo che nessuno ci fece caso. In una registrazione del 1969 sentiamo Paul affermare confusamente qualcosa del genere a Donovan; Paul sostiene tra l'altro di averla cantata a Diana Ross, e che lei se ne sia offesa ("she took offense"). Piccoli grandi choc culturali: agli afroamericani non piace essere accostati ad animali in virtù del loro colore, ma nel 1969 Paul non ne conosceva abbastanza per saperlo.
Non sembra una coincidenza il fatto che Blackbird appartenga a quel gruppetto di canzoni che cronologicamente Paul non poteva aver dichiarato a Jane Asher, ma che nemmeno poteva attribuire alla sua storia d'amore con Linda Eastmann. In quel periodo aveva una relazione un po' meno impegnativa con l'aspirante scrittrice Francie Schwartz. Francie era presente in Abbey Road durante le sessioni di alcuni brani del Disco Bianco, tra cui Blackbird, ma non sarebbe rimasta a lungo sullo stesso ramo di Paul. Ufficialmente non ci sono canzoni che parlano di lei. Blackbird dopotutto non deve parlare di nessuno in particolare: è una canzone che cattura semplicemente l'emozione di chi sta facendo qualcosa di fantastico per la prima volta. Cioè parla di sé stessa, e di quanto è fantastico riuscire a suonare per la prima volta Blackbird. Vola uccello nero, vola.
23. Come Together (Lennon-McCartney, Abbey Road, 1969).
One thing I can tell you is you've got to be free. I Beatles nell'estate del 1969 erano finiti, John Lennon lo sapeva meglio di tutti e non ci vedeva niente di male. Quello che per noi beatlemani è la Caduta ineluttabile, per lui era un normale fatto della vita. Se in seguito avrebbe sviluppato un certo rancore per Paul, in quel momento l'idea del divorzio era una delle più lucide che gli attraversassero la mente. Ormai erano anni che lui e il socio non condividevano più la visione artistica: perché continuare a fingere che i Beatles esistessero ancora, che i loro dischi non fossero raccolte eterogenee di due solisti che per comodità si facevano accompagnare dalla stessa band? Per i soldi? Ma il più dei soldi finivano comunque in tasse o in disavventure commerciali che portavano soltanto a ulteriori frustrazioni. Non era nemmeno escluso che i quattro musicisti più famosi del mondo, separati, non avrebbero venduto ancora più dischi: quindi, davvero, che senso aveva continuare a stare assieme? Ognuno per sé e magari Allen Klein per tutti. Per essere il ragionamento di una rockstar bipolare ed eroinomane, era sorprendentemente sensato. Senonché Klein aveva appena firmato un contratto con la Capitol per altri due album. E... li stava fregando. Paul aveva capito che Klein li stava fregando, ma non aveva niente di meglio da proporre che la consulenza del neo-suocero. La sola vaga ipotesi di trasformare la Apple Corps in una ditta a trazione famigliare Eastman-McCartney ottenne il risultato di riavvicinare Lennon a Harrison e Starkey, portando Paul a una posizione isolata che non sarebbe stato emotivamente in grado di gestire.
One and one and one is three. Uno dei tipici problemi della band che si stanno sciogliendo, è che i membri che scrivono le canzoni cominciano a mettere da parte le migliori. Dando un'occhiata ad Abbey Road e ai dischi solisti che uscirono pochissimi mesi dopo, appare abbastanza chiaro chi dei due soci stava già pensando a organizzarsi una carriera da solista e chi invece non si rassegnava. Lennon di lì a poco avrebbe buttato fuori Instant Kharma, Mother, Imagine, Working Class Hero, ma quando in estate i Quattro si ritrovarono in Abbey Road per assolvere i doveri contrattuali, sembrava aver meno musica da offrire di George Harrison. Giusto quel blues composto nei giorni di Twickenham, a cui avrebbe imposto una coda sinfonica che nelle sue intenzioni sarebbe diventata la marcia funebre del gruppo; un altro strano ghiribizzo beethoveniano, e qualche scarto del Disco Bianco. Tra gli altri c'era anche un brano alla Chuck Berry che aveva iniziato a comporre per Timothy Leary quando si era candidato alla carica di governatore della California contro un ex attore di serie B, Ronald Reagan; Leary si era fatto arrestare per possesso di marijuana prima che Lennon finisse il pezzo e così lo propose a Paul, con la preghiera di farlo suonare meno chuckberriano possibile: il tizio aveva la denuncia facile. Il brano prendeva il nome dallo slogan elettorale di Leary, “Come Together”: forse per un attimo l'idea di usarlo come tappabuchi nell'album del divorzio gli sembrò ironica: per completare il testo gli sarebbe stato sufficiente rispolverare un po' di quel surrealismo un tanto al chilo che non lo appassionava più come ai tempi di Lucy, ma di cui restava il maestro: et voilà, una canzone in un qualche modo ci sarebbe saltata fuori ed era tutto quello che serviva a Klein, un'altra manciata di canzoni per tranquillizzare azionisti e avvocati.
Invece saltò fuori un capolavoro.
I Beatles nel 1969 erano diventati Cinque. Già durante la lavorazione del Disco Bianco Harrison aveva capito che le sessioni diventavano più proficue se si invitava un quinto musicista. In certi casi era l'unico modo per smettere di trattarsi da vecchi amici scazzati e cominciare a trattarsi da professionisti. Purché fosse un musicista valido – qualcuno davanti al quale avrebbero avuto pudore di sbagliare – e anche una vecchia conoscenza, come Eric Clapton, o Billy Preston. Get Back, il primo singolo del 1969 era attribuito a "The Beatles With Billy Preston": un modo di valorizzare un musicista della scuderia Apple, ma anche l'ammissione che Preston non era il solito turnista di lusso invitato a dare un sapore particolare a una sola canzone: al di là di alcuni assoli effettivamente strepitosi, il suo organo Vox cambia davvero il suono dei Beatles. Ha un timbro inconfondibile che ci rimanda immediatamente a quegli anni a cavallo tra '60 e '70; uno tocco che trasuda professionalità americana e quindi crea uno scarto percepibile con lo stile più emotivo degli altri Quattro. Ciononostante, a un certo punto Lennon buttò lì l'ipotesi di far entrare Preston nel gruppo. Chi lo diceva, in fondo, che i Beatles dovessero restare sempre gli stessi quattro inglesi fino alla fine? Magari avrebbero potuto diventare qualcosa di diverso, un collettivo organico che si modifica, adattandosi ai tempi, alle sfide. Lennon diceva tutto quello che pensava e a volte anche cose che non pensava davvero (una volta che Harrison aveva sbattuto la porta aveva buttato lì di sostituirlo con Clapton). Ma se per un un attimo l'idea di un gruppo da Cinque lo poté solleticare, probabilmente fu davanti al risultato di Come Together. Una canzone che aveva scritto quasi per sbaglio, chiedendo esplicitamente ai colleghi di stravolgerla: un blues virato in minore, che all'improvviso prende vita. Secondo George Martin la molla che fece scattare il meccanismo fu il riverbero di un battito di mani di John vicino al microfono, che combinato con una nota insistita del basso di Paul creava un senso di mistero, accresciuto da quella sibilata palatale un po' inquietante, "shoot me!"
Dopodiché entra Ringo, con una delle sue più folli idee batteristiche: quattro tocchi al charleston e dieci ai tom. In qualsiasi altro gruppo, un qualsiasi altro batterista non avrebbe avuto nemmeno il coraggio di proporre qualcosa che anche a cinquant'anni di distanza suona così grottesco: ma erano i Beatles, potevano fare tutto. Durante le sessioni di Abbey Road, Come Together diventa quel blues drammatico e sospeso che avrebbe potuto essere Helter Skelter, prima che Paul decidesse di trasformarlo in un monumento al frastuono. Quel titolo che era rimasto attaccato per caso fu di ottimo auspicio: Come Together è il risultato più alto dei Beatles nella formazione a Cinque. Fanno tutti qualcosa di indispensabile: Lennon canta i suoi nonsense come fossero profezie della fine, Paul lo appoggia alla voce ma il suo basso è il collante di tutto il brano; Ringo ci mette la fantasia; George capisce al volo che il brano ha bisogno di un assolo lento, ipnotico; l'organo di Preston aggiunge un'arcana profondità. Come Together era la risposta del Dio della musica alla domanda di Lennon: che senso ha restare assieme? ecco che senso ha, imbecille. In questo studio persino la tua spazzatura diventa oro: potrebbe essere l'unico luogo dell'universo dove 1+1+1+1+1= infinito, e tu vuoi rinunciare a tutto questo? Questi stivali da tricheco, sai dove dovrei piazzarteli?
Sparami.
22. All You Need Is Love (singolo del 1967 per la trasmissione in mondovisione Our World; poi nell'edizione Capitol di Magical Mystery Tour).
Non c'è nulla che puoi fare che non possa essere fatto. Non si vive di soli Beatles, per esempio gli inglesi nel 1967 andavano anche pazzi per un personaggio tv, una spia impersonata dall'attore Patrick McGoohan. Dopo un inizio abbastanza convenzionale, verso il 1967 il personaggio sembrava andato fuori di testa (un po' come i Beatles) e la sua serie era diventata l'esperienza più psichedelica che i telespettatori potessero fare da sobri (oltre ad ascoltare i Beatles). Ora la serie si chiamava The Prisoner e mescolava in libertà Orwell, Huxley, James Bond e la Nouvelle Vague, in un calderone paranoico non sempre comprensibile ma che lasciava il segno. L'ultima puntata era attesa nel febbraio 1968. È la puntata in cui McGoohan, detto Numero 6, dopo avere sconfitto tutti i Numero 2 che lo tenevano recluso in una strana isola-campo-di-rieducazione, chiede e ottiene di incontrare il Numero 1, il personaggio misterioso che manovra tutti i fili della trama e che nessuno ha mai visto in volto. Tutto questo lo sto raccontando perché The Prisoner continuò a essere programmato a lungo in Italia, persino sui canali locali, e l'ultimo episodio è il primo ricordo che ho di All You Need Is Love. Per me, prima di essere un inno alla pace e all'amore, era il brano sparato all'unisono da cinque jukebox nella galleria che conduceva Numero 6 al rifugio di Numero 1. Probabilmente non capivo le parole, e comunque le avrei trovate molto ironiche, perché l'unico vero tema di tutte le 17 puntate di The Prisoner è il Lavaggio del Cervello, e All You Need Is Love è in effetti la classica cosa che un pool di psico-spie potrebbe cantarti mentre ti lobotomizzano. Più tardi si risente durante una sparatoria.
Una canzone originale dei Beatles in una fiction è un caso molto raro: anche nei pochi casi in cui succedeva, le canzoni venivano poi eliminate dalla versione home video. L'ultima puntata di The Prisoner è l'eccezione, probabilmente perché (secondo la testimonianza del figlio di George Harrison) il programma piaceva tantissimo a uno o più Beatles: al punto che tra i progetti cinematografici ipotizzati dopo Help! era stata sul tavolo anche l'ipotesi di fare una cosa in stile Prisoner. Difficilmente sarebbe venuta peggio di quel che poi fu realizzato davvero, ovvero The Magical Mystery Tour. Ma diciamo la verità: difficilmente sarebbe venuta peggio dell'ultima puntata di The Prisoner, una pagliacciata così avvilente, un tentativo così fallito di nascondere la mancanza di idee sotto un tappeto di ambiguità metafisiche, che al confronto l'ultima puntata di Lost è un capolavoro. Perché vi sto parlando di questo?
Perché l'imprinting è importante e nella canzone che per tutti più rappresenta la filosofia dell'amore universale, io ho sempre voluto cercare un fondo di ironia e paranoia. E retrospettivamente, devo ammettere, ho maturato su All You Need Is Love gli stessi dubbi che mi sono venuti rivedendo l'ultima puntata del Prigioniero: punto supremo di una coraggiosa visione artistica e filosofica, o canzone realizzata in fretta e furia nascondendo sotto un tappeto di aforismi enigmatici una certa mancanza di idee? Bisogna dire che All You Need Is Love è invecchiata molto meglio di The Prisoner, ma questo è il minimo: tutta la musica del 1967 è ancora ascoltabile, quasi tutta la tv di allora non è più guardabile. Sia McGoohan che i Beatles avevano oggettivamente poco tempo a disposizione: McGoohan per risolvere i misteri che avevano incollato milioni di spettatori al tubo catodico, Lennon e McCartney per produrre qualcosa all'altezza del loro nome per il primo programma in mondovisione, che sarebbe andato in onda in diretta il 25 giugno 1967. Ogni nazione portava in vetrina qualcosa di nuovo, e di potenzialmente interessante anche per gli stranieri: l'Italia portò le telecamere sul set di Romeo e Giulietta di Zeffirelli; il Regno Unito propose i Beatles.
Costoro potevano contare (a differenza di McGoohan) di un collaboratore che non li tradiva mai e che dimostrò nell'occasione una versatilità straordinaria. Lennon aveva per l'occasione una canzone dal testo più che appropriato: semplice, universale, un po' enigmatico ma è meglio un buon enigma di una pessima spiegazione. Il guaio è che lo aveva scritto su un tempo sghembo impossibile, una specie di sette quarti, una battuta rock e una valzer: e pretendeva che un'orchestra lo seguisse, su un tempo zoppo del genere, in Mondovisione. Qualcun altro lo avrebbe mandato a quel paese; George Martin ci rifletté sopra: il tema iniziale gli ricordava la Marsigliese. Perché non mettere proprio la Marsigliese? Non bisognava pagare i diritti a nessuno, dopotutto, e ai telespettatori francesi magari avrebbe fatto piacere. E già che ci siamo, perché non infilarci un concerto brandeburghese? E In The Mood?
Nel 1967 George Martin coglie subito il punto: i Beatles stavano diventando un feticcio culturale. La mondovisione sarebbe stata la consacrazione: i Beatles come Zeffirelli, come l'opera, la selezione del Reader's Digest. All You Need Is Love si candidava a diventare un inno generazionale ma la tv l'avrebbe portata ancora più in là nell'empireo della cultura middlebrow. Una simile occasione meritava pompa e circostanza. Le citazioni di All You Need non sono ironiche, sono necessarie come i volumi in pelle che si sfoggiano sulla libreria di un salotto rispettabile, altro che paperback da mezza sterlina. Una rivendicazione in diretta tv: siamo i Beatles, la Marsigliese del Novecento la stiamo componendo noi, qui, in diretta, con i nostri amici. Al centro di tutto questo monumento che si stanno scolpendo addosso, i Quattro cercano se possibile di restare seri. Non ce la fanno del tutto. Paul si mette a incitare il pubblico come l'artista circense che forse preferirebbe essere. Alla fine qualcuno (non si è mai capito chi) si mette a cantare “Yeah Yeah Yeah She Loves You” sulle auguste rovine di In the Mood: ha perfettamente senso (e anche In the Mood era diventato un feticcio da pochissimo: la generazione precedente lo considerava un semplice brano ballabile). Eppure, quello “Yeah Yeah Yeah” sembra la scritta lasciata da un teppistello su un monumento.
21. I Am the Walrus (Lennon-McCartney, lato B di Hello Goodbye e Magical Mystery Tour, 1967).
 LENNON: Io sono l'uomo uovo.
LENNON: Io sono l'uomo uovo.
GLOUCESTER: Dite, mio buon signore, chi siete?
LENNON: Essi sono l'uomo uovo
EDGAR: Un pover’uomo domato dai colpi della Fortuna,
LENNON: Io sono il Tricheco...
Vale ancor più per I Am the Walrus lo stesso dubbio confessato per All You Need Is Love: geniale capolavoro o sublime presa in giro? E come nel caso di All You Need, non è che si debba per forza scegliere. I Am the Walrus potrebbe anche essere entrambe le cose. Ogni brano ha la sua leggenda, ma all'altezza di Walrus Lennon ne era consapevole e si divertiva manifestamente a confondere le acque. Ogni glossatore di Walrus si sente il dovere di elencare tutti i riferimenti già acquisiti: il tricheco è un famoso personaggio della solita Alice, un libro da John più citato che letto visto che si sarebbe accorto solo in seguito che si trattava di un bieco sfruttatore; "crema di materia gialla che cola dal cane morto" è il residuo di una filastrocca da cortile rammentata a John dall'ex compagno di giochi Pete Shotton; "Semolina Pilchard" sarebbe un riferimento al sergente di Scotland Yard Norman Pilcher, che lottava contro la droga indagando i VIP e aveva appena tentato di incastrare i Rolling Stones; i pinguini elementari che cantano Hare Krishna sarebbero un riferimento ad Allen Ginsberg o a i poser che credono che basti inneggiare a Krisha per salvare il mondo: nessuno però ha mai fornito un movente per il loro prendere a calci Edgar A. Poe. Tutto chiaro adesso? Rimane il dubbio: ha senso davvero occuparsi di tutto questo, ha senso discutere delle esperienze sessuali di Eric "egg-man" Burton con una ragazza caraibica e un uovo crudo, o chiarire l'identità della pornosacerdotessa che fa cascare le mutande a un ragazzo che sta facendo la birichina ("naughty girl")? Non stiamo semplicemente cascando a piedi pari nella trappola che Lennon ha allestito nel 1967, dopo avere scoperto che nelle scuole di Liverpool agli studenti venivano richieste interpretazioni dei suoi brani? Non è sufficiente derubricare il tutto a sberleffo nei confronti di chi insiste a farne un feticcio? Quattro anni prima era stato un critico musicale che si era ingegnato a trovare una "cadenza eolia" in una sua canzoncina per teenager; ora c'è già qualcuno che vuole mettere Strawberry Fields e Lucy in the Sky nelle antologie scolastiche, Lennon non ci sta.
Alla fine del 1967 I Am the Walrus richiama sin dalle prime note di mellotron il singolo uscito appena in febbraio, Strawberry Fields. In mezzo c'è stato uno degli anni più importanti della storia del costume e del rock; i Beatles hanno partecipato con un disco "en travesti" sospeso tra avanguardia e nostalgia che è andato bene ogni oltre più rosea aspettativa. È un anno che Lennon ha trascorso consumando LSD con una certa continuità, ma il brano che sembra voler riprendere Strawberry da dove si era fermata ci fa anche apprezzare la differenza. La sintassi franta e caotica di Strawberry, che sembrava davvero scritta in trance, lascia il passo a un nonsense compiaciuto che si ricollega al surrealismo giocoso degli scritti giovanili. È un Lennon che sta già cominciando a farsi il verso, e lo sa, e se ne diverte; i due brani di quel singolo di Natale sono forse l'espressione più pura di quella concezione di musica come gioco. L'orchestra di Martin, la radio che trasmette Shakespeare, il surrealismo, Alice: è tutto un giocattolo. Lennon si fa un punto di onore di usare tutti gli accordi della scala, che in inglese hanno le sette lettere dell'alfabeto: ABCDEFG, come un bambino che voglia usare tutti i tasti del suo strumento in miniatura. In particolare la cadenza del ritornello è bizzarra ma puerile: I-II-III.
Credo che chi ama I Am the Walrus ne colga soprattutto questa dimensione giocosa. Malgrado John continui a insistere che "sta piangendo": ma per una volta ci riesce più facile fidarci del video (una sequenza del Magical Mystery Tour) in cui ghigna per tutto il tempo. È anche merito di due compari che reggono il gioco in modo impareggiabile. Uno è Ringo Starr, che si prende cura della canzone offrendole un groove imprevedibile; di tutti i capolavori psichedelici Walrus è l'unico che si potrebbe ballare. Ringo ci crede particolarmente e allo stesso tempo non ruba mai la scena, anche perché questo spetta all'altro compare, George Martin.
I Am the Walrus è una di quelle canzoni che nascono più da uno stimolo cerebrale che da un'intuizione emotiva: Lennon vuole mettere alla prova le nostre derive interpretative e nel farlo non si preoccupa più di tanto di annoiarci. Il fatto che non succeda lo abbiamo sempre preso come una dimostrazione delle sue trascendentali capacità compositive... ma provate ad ascoltare su Anthology la stessa canzone senza l'orchestra diretta da Martin. Non diventa subito molto meno interessante? Martin considerava I Am the Walrus il suo score migliore, e parliamo del signore che aveva composto gli spartiti per Yesterday e Eleanor Rigby. Martin è solitamente considerato soprattutto l'anima sinfonica dei Quattro, sempre tentato dall'aggiungere violini e clavicembali là dove a volte non ce ne sarebbe bisogno. Lui stesso dopo l'avventura coi Beatles ha preferito presentarsi al pubblico come un rispettabile maestro d'orchestra: ma prima di incontrare gli stessi Beatles il suo mestiere era anche reperire suoni buffi per gli album di varietà che erano il core business della Parlophone,o per i programmi radiofonici di Peter Sellers. C'è in Martin una dimensione farsesca e giocosa che gli permise di individuare la stessa componente nei Beatles, e farla risplendere al momento giusto: più spesso quando lavorava con John. Dopo l'happening di A Day in the Life, con gli orchestrali invitati a mettersi in maschera e a suonare la fine del mondo; dopo il pandemonio postmoderno di All You Need Is Love; stavolta Martin convoca un coro di professionisti e li costringe a fare le boccacce ("hoo hoo haa haa"); obbliga nel finale gli archi a scendere mentre i bassi salgono: sta giocando, anche lui.
L'orchestrazione di I Am the Walrus la solleva letteralmente da terra, lasciandola sospesa in una nuvola surreale in cui tutto diventa possibile – al punto che Lennon può accendere una radio nel bel mezzo del brano e captare una scena di Re Lear che miracolosamente si introduce tra i versi del ritornello creando un senso sinistro là dove un senso non c'era. La vostra poesia che comporrete pescando frasi ritagliate a caso da un cappello vi assomiglierà, scriveva Tszara. Ripensandoci, è quasi una maledizione.
Walrus è l'ultimo trionfo della collaborazione tra Lennon e Martin. La lavorazione del brano comincia appena nove giorni dopo la morte di Epstein; uscirà nel momento forse più alto della traiettoria artistica dei Beatles, il momento in cui dopo Sgt Pepper hanno convinto quasi tutti e sanno di potersi permettere quasi tutto: che è proprio quello che fanno in Hello Goodbye e Walrus. A scegliere la prima come lato A del singolo sarebbero stati McCartney e Martin, gettando in Lennon i semi di una frustrazione che l'avrebbe portato, più di un anno dopo, a chiedere il divorzio. È una ricostruzione che lascia perplessi: se Lennon avesse davvero voluto quel lato A, non avrebbe evocato quella "pornographic priestress" più che sufficiente a bandire il brano dalla programmazione radiofonica sia nel Regno Unito che negli USA. Certo col senno del poi Walrus è rimasta molto più che Hello Goodbye, ma nemmeno Lennon credo che potesse immaginarlo a fine '67. In quel momento aveva soprattutto voglia di giocare – il che comunque era un buon segno – e forse non pensava nemmeno che il gioco gli sarebbe riuscito così bene.
Ricordo a tutti che la classifica non la faccio io, anzi io mi dissocio formalmente, è la media di tutte le classifiche redatte dai giornalisti musicali, credo che li assumano soltanto se dimostrano di non percepire la differenza tra Il flauto magico e una mietitrebbia.
Puntate precedenti: (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#200-181), (#180-166), (#165-156), (#155-146), (#145-136), (#135-121), (#120-111), (#110-96), (#95-86), (#85-76), (#75-66), (#65-56), (#55-46), (#45-36)
30. Nowhere Man (Lennon-McCartney, Rubber Soul, 1965).
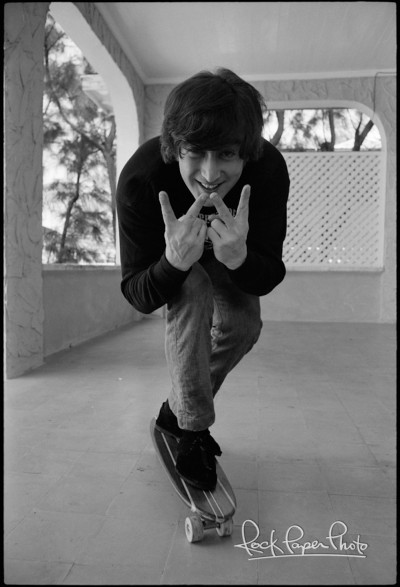 Uomo di Nessun Dove, il mondo aspetta i tuoi ordini. Quando lo andò a trovare qualche mese dopo, nella sua villa di Weybridge, la giornalista Maureen Cleave trovò un John Lennon sospeso tra inquietudine e apatia, isolato dal mondo in un villino ingombro di elettrodomestici e gadget di cui si era stancato a volte prima di scartarli. Lennon non poteva rinunciare a dire spiritosaggini – era il suo personaggio – e a un certo punto gli scappò detto che non vedeva molto futuro per il cristianesimo, forse non sarebbe sopravvissuto neanche ai Beatles. Una battuta a cui in Inghilterra nessuno fece caso, ma che ripresa dalla stampa americana alla vigilia di un tour scatenò una delle prime shitstorm di cui la storia del costume sia a conoscenza: minacce di morte, roghi di dischi, eccetera. L'intervista della Cleave è passata alla storia per quella battuta, ma rimane anche un bell'esercizio su quello che stava per diventare un topos giornalistico: il ritratto della giovane rockstar alienata. La stanza dei giocattoli, le auto di lusso che Lennon compra e rivende perché ha paura di spendere tutti i soldi che guadagna, salvo ricomprarle subito dopo... è tutto già così perfetto e familiare da seminare un dubbio: non è che Lennon stesse recitando, come aveva sempre fatto davanti ai microfoni dei giornalisti? Era davvero così compreso nel suo ruolo di divo con piscina e Rolls Royce, o non stava semplicemente dando al pubblico quello che il pubblico si aspettava da lui, quello che il pubblico si aspetta ancora oggi, un'ostentazione spudorata di status symbol, tratti eccentrici e sintomi di alienazione? Essendo inglese non poteva candidarsi alla Casa Bianca come Kanye West; si limitò a un po' di dissing su Gesù Cristo. Non stava semplicemente fornendo ai fan una specie di tableau vivente del brano che era appena uscito come singolo negli USA, Nowhere Man?
Uomo di Nessun Dove, il mondo aspetta i tuoi ordini. Quando lo andò a trovare qualche mese dopo, nella sua villa di Weybridge, la giornalista Maureen Cleave trovò un John Lennon sospeso tra inquietudine e apatia, isolato dal mondo in un villino ingombro di elettrodomestici e gadget di cui si era stancato a volte prima di scartarli. Lennon non poteva rinunciare a dire spiritosaggini – era il suo personaggio – e a un certo punto gli scappò detto che non vedeva molto futuro per il cristianesimo, forse non sarebbe sopravvissuto neanche ai Beatles. Una battuta a cui in Inghilterra nessuno fece caso, ma che ripresa dalla stampa americana alla vigilia di un tour scatenò una delle prime shitstorm di cui la storia del costume sia a conoscenza: minacce di morte, roghi di dischi, eccetera. L'intervista della Cleave è passata alla storia per quella battuta, ma rimane anche un bell'esercizio su quello che stava per diventare un topos giornalistico: il ritratto della giovane rockstar alienata. La stanza dei giocattoli, le auto di lusso che Lennon compra e rivende perché ha paura di spendere tutti i soldi che guadagna, salvo ricomprarle subito dopo... è tutto già così perfetto e familiare da seminare un dubbio: non è che Lennon stesse recitando, come aveva sempre fatto davanti ai microfoni dei giornalisti? Era davvero così compreso nel suo ruolo di divo con piscina e Rolls Royce, o non stava semplicemente dando al pubblico quello che il pubblico si aspettava da lui, quello che il pubblico si aspetta ancora oggi, un'ostentazione spudorata di status symbol, tratti eccentrici e sintomi di alienazione? Essendo inglese non poteva candidarsi alla Casa Bianca come Kanye West; si limitò a un po' di dissing su Gesù Cristo. Non stava semplicemente fornendo ai fan una specie di tableau vivente del brano che era appena uscito come singolo negli USA, Nowhere Man?Quando non faceva il matto davanti ai giornalisti e non era in tour da qualche parte, John aveva pur sempre un gruppo da portare avanti. La tabella era sempre quella concordata con Brian Epstein tre anni prima: due album e quattro singoli all'anno. Ormai ci si aspettava che gli album fossero composti tutti di materiale originale, che non si scriveva da solo, per cui no: Lennon non è che non stesse facendo nulla tutto il giorno. Il problema dell'artista (e soprattutto di chi gli vive intorno) è che è quasi impossibile distinguere i momenti in cui sta creando da quelli in cui sta cazzeggiando. Si capisce che gironzolare mezzo fatto per la casa non restituisce una buona impressione di te, ma se sei il tizio che scrive le canzoni di Lennon-McCartney può darsi che sia il modo più proficuo di passare il tempo.Un buon esempio è proprio la leggenda di Nowhere Man: dopo cinque ore passate a cercare una canzone che non gli veniva, Lennon si butta sul letto, comincia a osservare dall'esterno quel sé stesso che si dibatte tra noia e velleità, ed eureka: ecco Nowhere Man. Quando non riesci a trovare niente da dire, puoi sempre mettere in scena te stesso che non riesce a trovare niente. Due anni prima Federico Fellini ci aveva fatto un film: Nowhere Man è l'8 e 1/2 di Lennon.
 Né dobbiamo credere per forza che le ore passate prima di buttarsi a letto fossero state infruttuose: magari le aveva passate ad ascoltare qualche disco d'importazione. In febbraio negli USA era uscito Bringing It All Back Home, il disco in cui Dylan suonava per la prima volta con una band. Ma il brano che probabilmente doveva averlo colpito di più era ancora acustico: si chiamava Mr Tambourine Man. In marzo poi un gruppo californiano aveva pubblicato la sua versione 'elettrica' di Mr Tambourine Man: si facevano chiamare Byrds e le loro chitarre ricordavano smaccatamente la 12 corde usata da George Harrison in Ticket to Ride: insomma se Lennon avesse voluto copiarli, non avrebbe che "riportato tutto a casa".
Né dobbiamo credere per forza che le ore passate prima di buttarsi a letto fossero state infruttuose: magari le aveva passate ad ascoltare qualche disco d'importazione. In febbraio negli USA era uscito Bringing It All Back Home, il disco in cui Dylan suonava per la prima volta con una band. Ma il brano che probabilmente doveva averlo colpito di più era ancora acustico: si chiamava Mr Tambourine Man. In marzo poi un gruppo californiano aveva pubblicato la sua versione 'elettrica' di Mr Tambourine Man: si facevano chiamare Byrds e le loro chitarre ricordavano smaccatamente la 12 corde usata da George Harrison in Ticket to Ride: insomma se Lennon avesse voluto copiarli, non avrebbe che "riportato tutto a casa".Alcune caratteristiche formali di Nowhere Man si spiegano proprio se si confrontano con quello che stava succedendo negli USA: per la prima volta un bridge compare tre volte (ciononostante la canzone è ancora breve rispetto ai modelli dylaniani). Le chitarre danno la loro versione del jingle-jangle byrdiano: Paul ricorda con soddisfazione di avere costretto i tecnici del suono a oltrepassare i limiti della strumentazione disponibile, facendo passare le chitarre da un amplificatore intermedio per aumentare le frequenze alte oltre il consentito. Persino la scelta di non correggere la lieve dissonanza tra il coro iniziale e gli strumenti in entrata potrebbe essere un tentativo di aggiornarsi al suono 'sporco' che negli USA era l'ultimissima novità – Dylan in studio a volte non si preoccupava nemmeno di accordare la chitarra, e Dylan era la cosa più hip che ci fosse. Si dice che Nowhere Man sia il primo brano dei Beatles che non parli d'amore: in superficie è proprio così, ma dopotutto è una canzone di John su sé stesso: c'è più amore qui che in Day Tripper. Qualche anno più tardi Dylan avrebbe spiegato in un'altra celebre intervista che molte canzoni che credeva di dedicare agli altri, in realtà erano rivolte a sé stesso. Lennon, mentre fissava il soffitto della sua camera da letto di Weybridge, lo aveva già capito.
29. Rain (Lennon-McCartney, lato B di Paperback Writer).
Sempre a Weybridge una sera, dopo essersi rollato un joint, Lennon spinge un bottone perché vuole riascoltare il brano a cui sta lavorando. Viene investito da una canzone mai sentita: eppure è lui che canta, anche se è come se chiamasse da un mondo al di là dello specchio. Rimane perplesso per qualche istante (il joint in mano), prima di capire: ha montato la bobina a rovescio, sta ascoltando l'esatto contrario di quello che ha inciso ad Abbey Road. Niente di così strano, tranne che la canzone gli piaceva di più così.
Il giorno dopo cerca di spiegare ai colleghi e a George Martin che Rain suona meglio alla rovescio. Alla fine Martin acconsentirà ad inserire almeno un frammento invertito della traccia vocale di John nel finale (nei video musicali che vengono girati, John dovrà mimare anche questa traccia invertita). È un episodio famoso forse più di quanto meriti – di tante innovazioni tentate con Rain, la voce alla rovescio è la più appariscente ma la meno incisiva. L'episodio fotografa comunque un John Lennon che dopo tre anni di esperienza vive ancora la sala prove come una stanza di giocattoli da smontare alla ricerca di qualche effetto inatteso e divertente. È anche il sintomo di una resa: su Rain si poteva osare di più perché in fondo era chiaro dall'inizio che sarebbe stato solo un Lato B. È come se dopo il passo falso di Day Tripper, Lennon cominci a ritirarsi in un ghetto creativo: se Paul davvero vende di più, John diventerà l'anima sperimentale della band (il ruolo che in precedenza Harrison aveva iniziato a ritagliarsi).
Rain è un brano che dà sempre l'impressione di restare un po' nascosto – per quanto possa restare nascosto un brano dei Beatles. C'è un motivo semplice: era un lato B, appunto, e Allen Klein non volle inserire lati B nell'antologia ufficiale del periodo 1962-66, il cosiddetto Disco Rosso. Lo spazio c'era, ma in effetti Rain, che pure è il brano in cui Ringo Starr ritiene di avere dato il meglio di sé, non è quel tipo di canzone che metteresti in vetrina. Gli è perfettamente congeniale la sua dimensione di lato B, che oggi non possiamo più percepire: se nei primi anni della Beatlemania il lato B era quello dedicato al lento, verso la metà degli anni Sessanta ormai dedicare tempo all'ascolto dei lati B era la forma di snobismo più a buon mercato cui i giovani consumatori di musica potessero accedere. Il lato B era diventato lo spazio per gli intenditori: se il lato A era la vetrina, il B era il retrobottega dove gli esercenti tenevano da parte per la clientela più affezionata le cose veramente buone o comunque un insolite, non per tutti. E cosa c'era di 'buono ma non per tutti', all'inizio dell'anno di grazia 1966, nel menu dei Beatles? Un brano volutamente sfuocato, compresso, saturato che dà l'impressione di rallentare in corsa finché a un certo punto non è più un'impressione: rallenta davvero. Il ritornello, anche se non ha nulla di specificatamente indiano, comincia a suonare come un mantra.
 Anche l'idea di accelerare o rallentare le tracce vocali e strumentali non l'hanno inventata i Beatles – è sempre stata un'opzione, sin dall'invenzione del fonografo. Alcuni musicologi sono convinti che le registrazioni degli anni '20 di Robert Johnson siano accelerate del 20%: per un secolo tutti gli apprendisti blues e poi rock avrebbero tentato di imitare uno stile molto più svelto del suo. Ma prima dei Beatles era un trucco tenere i dischi più brevi e farli suonare meglio; ai limiti un gioco per divertire i bambini (i Chipmunks prima ancora di diventare personaggi televisivi erano un gruppo vocale che registrava cover accelerate). Con i Beatles il trucco diventa una tecnica, esplorata in tutte le sue potenzialità e a volte persino esibita. In Rain Lennon chiede a Martin di rallentare gli strumenti e accelerargli la voce; del resto è la canzone che parla di un uomo che non vive alla velocità degli altri, e non capisce più l'affanno di chi ancora subisce il tempo atmosferico ("posso mostrarti che è solo uno stato della mente", ok John, io l'ombrello comunque me lo porterei). È l'equivalente musicale di quei video girati in time-lapse in cui una persona quasi ferma si staglia su uno sfondo di persone o automobili che sciama a velocità rapidissima. Sui forum di fotografia qualcuno lo chiama "effetto Koyaanisqatsi", dal nome del celebre film sperimentale che negli anni '80 rese popolare il time-lapse. La progressione armonica è più semplice del solito – come del resto nel brano in vetrina, Paperback Writer: la sperimentazione della coppia Lennon-McCartney si è spostata dagli accordi ai suoni e ai nastri; ormai i loro veri strumenti sono gli amplificatori, gli equalizzatori, i magnetofoni a bobina. Non c'è più nulla che non si possa fare: la pioggia può suonare come il sole, è tutto uno stato della mente.
Anche l'idea di accelerare o rallentare le tracce vocali e strumentali non l'hanno inventata i Beatles – è sempre stata un'opzione, sin dall'invenzione del fonografo. Alcuni musicologi sono convinti che le registrazioni degli anni '20 di Robert Johnson siano accelerate del 20%: per un secolo tutti gli apprendisti blues e poi rock avrebbero tentato di imitare uno stile molto più svelto del suo. Ma prima dei Beatles era un trucco tenere i dischi più brevi e farli suonare meglio; ai limiti un gioco per divertire i bambini (i Chipmunks prima ancora di diventare personaggi televisivi erano un gruppo vocale che registrava cover accelerate). Con i Beatles il trucco diventa una tecnica, esplorata in tutte le sue potenzialità e a volte persino esibita. In Rain Lennon chiede a Martin di rallentare gli strumenti e accelerargli la voce; del resto è la canzone che parla di un uomo che non vive alla velocità degli altri, e non capisce più l'affanno di chi ancora subisce il tempo atmosferico ("posso mostrarti che è solo uno stato della mente", ok John, io l'ombrello comunque me lo porterei). È l'equivalente musicale di quei video girati in time-lapse in cui una persona quasi ferma si staglia su uno sfondo di persone o automobili che sciama a velocità rapidissima. Sui forum di fotografia qualcuno lo chiama "effetto Koyaanisqatsi", dal nome del celebre film sperimentale che negli anni '80 rese popolare il time-lapse. La progressione armonica è più semplice del solito – come del resto nel brano in vetrina, Paperback Writer: la sperimentazione della coppia Lennon-McCartney si è spostata dagli accordi ai suoni e ai nastri; ormai i loro veri strumenti sono gli amplificatori, gli equalizzatori, i magnetofoni a bobina. Non c'è più nulla che non si possa fare: la pioggia può suonare come il sole, è tutto uno stato della mente.28. Here, There and Everywhere (Lennon-McCartney, Revolver, 1966).
"Per vivere una vita migliore ho bisogno che il mio amore sia qui..." è abbastanza significativo che la canzone che parla della necessità di non separarsi mai dall'amata ("ogni giorno dell'anno") provenga dall'unico Beatle che nel 1966 viveva felicemente scapolo. Mentre John deve "nascondere il suo amore" e ricorrere a giri di parole sempre più immaginifici per cantare le sue avventure senza insospettire Cynthia, Paul è libero di uscire e tornare a casa all'ora che vuole, e se non ha sonno mettersi a fantasticare di come sarebbe bello avere lei in ogni giorno dell'anno. Ci può anche scrivere una canzone senza che nessuno venga a disturbarlo. Ma cosa significa scrivere una canzone? Per Paul è spesso una questione strutturale: si tratta di costruire un piccolo mondo, anche solo un appartamento.
Tra le caratteristiche inconfondibili dei giovane compositore McCartney c'è l'abitudine a variare la progressione armonica nel bel mezzo della strofa creando nell'ascoltatore un effetto sorpresa (i compositori suoi coetanei, se riescono ad azzeccare quattro accordi se li tengono, a volte per sicurezza non li cambiano nemmeno per il ritornello). Here There è l'esempio classico: si annuncia come canzoncina dolce dolce in quattro accordi, una scala ascendente lungo un intervallo di quarta (Sol, La-, Si-, Do) che ci fa desiderare di sbucare sul Re che completerebbe la quinta – e proprio quando ce l'aspettiamo Paul cambia tutto con Fa#-. Bisogna fare caso anche al testo: Paul ha appena detto "changing my life" e il Fa#- imprevisto avviene proprio "with a wave of her hand": scrivere canzoni non significa proprio costruire mondi che possono cambiare con un gesto della mano? È come se a un certo punto mentre ci mostrava il suo ménage immaginario, abbia aperto una porta e ci abbia condotto in una stanza diversa, da cui finalmente si accede al Re sospirato ma ormai inatteso.
E il bridge? È un'altra stanza ancora: per arrivarci si passa da uno strano scalino (Re-Fa-Sib) e quando per un attimo siamo convinti di esserci finalmente accomodati in una confortante 50s progression (Sib, Sol-, Do-), il quarto accordo è un Re7 e non sai più bene se sei nel vestibolo o nel salotto buono. Invece di accendere la luce Paul si è messo a intonare una melodia rétro ("and if she's beside me I know I need never care"); non fai in tempo ad ambientarti ("but to love her is to meet her...") che Paul accende la luce davvero e scopri che sei al punto di partenza! ("everywhere"). E non può non lasciarti ammirato il modo in cui il bridge si appoggia naturalmente sulla strofa successiva, persino dal punto di vista sintattico ("knowing that love is to share": non sono molte le canzoni in cui una frase comincia nel bridge e prosegue nel ritornello). Sei tornato da dove avevi cominciato, ma ora vedi tutto con un occhio diverso. Ci sono canzoni di McCartney che suscitano entusiasmo, affetto, malinconia, diffidenza (persino ripugnanza...): Here, There è la canzone che suscita ammirazione. Lennon la considerava una delle sue preferite non solo di McCartney, ma dei Beatles, e in effetti nel modo in cui il bridge trapassa immediatamente nella strofa riconosciamo un suo vecchio trucco di scena; a sua volta Lennon avrebbe fatto tesoro della principale suggestione di Here There, l'idea di una canzone che si rovescia in sé stessa come una scala di Escher. Il tratto distintivo più appariscente della canzone rimangono comunque i languidi coretti, un richiamo senza vergogna ai numeri dei crooner anni Quaranta. È uno dei rari casi in cui abbia ammesso un ripensamento, quando nel 1984 ripubblicò il brano nella colonna sonora di Give My Regards to Broad Street.
27. You've Got to Hide Your Love Away (Lennon-McCartney, Help!, 1965).
Eccomi qui, con la testa tra le mani. You've Got to Hide, lo dicono tutti, è la canzone in cui Lennon si rifà a Dylan. Diciamo pure che rifà Dylan: il timbro della voce rasenta la caricatura. È l'elemento più dylaniano di una canzone che non somiglia in particolare a nessun brano del Dylan folk – la parentela più probabile è con I Don't Believe You, in Another Side, che comincia con una rima molto simile, "I can't understand / she let go of my hand". In quegli anni la voce di Dylan era una sfida a tutto ciò che si poteva considerare radiofonicamente accettabile (un po' è ancora così: avete sentito per caso qualche brano del suo ultimo disco per radio?) Che i Beatles tentassero di imitarlo non era affatto scontato.
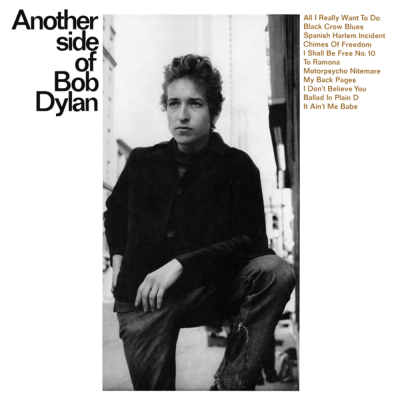 Dylan era un fenomeno di nicchia, anche in Inghilterra (dove la sua svolta rock avrebbe destato le reazioni peggiori nei fan): cominciava a essere un nome importante tra i frequentatori abituali dei negozi di dischi; era già il volto più celebre di quella cosa che di lì a poco si sarebbe cominciata a chiamare Controcultura; esibire i suoi dischi su mensole e tavolini conferiva già a studenti e professionisti un certa credibilità intellettuale. I Beatles, ormai onnipresenti sui media, giocavano in un altro campionato. Dylan avrebbe avuto tutti i motivi per disprezzare quei figurini venuti dal vecchio mondo a profanare la vera essenza dello spirito americano, la sua musica; invece li trovava fantastici sin dal primo momento impazziva proprio per le cose più smaccatamente pop, come I Want to Hold Your Hand, e non vedeva l'ora di incontrarli e fumarci assieme. Lennon dal canto suo avrebbe avuto più di un motivo per riservare a Dylan la stessa diffidenza che riservava ai coetanei che fino a quel momento potevano aspirare soltanto a porzioni della sua fama. Dylan in effetti è il più giovane tra gli autori che hanno avuto un peso rilevante nella sua formazione artistica: l'unico coetaneo che abbia preso a modello.
Dylan era un fenomeno di nicchia, anche in Inghilterra (dove la sua svolta rock avrebbe destato le reazioni peggiori nei fan): cominciava a essere un nome importante tra i frequentatori abituali dei negozi di dischi; era già il volto più celebre di quella cosa che di lì a poco si sarebbe cominciata a chiamare Controcultura; esibire i suoi dischi su mensole e tavolini conferiva già a studenti e professionisti un certa credibilità intellettuale. I Beatles, ormai onnipresenti sui media, giocavano in un altro campionato. Dylan avrebbe avuto tutti i motivi per disprezzare quei figurini venuti dal vecchio mondo a profanare la vera essenza dello spirito americano, la sua musica; invece li trovava fantastici sin dal primo momento impazziva proprio per le cose più smaccatamente pop, come I Want to Hold Your Hand, e non vedeva l'ora di incontrarli e fumarci assieme. Lennon dal canto suo avrebbe avuto più di un motivo per riservare a Dylan la stessa diffidenza che riservava ai coetanei che fino a quel momento potevano aspirare soltanto a porzioni della sua fama. Dylan in effetti è il più giovane tra gli autori che hanno avuto un peso rilevante nella sua formazione artistica: l'unico coetaneo che abbia preso a modello.A Lennon non interessa copiare una progressione di accordi o altri trucchi del mestiere. La maggior parte continua a portarseli da casa (persino nel ritornello di questo 'pezzo folk' si annida la cara vecchia cadenza I-IV-V di Twist and Shout): gli interessava l'atteggiamento, un modo completamente diverso di porsi nei confronti del pubblico, e che rendeva credibili tutta una nuova gamma di sentimenti che fino a quel momento John non aveva mai tentato di mettere tra i solchi. You've Got to Hide ritrae un innamorato frustrato e senza speranza che in effetti somiglia all'eroe di molte ballate acustiche di Dylan. Ma è proprio a questo livello che possiamo misurare la distanza: per Dylan la frustrazione sentimentale è sempre una questione intima, che al limite può essere condivisa con l'oggetto del proprio amore sfortunato (e delle proprie recriminazioni, che Dylan protrae per strofe e strofe).
Per Lennon questa intimità non esiste: ogni sentimento è un fatto sociale che assume un senso solo se c'è un coro che ascolta, osserva, commenta, e in questo caso gli ride in faccia: ehi, bisogna che quell'amore te lo metti via. Esiste un amore se nessuno lo guarda? You've Got to Hide è il lato oscuro di I Feel Fine: se per essere felici del proprio amore è necessario vantarsi con qualcuno, è proprio l'esistenza di tutti questi qualcuno a rendere insostenibile la situazione in cui l'amore non va in porto. Lennon è circondato da un coro di osservatori in maschera da clown che lo spìano, lo giudicano, lo irridono, lo costringono a coprirsi la faccia e voltarsi verso il muro. La ragazza quasi non c'entra, anzi sembra compassionevole. Una volte gli aveva persino detto "l'amore troverà una strada". (Due anni dopo, alla festa per il lancio di Magical Mystery Tour, Lennon imbarazzerà gli ospiti danzando tutta la sera con Patti Boyd Harrison).
26. Paperback Writer (Lennon-McCartney, singolo del 1966).
 "Gentile signore / gentile signora, leggereste il mio libro?" Nell'anno precedente la Arnoldo Mondadori Editore aveva tentato un esperimento: una collana di libri da vendere non nelle librerie, ma in edicola, in un formato tascabile (o come si dice in inglese, "paperback"). Il romanzo scelto per la prima uscita fu Addio alle armi di Ernest Hemingway, un titolo che le librerie italiane sfoggiavano ormai da vent'anni, ma chissà, forse in questo nuovo formato avrebbe intercettato un pubblico diverso. Sulla fragile copertina in cartoncino campeggiava ben evidente il nome piuttosto pacchiano della nuova collana, "Gli Oscar", nonché l'aspetto più allettante dell'edizione, il prezzo: sole 350 lire! Ne stamparono sessantamila copie, una follia. Finirono in giornata. Scoppiava anche in Italia il boom dei tascabili, "i libri-transistor che fanno biblioteca", si leggeva nel risvolto di copertina. "A casa, in tram, in autobus, in filobus, in metropolitana, in automobile, in taxi... Gli Oscar sono gli Oscar dei libri: si rinnovano ogni settimana, durano tutta la vita". Si sarebbero scollati molto prima, come ognuno di noi ben sa.
"Gentile signore / gentile signora, leggereste il mio libro?" Nell'anno precedente la Arnoldo Mondadori Editore aveva tentato un esperimento: una collana di libri da vendere non nelle librerie, ma in edicola, in un formato tascabile (o come si dice in inglese, "paperback"). Il romanzo scelto per la prima uscita fu Addio alle armi di Ernest Hemingway, un titolo che le librerie italiane sfoggiavano ormai da vent'anni, ma chissà, forse in questo nuovo formato avrebbe intercettato un pubblico diverso. Sulla fragile copertina in cartoncino campeggiava ben evidente il nome piuttosto pacchiano della nuova collana, "Gli Oscar", nonché l'aspetto più allettante dell'edizione, il prezzo: sole 350 lire! Ne stamparono sessantamila copie, una follia. Finirono in giornata. Scoppiava anche in Italia il boom dei tascabili, "i libri-transistor che fanno biblioteca", si leggeva nel risvolto di copertina. "A casa, in tram, in autobus, in filobus, in metropolitana, in automobile, in taxi... Gli Oscar sono gli Oscar dei libri: si rinnovano ogni settimana, durano tutta la vita". Si sarebbero scollati molto prima, come ognuno di noi ben sa.Nel Regno Unito la situazione era diversa, per il solito motivo che i britannici leggono di più. I paperback esistevano da inizio secolo e un boom delle vendite, se c'era stato, era avvenuto durante la Seconda Guerra, in un momento in cui i lettori si erano trovati più spesso in viaggio, sfollati o al fronte. I paperback erano il regno della letteratura di genere, e avevano spodestato le riviste pulp: gialli, intrighi di spionaggio, "sword and sorcery" (il termine fantasy doveva ancora prendere piede). Il protagonista di Paperback Writer non aspira alla fama di un Hemingway, non cerca l'Oscar: vuole scrivere robaccia che entri nelle case di tutti. Non lo spinge la sete di gloria, né la prospettiva di un guadagno. Non vuole finire come il padre, non vuole lavorare per sempre al Daily Mail. Quello che vuole fare nella vita è scrivere migliaia di pagine alla settimana – it took me years to write, will you take a look? Se riuscisse a farne un mestiere, sarebbe l'uomo più felice sulla terra, (dopo McCartney, ovviamente).
Pungolato dalla zia Lil, che voleva sentire almeno una canzone che non fosse d'amore, Paul ritorna sul sentimento che tutti nel 1966 hanno il diritto di provare, tranne lui: l'ambizione. Ma l'aspirante scrittore-di-tascabili non è animato come la ragazza di Drive My Car dalla fede nel successo finale, bensì da un desiderio irrefrenabile di creare mondi immaginari in cui forse rinchiudersi – anche se alla fine, non importa in quale galassia ambienti la tua saga, per qualche bizzarro motivo ci trovi dentro tuo padre. Proprio come Paul, che da lì a poco comincerà a intravedere l'ombra di "Father McCartney" sui set delle sue canzoni, l'aspirante scrittore di paperback comincia a inventarsi un personaggio ("è la lurida storia di un lurido uomo, e la sua affezionata moglie non lo capisce") e solo dopo un verso si rende conto che è di lui che la favola sta narrando. "Suo figlio lavora per il Daily Mail, è un bel posto fisso, ma lui vuole fare lo scrittore di paperback".
Sul piano musicale, Paul dichiara di voler proseguire l'esperimento già tentato da John con The Word, la canzone su un accordo solo: alla fine ne adopera due ma scarta l'intervallo più tipico, quello di quinta, come se una canzone senza amore non avesse diritto a sbocciarvi. La canzone rimane costretta in un più angusto intervallo di quarta che non si risolve mai – proprio come le richieste del protagonista non trovano mai un riscontro. È come se Paul stesse tentando di operare una sintesi tra le due anime che si erano espresse nel singolo di quattro mesi prima: Paperback è una canzone veloce (forse la più veloce di tutte) basata su un riff, come Day Tripper: come We Can Work It Out s'interrompe all'improvviso per lasciare spazio a un elemento vistosamente non-rock, un mini-coro a cappella che è rimasto a tutt'oggi uno degli stilemi più noti dei Beatles, e che però fino al 1966 non si era ancora sentito – e che anche in seguito i Beatles avrebbero adoperato con parsimonia. Il fatto che abbia lasciato un solco tanto profondo è la prova di quanto suonasse già allora caratteristico. Benché non compaia nessuno strumento classico, contiene già un rimando irresistibile alla 'musica seria': sta a Bach come i paperback stanno ai classici della letteratura. Il coro appare come una parrucca incipriata o una corona d'alloro che si cala all'improvviso sull'aspirante scrittore: il testo non lo dice, ma il coro ce lo fa capire, il ragazzo ha la stoffa. Forse non diventerà mai famoso, ma nella sua stanza, mentre batte a macchina centinaia di lettere al minuto, Paperback Writer è felice.
25. Can't Buy Me Love (Lennon-McCartney, singolo, del 1964, poi in A Hard Day's Night)
“Poi siamo andati in America, abbiamo fatto un giorno di vacanza a Miami ed è stato incredibile. C'era un mucchio di ragazze belle, sexy e abbronzate. Abbiamo fatto un servizio fotografico sulla spiaggia con loro e naturalmente abbiamo proposto loro di uscire con noi. La MG stava per mettere in vendita una sua nuova automobile, una decappottabile, e ce ne prestò una a testa proprio per farsi pubblicità. Ricordo di aver portato a cena una di quelle ragazze con questa automobile, ricordo quella notte in Florida, con le palme che ondeggiavano alla brezza. Un ragazzotto di Liverpool con una bella ragazza così in una decappottabile MG... avrei dovuto scrivere Money Can Buy Me Love, altro che can't!”
D'altro canto, cosa c'è di più swag di cominciare una canzone con "ti comprerò un anello di diamanti, amica mia, se questo ti fa stare bene"? Paul si fa venire in mente una frase del genere a Parigi in una camera di hotel che gli costa più o meno tutto quello che gli rende suonare all'Opéra dopo Sylvie Vartan. Non ha idea di quanto sta guadagnando, non ha idea di quanto sta spendendo, l'unica cosa che ha capito del denaro è che non ci può comprare l'amore ma non ne è nemmeno così sicuro. Però "tutti gli dicono così" (Everybody tells me so), e lui si fida. Can't Buy Me Love è l'apogeo della Beatlemania: lo incidono nell'esatto momento in cui I Wanna Hold Your Hand arriva in cima alla top100 americana. Andrà dritto al primo posto subito dopo I Wanna Hold e She Loves You, nel momento in cui nella stessa top100 ci sono 14 singoli dei Beatles. Nel 1963 tutto questo equivale a un sacco di soldi che Paul non è in grado di contare. Quello che può fare è cavalcare l'onda, comprando mobili e immobili prima che i soldi vengano assorbiti da qualche professionista di management o dagli uomini del fisco. Nel momento in cui in America nascono gruppi fotocopia come i "Beetles", nessuno ha bisogno che il prossimo singolo sia un capolavoro, davvero: e in effetti non lo è.
È anzi un brano atipico, in un momento in cui l'immagine dei Beatles dipendeva da una serie di stilemi molto riconoscibili: erano quelli che cantavano "Yeah Yeah", e Paul qui canta "No no no, no". Erano famosi per i coretti armonizzati in modo molto peculiare, e qui i Quattro, dopo averli incisi, decidono di farne a meno: scelta coraggiosa. Erano riconoscibili per le progressioni imprevedibili, e qui Paul opta nella strofa per uno schietta e prevedibile progressione blues. Suonano una miscela di rock e pop, ma qui Paul sembra avere in mente qualcosa di più classico e swingante, e più tardi si sentirà onorato della versione di Ella Fitzgerald. Come se i Beatles fossero già stanchi della formula che li sta coprendo d'oro – o semplicemente non hanno nient'altro per le mani e bisogna battere il ferro finché è caldo. In fondo poteva finire tutto tanto rapidamente quanto era iniziato, e cosa sarebbe rimasto? La consolante idea che con tutti quei soldi piovuti ed evaporati non avrebbero potuto comprarci un grammo d'amore. O no?
Can't Buy esce su singolo insieme a You Can't Do That: su un lato John si atteggia a maschio possessivo, sull'altro lato Paul spergiura che i soldi non danno la felicità. Suonano credibili entrambi, ma è solo l'inizio del 1964.
24. Blackbird (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968).
Take these broken wings and learn to fly. A Rikikesh come è noto Lennon e McCartney fecero progressi con la meditazione, ma soprattutto col fingerpicking. È emozionante notare come malgrado il maestro fosse lo stesso, i discepoli abbiano sviluppato immediatamente due stili completamente diversi – del resto il fingerpicking è una delle tecniche più idiosincratiche, ognuno ha una mano diversa e la chitarra se ne accorge più di altri strumenti. Se Lennon è più ossessivo, quasi alla ricerca dell'equivalente chitarristico di un mantra, Paul approfitta subito della possibilità di trattare la chitarra come una piccola orchestra, con una chiara ripartizione dei ruoli tra corde basse e acute. Una cosa di cui probabilmente nessuno si sarebbe accorto se Paul non ce l'avesse raccontato è che Blackbird trae ispirazione nientemeno che da da una breve frase della Bourrée in Mi- di Johann Sebastian Bach che John e Paul suonavano alle feste per dimostrare "che non eravamo stupidi come sembravamo". Ma siccome non erano nemmeno così brillanti, la loro Bourrée abortiva spontaneamente dopo otto battute (qualche anno più tardi una versione più completa sarebbe diventata un cavallo da battaglia dei Jethro Tull in concerto).
Quando a Rikikesh Paul scopre le potenzialità polifoniche della chitarra, l'indice della mano sinistra corre istintivamente sui tasti di quella bourée. Ricordiamo che il fingerpicking, che nel giro di pochi anni diventerà un luogo comune della cultura giovanile, nel 1968 era qualcosa di pionieristico che Donovan raccontava di aver appreso in Europa mentre viaggiava in una carovana di gitani. Comporre un brano in questo stile significa letteralmente brevettare diteggiature e accordi che nessuno ha ancora sentito: per qualche anno il segreto di come si suona Blackbird sarà gelosamente custodito e passerà solo da bocca di hippy a orecchio di hippy. Blackbird può approfittare di quell'estetica del non finito che trionfa nel Disco Bianco: qualche anno prima lo stesso Paul avrebbe sentito l'esigenza di annegarla nei violini, com'era successo a Yesterday. Nel 1968 i tempi sono maturi perché sul disco della band più famosa del mondo compaia un breve brano acustico col rumore del battito del piede in sottofondo. Quasi un invito ai chitarristi di tutto il mondo a cimentarcisi: prendete quelle ali spezzate, anzi quelle dita, e spiccate il volo. A parte il merlo ridondante in sottofondo, la stiamo ascoltando come l'ascoltarono le Apple Scruffs, le ragazze che si appostavano tutta la notte davanti all'appartamento di Paul, a cui una sera la suonò dal balcone, come una serenata al contrario (forse anche un invito a farsi una vita).
(Anche stavolta Paul non si risparmia un paio di incongruenze: come si fa a imparare a volare con "ali spezzate"? Come si fa a volare "nella luce di una notte buia e oscura"?).
 |
| Diana Ross e Brian Jones nel 1968. |
Non sembra una coincidenza il fatto che Blackbird appartenga a quel gruppetto di canzoni che cronologicamente Paul non poteva aver dichiarato a Jane Asher, ma che nemmeno poteva attribuire alla sua storia d'amore con Linda Eastmann. In quel periodo aveva una relazione un po' meno impegnativa con l'aspirante scrittrice Francie Schwartz. Francie era presente in Abbey Road durante le sessioni di alcuni brani del Disco Bianco, tra cui Blackbird, ma non sarebbe rimasta a lungo sullo stesso ramo di Paul. Ufficialmente non ci sono canzoni che parlano di lei. Blackbird dopotutto non deve parlare di nessuno in particolare: è una canzone che cattura semplicemente l'emozione di chi sta facendo qualcosa di fantastico per la prima volta. Cioè parla di sé stessa, e di quanto è fantastico riuscire a suonare per la prima volta Blackbird. Vola uccello nero, vola.
23. Come Together (Lennon-McCartney, Abbey Road, 1969).
 |
| Timothy Leary ma nel 1983, con la moglie e Susan Sarandon |
One and one and one is three. Uno dei tipici problemi della band che si stanno sciogliendo, è che i membri che scrivono le canzoni cominciano a mettere da parte le migliori. Dando un'occhiata ad Abbey Road e ai dischi solisti che uscirono pochissimi mesi dopo, appare abbastanza chiaro chi dei due soci stava già pensando a organizzarsi una carriera da solista e chi invece non si rassegnava. Lennon di lì a poco avrebbe buttato fuori Instant Kharma, Mother, Imagine, Working Class Hero, ma quando in estate i Quattro si ritrovarono in Abbey Road per assolvere i doveri contrattuali, sembrava aver meno musica da offrire di George Harrison. Giusto quel blues composto nei giorni di Twickenham, a cui avrebbe imposto una coda sinfonica che nelle sue intenzioni sarebbe diventata la marcia funebre del gruppo; un altro strano ghiribizzo beethoveniano, e qualche scarto del Disco Bianco. Tra gli altri c'era anche un brano alla Chuck Berry che aveva iniziato a comporre per Timothy Leary quando si era candidato alla carica di governatore della California contro un ex attore di serie B, Ronald Reagan; Leary si era fatto arrestare per possesso di marijuana prima che Lennon finisse il pezzo e così lo propose a Paul, con la preghiera di farlo suonare meno chuckberriano possibile: il tizio aveva la denuncia facile. Il brano prendeva il nome dallo slogan elettorale di Leary, “Come Together”: forse per un attimo l'idea di usarlo come tappabuchi nell'album del divorzio gli sembrò ironica: per completare il testo gli sarebbe stato sufficiente rispolverare un po' di quel surrealismo un tanto al chilo che non lo appassionava più come ai tempi di Lucy, ma di cui restava il maestro: et voilà, una canzone in un qualche modo ci sarebbe saltata fuori ed era tutto quello che serviva a Klein, un'altra manciata di canzoni per tranquillizzare azionisti e avvocati.
Invece saltò fuori un capolavoro.
I Beatles nel 1969 erano diventati Cinque. Già durante la lavorazione del Disco Bianco Harrison aveva capito che le sessioni diventavano più proficue se si invitava un quinto musicista. In certi casi era l'unico modo per smettere di trattarsi da vecchi amici scazzati e cominciare a trattarsi da professionisti. Purché fosse un musicista valido – qualcuno davanti al quale avrebbero avuto pudore di sbagliare – e anche una vecchia conoscenza, come Eric Clapton, o Billy Preston. Get Back, il primo singolo del 1969 era attribuito a "The Beatles With Billy Preston": un modo di valorizzare un musicista della scuderia Apple, ma anche l'ammissione che Preston non era il solito turnista di lusso invitato a dare un sapore particolare a una sola canzone: al di là di alcuni assoli effettivamente strepitosi, il suo organo Vox cambia davvero il suono dei Beatles. Ha un timbro inconfondibile che ci rimanda immediatamente a quegli anni a cavallo tra '60 e '70; uno tocco che trasuda professionalità americana e quindi crea uno scarto percepibile con lo stile più emotivo degli altri Quattro. Ciononostante, a un certo punto Lennon buttò lì l'ipotesi di far entrare Preston nel gruppo. Chi lo diceva, in fondo, che i Beatles dovessero restare sempre gli stessi quattro inglesi fino alla fine? Magari avrebbero potuto diventare qualcosa di diverso, un collettivo organico che si modifica, adattandosi ai tempi, alle sfide. Lennon diceva tutto quello che pensava e a volte anche cose che non pensava davvero (una volta che Harrison aveva sbattuto la porta aveva buttato lì di sostituirlo con Clapton). Ma se per un un attimo l'idea di un gruppo da Cinque lo poté solleticare, probabilmente fu davanti al risultato di Come Together. Una canzone che aveva scritto quasi per sbaglio, chiedendo esplicitamente ai colleghi di stravolgerla: un blues virato in minore, che all'improvviso prende vita. Secondo George Martin la molla che fece scattare il meccanismo fu il riverbero di un battito di mani di John vicino al microfono, che combinato con una nota insistita del basso di Paul creava un senso di mistero, accresciuto da quella sibilata palatale un po' inquietante, "shoot me!"
Dopodiché entra Ringo, con una delle sue più folli idee batteristiche: quattro tocchi al charleston e dieci ai tom. In qualsiasi altro gruppo, un qualsiasi altro batterista non avrebbe avuto nemmeno il coraggio di proporre qualcosa che anche a cinquant'anni di distanza suona così grottesco: ma erano i Beatles, potevano fare tutto. Durante le sessioni di Abbey Road, Come Together diventa quel blues drammatico e sospeso che avrebbe potuto essere Helter Skelter, prima che Paul decidesse di trasformarlo in un monumento al frastuono. Quel titolo che era rimasto attaccato per caso fu di ottimo auspicio: Come Together è il risultato più alto dei Beatles nella formazione a Cinque. Fanno tutti qualcosa di indispensabile: Lennon canta i suoi nonsense come fossero profezie della fine, Paul lo appoggia alla voce ma il suo basso è il collante di tutto il brano; Ringo ci mette la fantasia; George capisce al volo che il brano ha bisogno di un assolo lento, ipnotico; l'organo di Preston aggiunge un'arcana profondità. Come Together era la risposta del Dio della musica alla domanda di Lennon: che senso ha restare assieme? ecco che senso ha, imbecille. In questo studio persino la tua spazzatura diventa oro: potrebbe essere l'unico luogo dell'universo dove 1+1+1+1+1= infinito, e tu vuoi rinunciare a tutto questo? Questi stivali da tricheco, sai dove dovrei piazzarteli?
Sparami.
22. All You Need Is Love (singolo del 1967 per la trasmissione in mondovisione Our World; poi nell'edizione Capitol di Magical Mystery Tour).
Non c'è nulla che puoi fare che non possa essere fatto. Non si vive di soli Beatles, per esempio gli inglesi nel 1967 andavano anche pazzi per un personaggio tv, una spia impersonata dall'attore Patrick McGoohan. Dopo un inizio abbastanza convenzionale, verso il 1967 il personaggio sembrava andato fuori di testa (un po' come i Beatles) e la sua serie era diventata l'esperienza più psichedelica che i telespettatori potessero fare da sobri (oltre ad ascoltare i Beatles). Ora la serie si chiamava The Prisoner e mescolava in libertà Orwell, Huxley, James Bond e la Nouvelle Vague, in un calderone paranoico non sempre comprensibile ma che lasciava il segno. L'ultima puntata era attesa nel febbraio 1968. È la puntata in cui McGoohan, detto Numero 6, dopo avere sconfitto tutti i Numero 2 che lo tenevano recluso in una strana isola-campo-di-rieducazione, chiede e ottiene di incontrare il Numero 1, il personaggio misterioso che manovra tutti i fili della trama e che nessuno ha mai visto in volto. Tutto questo lo sto raccontando perché The Prisoner continuò a essere programmato a lungo in Italia, persino sui canali locali, e l'ultimo episodio è il primo ricordo che ho di All You Need Is Love. Per me, prima di essere un inno alla pace e all'amore, era il brano sparato all'unisono da cinque jukebox nella galleria che conduceva Numero 6 al rifugio di Numero 1. Probabilmente non capivo le parole, e comunque le avrei trovate molto ironiche, perché l'unico vero tema di tutte le 17 puntate di The Prisoner è il Lavaggio del Cervello, e All You Need Is Love è in effetti la classica cosa che un pool di psico-spie potrebbe cantarti mentre ti lobotomizzano. Più tardi si risente durante una sparatoria.
Una canzone originale dei Beatles in una fiction è un caso molto raro: anche nei pochi casi in cui succedeva, le canzoni venivano poi eliminate dalla versione home video. L'ultima puntata di The Prisoner è l'eccezione, probabilmente perché (secondo la testimonianza del figlio di George Harrison) il programma piaceva tantissimo a uno o più Beatles: al punto che tra i progetti cinematografici ipotizzati dopo Help! era stata sul tavolo anche l'ipotesi di fare una cosa in stile Prisoner. Difficilmente sarebbe venuta peggio di quel che poi fu realizzato davvero, ovvero The Magical Mystery Tour. Ma diciamo la verità: difficilmente sarebbe venuta peggio dell'ultima puntata di The Prisoner, una pagliacciata così avvilente, un tentativo così fallito di nascondere la mancanza di idee sotto un tappeto di ambiguità metafisiche, che al confronto l'ultima puntata di Lost è un capolavoro. Perché vi sto parlando di questo?
Perché l'imprinting è importante e nella canzone che per tutti più rappresenta la filosofia dell'amore universale, io ho sempre voluto cercare un fondo di ironia e paranoia. E retrospettivamente, devo ammettere, ho maturato su All You Need Is Love gli stessi dubbi che mi sono venuti rivedendo l'ultima puntata del Prigioniero: punto supremo di una coraggiosa visione artistica e filosofica, o canzone realizzata in fretta e furia nascondendo sotto un tappeto di aforismi enigmatici una certa mancanza di idee? Bisogna dire che All You Need Is Love è invecchiata molto meglio di The Prisoner, ma questo è il minimo: tutta la musica del 1967 è ancora ascoltabile, quasi tutta la tv di allora non è più guardabile. Sia McGoohan che i Beatles avevano oggettivamente poco tempo a disposizione: McGoohan per risolvere i misteri che avevano incollato milioni di spettatori al tubo catodico, Lennon e McCartney per produrre qualcosa all'altezza del loro nome per il primo programma in mondovisione, che sarebbe andato in onda in diretta il 25 giugno 1967. Ogni nazione portava in vetrina qualcosa di nuovo, e di potenzialmente interessante anche per gli stranieri: l'Italia portò le telecamere sul set di Romeo e Giulietta di Zeffirelli; il Regno Unito propose i Beatles.
Costoro potevano contare (a differenza di McGoohan) di un collaboratore che non li tradiva mai e che dimostrò nell'occasione una versatilità straordinaria. Lennon aveva per l'occasione una canzone dal testo più che appropriato: semplice, universale, un po' enigmatico ma è meglio un buon enigma di una pessima spiegazione. Il guaio è che lo aveva scritto su un tempo sghembo impossibile, una specie di sette quarti, una battuta rock e una valzer: e pretendeva che un'orchestra lo seguisse, su un tempo zoppo del genere, in Mondovisione. Qualcun altro lo avrebbe mandato a quel paese; George Martin ci rifletté sopra: il tema iniziale gli ricordava la Marsigliese. Perché non mettere proprio la Marsigliese? Non bisognava pagare i diritti a nessuno, dopotutto, e ai telespettatori francesi magari avrebbe fatto piacere. E già che ci siamo, perché non infilarci un concerto brandeburghese? E In The Mood?
Nel 1967 George Martin coglie subito il punto: i Beatles stavano diventando un feticcio culturale. La mondovisione sarebbe stata la consacrazione: i Beatles come Zeffirelli, come l'opera, la selezione del Reader's Digest. All You Need Is Love si candidava a diventare un inno generazionale ma la tv l'avrebbe portata ancora più in là nell'empireo della cultura middlebrow. Una simile occasione meritava pompa e circostanza. Le citazioni di All You Need non sono ironiche, sono necessarie come i volumi in pelle che si sfoggiano sulla libreria di un salotto rispettabile, altro che paperback da mezza sterlina. Una rivendicazione in diretta tv: siamo i Beatles, la Marsigliese del Novecento la stiamo componendo noi, qui, in diretta, con i nostri amici. Al centro di tutto questo monumento che si stanno scolpendo addosso, i Quattro cercano se possibile di restare seri. Non ce la fanno del tutto. Paul si mette a incitare il pubblico come l'artista circense che forse preferirebbe essere. Alla fine qualcuno (non si è mai capito chi) si mette a cantare “Yeah Yeah Yeah She Loves You” sulle auguste rovine di In the Mood: ha perfettamente senso (e anche In the Mood era diventato un feticcio da pochissimo: la generazione precedente lo considerava un semplice brano ballabile). Eppure, quello “Yeah Yeah Yeah” sembra la scritta lasciata da un teppistello su un monumento.
21. I Am the Walrus (Lennon-McCartney, lato B di Hello Goodbye e Magical Mystery Tour, 1967).
 LENNON: Io sono l'uomo uovo.
LENNON: Io sono l'uomo uovo.GLOUCESTER: Dite, mio buon signore, chi siete?
LENNON: Essi sono l'uomo uovo
EDGAR: Un pover’uomo domato dai colpi della Fortuna,
LENNON: Io sono il Tricheco...
Vale ancor più per I Am the Walrus lo stesso dubbio confessato per All You Need Is Love: geniale capolavoro o sublime presa in giro? E come nel caso di All You Need, non è che si debba per forza scegliere. I Am the Walrus potrebbe anche essere entrambe le cose. Ogni brano ha la sua leggenda, ma all'altezza di Walrus Lennon ne era consapevole e si divertiva manifestamente a confondere le acque. Ogni glossatore di Walrus si sente il dovere di elencare tutti i riferimenti già acquisiti: il tricheco è un famoso personaggio della solita Alice, un libro da John più citato che letto visto che si sarebbe accorto solo in seguito che si trattava di un bieco sfruttatore; "crema di materia gialla che cola dal cane morto" è il residuo di una filastrocca da cortile rammentata a John dall'ex compagno di giochi Pete Shotton; "Semolina Pilchard" sarebbe un riferimento al sergente di Scotland Yard Norman Pilcher, che lottava contro la droga indagando i VIP e aveva appena tentato di incastrare i Rolling Stones; i pinguini elementari che cantano Hare Krishna sarebbero un riferimento ad Allen Ginsberg o a i poser che credono che basti inneggiare a Krisha per salvare il mondo: nessuno però ha mai fornito un movente per il loro prendere a calci Edgar A. Poe. Tutto chiaro adesso? Rimane il dubbio: ha senso davvero occuparsi di tutto questo, ha senso discutere delle esperienze sessuali di Eric "egg-man" Burton con una ragazza caraibica e un uovo crudo, o chiarire l'identità della pornosacerdotessa che fa cascare le mutande a un ragazzo che sta facendo la birichina ("naughty girl")? Non stiamo semplicemente cascando a piedi pari nella trappola che Lennon ha allestito nel 1967, dopo avere scoperto che nelle scuole di Liverpool agli studenti venivano richieste interpretazioni dei suoi brani? Non è sufficiente derubricare il tutto a sberleffo nei confronti di chi insiste a farne un feticcio? Quattro anni prima era stato un critico musicale che si era ingegnato a trovare una "cadenza eolia" in una sua canzoncina per teenager; ora c'è già qualcuno che vuole mettere Strawberry Fields e Lucy in the Sky nelle antologie scolastiche, Lennon non ci sta.
Alla fine del 1967 I Am the Walrus richiama sin dalle prime note di mellotron il singolo uscito appena in febbraio, Strawberry Fields. In mezzo c'è stato uno degli anni più importanti della storia del costume e del rock; i Beatles hanno partecipato con un disco "en travesti" sospeso tra avanguardia e nostalgia che è andato bene ogni oltre più rosea aspettativa. È un anno che Lennon ha trascorso consumando LSD con una certa continuità, ma il brano che sembra voler riprendere Strawberry da dove si era fermata ci fa anche apprezzare la differenza. La sintassi franta e caotica di Strawberry, che sembrava davvero scritta in trance, lascia il passo a un nonsense compiaciuto che si ricollega al surrealismo giocoso degli scritti giovanili. È un Lennon che sta già cominciando a farsi il verso, e lo sa, e se ne diverte; i due brani di quel singolo di Natale sono forse l'espressione più pura di quella concezione di musica come gioco. L'orchestra di Martin, la radio che trasmette Shakespeare, il surrealismo, Alice: è tutto un giocattolo. Lennon si fa un punto di onore di usare tutti gli accordi della scala, che in inglese hanno le sette lettere dell'alfabeto: ABCDEFG, come un bambino che voglia usare tutti i tasti del suo strumento in miniatura. In particolare la cadenza del ritornello è bizzarra ma puerile: I-II-III.
Credo che chi ama I Am the Walrus ne colga soprattutto questa dimensione giocosa. Malgrado John continui a insistere che "sta piangendo": ma per una volta ci riesce più facile fidarci del video (una sequenza del Magical Mystery Tour) in cui ghigna per tutto il tempo. È anche merito di due compari che reggono il gioco in modo impareggiabile. Uno è Ringo Starr, che si prende cura della canzone offrendole un groove imprevedibile; di tutti i capolavori psichedelici Walrus è l'unico che si potrebbe ballare. Ringo ci crede particolarmente e allo stesso tempo non ruba mai la scena, anche perché questo spetta all'altro compare, George Martin.
I Am the Walrus è una di quelle canzoni che nascono più da uno stimolo cerebrale che da un'intuizione emotiva: Lennon vuole mettere alla prova le nostre derive interpretative e nel farlo non si preoccupa più di tanto di annoiarci. Il fatto che non succeda lo abbiamo sempre preso come una dimostrazione delle sue trascendentali capacità compositive... ma provate ad ascoltare su Anthology la stessa canzone senza l'orchestra diretta da Martin. Non diventa subito molto meno interessante? Martin considerava I Am the Walrus il suo score migliore, e parliamo del signore che aveva composto gli spartiti per Yesterday e Eleanor Rigby. Martin è solitamente considerato soprattutto l'anima sinfonica dei Quattro, sempre tentato dall'aggiungere violini e clavicembali là dove a volte non ce ne sarebbe bisogno. Lui stesso dopo l'avventura coi Beatles ha preferito presentarsi al pubblico come un rispettabile maestro d'orchestra: ma prima di incontrare gli stessi Beatles il suo mestiere era anche reperire suoni buffi per gli album di varietà che erano il core business della Parlophone,o per i programmi radiofonici di Peter Sellers. C'è in Martin una dimensione farsesca e giocosa che gli permise di individuare la stessa componente nei Beatles, e farla risplendere al momento giusto: più spesso quando lavorava con John. Dopo l'happening di A Day in the Life, con gli orchestrali invitati a mettersi in maschera e a suonare la fine del mondo; dopo il pandemonio postmoderno di All You Need Is Love; stavolta Martin convoca un coro di professionisti e li costringe a fare le boccacce ("hoo hoo haa haa"); obbliga nel finale gli archi a scendere mentre i bassi salgono: sta giocando, anche lui.
L'orchestrazione di I Am the Walrus la solleva letteralmente da terra, lasciandola sospesa in una nuvola surreale in cui tutto diventa possibile – al punto che Lennon può accendere una radio nel bel mezzo del brano e captare una scena di Re Lear che miracolosamente si introduce tra i versi del ritornello creando un senso sinistro là dove un senso non c'era. La vostra poesia che comporrete pescando frasi ritagliate a caso da un cappello vi assomiglierà, scriveva Tszara. Ripensandoci, è quasi una maledizione.
Walrus è l'ultimo trionfo della collaborazione tra Lennon e Martin. La lavorazione del brano comincia appena nove giorni dopo la morte di Epstein; uscirà nel momento forse più alto della traiettoria artistica dei Beatles, il momento in cui dopo Sgt Pepper hanno convinto quasi tutti e sanno di potersi permettere quasi tutto: che è proprio quello che fanno in Hello Goodbye e Walrus. A scegliere la prima come lato A del singolo sarebbero stati McCartney e Martin, gettando in Lennon i semi di una frustrazione che l'avrebbe portato, più di un anno dopo, a chiedere il divorzio. È una ricostruzione che lascia perplessi: se Lennon avesse davvero voluto quel lato A, non avrebbe evocato quella "pornographic priestress" più che sufficiente a bandire il brano dalla programmazione radiofonica sia nel Regno Unito che negli USA. Certo col senno del poi Walrus è rimasta molto più che Hello Goodbye, ma nemmeno Lennon credo che potesse immaginarlo a fine '67. In quel momento aveva soprattutto voglia di giocare – il che comunque era un buon segno – e forse non pensava nemmeno che il gioco gli sarebbe riuscito così bene.
Comments (4)
Lazzaro che morì due volte
29-07-2020, 01:38Bibbia, repliche, santiPermalink29 luglio - San Lazzaro, amico di Gesù
[2014] Tutti dobbiamo morire, e secondo la dottrina cristiana Gesù a tempo debito ci resusciterà. Tranne Lazzaro: lui è stato risorto prima. Così presto che è probabilmente già rimorto. Ma perché con lui Gesù si è comportato così? A prima vista sembrerebbe una debolezza: Lazzaro ha un trattamento di favore perché... è suo amico.
Gesù ha un solo amico: gli altri li chiama fratelli, o discepoli. Quando muore, ci rimane male. È il messia, è il Cristo, giudicherà i vivi e i morti, ma ci rimane male lo stesso. Davanti alla tomba scoppia a piangere. Non era successo per tre vangeli sinottici, ed ecco che succede nell'ultimo, quello di Giovanni. Anzi, un argomento per considerare il vangelo di Giovanni il più tardo è proprio questa virata nel patetico: all'estremo opposto sta il Gesù di Marco, probabilmente il più antico, un tizio sempre corrucciato e sdegnato perché i comuni mortali non hanno orecchie per intendere le sue parabole. Il Gesù di Giovanni invece sembra ridisegnato per un ceto medio che vuole bei discorsi ma anche una certa dose di sentimento.
Insomma, frigna come un pupo. Tanto che la gente comincia a darsi di gomito; però! Gli voleva bene davvero, al suo amico. Boh, ma se è davvero Chi dice di essere, non poteva arrivare un po' prima? Gesù non fa segno di ascoltare, ma chiede che sia aperta la tomba, malgrado le obiezioni della sorella più pratica, Marta ("Sono passati tre giorni, puzzerà"). E invece Lazzaro ne esce fuori fresco come appena deposto, e soprattutto esce vivo. Gesù l'ha risorto. Non è un miracolo come gli altri.
Gesù non aveva mai risorto nessuno prima. Certo, ci sarebbe l'episodio della figlia di Giairo, "capo di una sinagoga", riportato dai tre vangeli sinottici: ma non è chiaro se la bambina sia davvero morta. Lo stesso Gesù minimizza; afferma che la bambina sta solo dormendo, e la risveglia. Il caso di Lazzaro è molto diverso. Addirittura Gesù prende tempo; anche se le sorelle Maria e Marta gli avevano fatto sapere della malattia dell'amico, Gesù decide di aspettare che muoia. E agli apostoli prima di partire dice proprio così: Lazzaro è morto.
La decisione di risorgere Lazzaro non è una semplice debolezza, ma parte di un piano. I tre giorni di attesa sono fondamentali, non solo perché preannunciano la morte di Gesù, ma perché legalmente sono necessari affinché la resurrezione non possa essere derubricata a risveglio da un coma (quel che era successo nel caso della figlia di Giairo). Anche il dettaglio della puzza non è un semplice tocco di realismo: il testo vuole eliminare qualsiasi dubbio sul fatto che quella di Lazzaro sia stata una resurrezione, non una guarigione. Gesù ha scelto il suo amico per farne il cardine di tutto il Vangelo.
Non a caso nel testo di Giovanni occupa proprio il capitolo centrale: tra la prima parte, il cosiddetto "vangelo dei segni", e la seconda parte, il lungo racconto della passione. Nella prima parte Gesù ha esibito agli scettici tutti i "segni" necessari affinché credano che lui è il Messia - e che riprendono una profezia di Isaia: gli storpi camminano, i sordi odono, i ciechi vedono... i morti devono resuscitare. Lazzaro è appunto l'ultimo segno, la prova definitiva che Gesù è Colui che afferma di essere. Ma proprio la sua resurrezione è l'inizio della passione di Gesù: appena farisei e sommi sacerdoti si accorgono di che è successo, decidono di ammazzare sia Gesù che Lazzaro, il colpevole e la prova. L'idea di uccidere un tizio in grado di resuscitare dai morti può lasciare perplessi, ma il ragionamento dei sacerdoti non è poi così peregrino:
Giovanni è l'evangelista più filosofico, lo sanno tutti; mastica un po' di gnosi, e scrive molto bene; ma da un punto di vista meramente narrativo, sembra un autore di fanfiction - un lettore dei vangeli precedenti che si mette a ricamarci sopra perché molti episodi lo hanno lasciato insoddisfatto - inoltre crede di aver trovato dei buchi di sceneggiatura e non li sopporta. Perché Gesù non scoppia mai in lacrime? Non sarebbe bello se avesse un amico? Tra le domande che il fan-Giovanni si pone ce n'è una fondamentale: perché Gesù non ha mai resuscitato un morto? Ok, ha resuscitato sé stesso, ma solo alla fine. E però, molto prima della fine, ai discepoli di Giovanni Battista che gli chiedevano se fosse veramente il Messia aveva detto:
Un altro tratto tipico degli autori di fanfiction è il riutilizzo di nomi e personaggi minori. È un modo per sentirsi più 'canonici', vicini all'originale che stanno rielaborando. Giovanni evangelista riprende così le due sorelle Marta e Maria, già protagoniste di un breve e famoso diverbio nel vangelo di Luca; e le provvede di un fratello di cui nessuno fin qui ha sentito parlare, ma a cui Gesù voleva un bene dell'anima. Se il personaggio-Lazzaro è un'assoluta novità, il suo nome non è tuttavia nuovo: Eleazar ("Dio è il mio aiuto") era già il nome di un lebbroso in una parabola dei sinottici, costretto a mendicare davanti alla casa del ricco Epulone: da lui viene il termine "lazzaro" come sinonimo di "lebbroso" (da cui "lazzaretto"), nonché l'accrescitivo "lazzarone" . Poi Epulone finisce all'inferno e non può nemmeno supplicare che Lazzaro dal paradiso gli allunghi un po' d'acqua, tra i due oltremondi non vi è nessuna convenzione. Battezzando "Lazzaro" l'amico di Gesù, il Fan-Giovanni può anche alludere al luogo dove Lazzaro sarebbe stato nei tre giorni tra la morte e la prima resurrezione: il paradiso. Una questione che lasciava perplessi alcuni teologi, secondo i quali l'amico di Gesù non poteva che essere stato all'inferno: il paradiso era ancora chiuso. D'altro canto, il Lazzaro del vangelo di Giovanni non è un lebbroso, non è un mendicante; forse il fan-Giovanni stava soltanto cercando un nome di origine ebraica, per evitare di inventarsene uno che rischiasse di suonare falso a un orecchio più allenato del suo.
Lazzaro dunque dovrebbe morire e resuscitare una prima volta per risolvere un'incongruenza narrativa dei vangeli sinottici, e dimostrare incontrovertibilmente che Gesù è il messia. Giovanni dà particolare importanza dei "segni", i miracoli rivelatori; laddove gli altri evangelisti li snobbano un po', ammettendo in alcuni casi che Gesù li facesse controvoglia e li considerasse con sufficienza. La gente lo avrebbe dovuto seguire per quel che diceva, e non per i pani o i pesci, o un lebbroso guarito o un paralitico rialzatosi dalla sedia. Per Giovanni invece i "segni" sono fondamentali, e Lazzaro è il più importante.
Un altro indizio del carattere fittizio dell'amico di Gesù è la sua improvvisa scomparsa: così com'era apparso, fa sparire subito le sue tracce. Che fece durante la passione dell'amico? E dopo la resurrezione? Non si sa. Di sicuro non era coi Dodici, ma gli Atti degli Apostoli di lui non dicono niente (per forza, li aveva scritti Luca prima che Giovanni partorisse il personaggio). È lo stesso Fan-Giovanni a suggerirci una spiegazione: i sacerdoti del sommo sinedrio volevano far accoppare anche lui, magari ci sono riusciti. Un'altra teoria, ma molto più tarda, è che Lazzaro sia stato occultato dai proto-cristiani proprio perché il sinedrio gli dava la caccia. Paolo di Tarso lo avrebbe portato a Larnaca, nell'isola di Cipro, di cui Lazzaro sarebbe diventato il vescovo fino alla sua seconda morte, trent'anni dopo. La leggenda orientale dice che non sorrise mai, per tutto il tempo, a causa di quello che aveva visto nei suoi tre giorni da morto. Dunque era stato all'inferno. Solo una volta gli sarebbe scappato un sorriso - davanti a un ladro di vasellame - dopo aver sentenziato: "L'argilla ruba l'argilla".
L'ipotesi occidentale, che i lettori di Dan Brown magari conoscono, è che Lazzaro sia miracolosamente approdato con le due sorelle nel Midi della Francia, diventando il primo vescovo di Marsiglia. La devozione dei marsigliesi fu tale che nel 1204, durante la Quarta Crociata, (detta anche saccheggio di Bisanzio) si portarono a casa le reliquie. Poi le persero, forse anche in seguito a una riflessione: se davvero le sue ossa erano custodite a Bisanzio, Lazzaro non avrebbe mai potuto evangelizzare Marsiglia. In ogni caso i suoi resti si possono venerare ad Autun e a Vézelay in Borgogna - oltre che naturalmente a Larnaca. A Vendome invece c'è un'ampolla con le lacrime che Gesù avrebbe pianto davanti al suo amico. Forse perché sapeva di averlo lasciato scendere all'inferno, anche solo per tre giorni. Oppure perché davvero gli voleva bene.
 |
| (Juan De Flandes) Ce n'hai messo di tempo, eh, amico. |
Gesù ha un solo amico: gli altri li chiama fratelli, o discepoli. Quando muore, ci rimane male. È il messia, è il Cristo, giudicherà i vivi e i morti, ma ci rimane male lo stesso. Davanti alla tomba scoppia a piangere. Non era successo per tre vangeli sinottici, ed ecco che succede nell'ultimo, quello di Giovanni. Anzi, un argomento per considerare il vangelo di Giovanni il più tardo è proprio questa virata nel patetico: all'estremo opposto sta il Gesù di Marco, probabilmente il più antico, un tizio sempre corrucciato e sdegnato perché i comuni mortali non hanno orecchie per intendere le sue parabole. Il Gesù di Giovanni invece sembra ridisegnato per un ceto medio che vuole bei discorsi ma anche una certa dose di sentimento.
Insomma, frigna come un pupo. Tanto che la gente comincia a darsi di gomito; però! Gli voleva bene davvero, al suo amico. Boh, ma se è davvero Chi dice di essere, non poteva arrivare un po' prima? Gesù non fa segno di ascoltare, ma chiede che sia aperta la tomba, malgrado le obiezioni della sorella più pratica, Marta ("Sono passati tre giorni, puzzerà"). E invece Lazzaro ne esce fuori fresco come appena deposto, e soprattutto esce vivo. Gesù l'ha risorto. Non è un miracolo come gli altri.
Gesù non aveva mai risorto nessuno prima. Certo, ci sarebbe l'episodio della figlia di Giairo, "capo di una sinagoga", riportato dai tre vangeli sinottici: ma non è chiaro se la bambina sia davvero morta. Lo stesso Gesù minimizza; afferma che la bambina sta solo dormendo, e la risveglia. Il caso di Lazzaro è molto diverso. Addirittura Gesù prende tempo; anche se le sorelle Maria e Marta gli avevano fatto sapere della malattia dell'amico, Gesù decide di aspettare che muoia. E agli apostoli prima di partire dice proprio così: Lazzaro è morto.
...e io sono contento per voi di non essere stato là, perché voi crediate. Orsù, andiamo da lui!
 |
| (Giotto) E gli amici li tratti così, figurati gli altri. |
Non a caso nel testo di Giovanni occupa proprio il capitolo centrale: tra la prima parte, il cosiddetto "vangelo dei segni", e la seconda parte, il lungo racconto della passione. Nella prima parte Gesù ha esibito agli scettici tutti i "segni" necessari affinché credano che lui è il Messia - e che riprendono una profezia di Isaia: gli storpi camminano, i sordi odono, i ciechi vedono... i morti devono resuscitare. Lazzaro è appunto l'ultimo segno, la prova definitiva che Gesù è Colui che afferma di essere. Ma proprio la sua resurrezione è l'inizio della passione di Gesù: appena farisei e sommi sacerdoti si accorgono di che è successo, decidono di ammazzare sia Gesù che Lazzaro, il colpevole e la prova. L'idea di uccidere un tizio in grado di resuscitare dai morti può lasciare perplessi, ma il ragionamento dei sacerdoti non è poi così peregrino:
"Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui e verranno i Romani e distruggeranno il nostro luogo santo e la nostra nazione".Col suo nuovo culto, potenzialmente rivoluzionario, Gesù rischia di attirare l'attenzione della potenza occupante. Chi scrive il Vangelo probabilmente sa già di cosa sono capaci i Romani – che raderanno davvero al suolo Gerusalemme nel 70. "Meglio che muoia lui, piuttosto che un popolo intero", dice il sommo sacerdote. Una frase troppo bella e pregna di significato per essere stata pronunciata davvero. Tutto l'episodio sembra, in effetti, una costruzione a posteriori, di un autore che conosce per sommi capi il racconto evangelico, ma vuole dargli un senso nuovo, un respiro diverso (oltre a spruzzare un po' di sentimenti qua e là).
 |
| Wake up dead man (Caravaggio) |
Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano.Questo è Matteo 11, ma i morti che risuscitano chi sono? In Matteo non ci sono! Ok, la figlia di Giairo, ma possiamo veramente contarla? Con lo stesso Gesù che afferma "non è morta ma dorme"? Insomma qui c'è un buco, bisogna riempirlo. Ma con cosa?
Un altro tratto tipico degli autori di fanfiction è il riutilizzo di nomi e personaggi minori. È un modo per sentirsi più 'canonici', vicini all'originale che stanno rielaborando. Giovanni evangelista riprende così le due sorelle Marta e Maria, già protagoniste di un breve e famoso diverbio nel vangelo di Luca; e le provvede di un fratello di cui nessuno fin qui ha sentito parlare, ma a cui Gesù voleva un bene dell'anima. Se il personaggio-Lazzaro è un'assoluta novità, il suo nome non è tuttavia nuovo: Eleazar ("Dio è il mio aiuto") era già il nome di un lebbroso in una parabola dei sinottici, costretto a mendicare davanti alla casa del ricco Epulone: da lui viene il termine "lazzaro" come sinonimo di "lebbroso" (da cui "lazzaretto"), nonché l'accrescitivo "lazzarone" . Poi Epulone finisce all'inferno e non può nemmeno supplicare che Lazzaro dal paradiso gli allunghi un po' d'acqua, tra i due oltremondi non vi è nessuna convenzione. Battezzando "Lazzaro" l'amico di Gesù, il Fan-Giovanni può anche alludere al luogo dove Lazzaro sarebbe stato nei tre giorni tra la morte e la prima resurrezione: il paradiso. Una questione che lasciava perplessi alcuni teologi, secondo i quali l'amico di Gesù non poteva che essere stato all'inferno: il paradiso era ancora chiuso. D'altro canto, il Lazzaro del vangelo di Giovanni non è un lebbroso, non è un mendicante; forse il fan-Giovanni stava soltanto cercando un nome di origine ebraica, per evitare di inventarsene uno che rischiasse di suonare falso a un orecchio più allenato del suo.
 |
| Stavo a fare il muschio, ormai (Spagnoletto). |
Un altro indizio del carattere fittizio dell'amico di Gesù è la sua improvvisa scomparsa: così com'era apparso, fa sparire subito le sue tracce. Che fece durante la passione dell'amico? E dopo la resurrezione? Non si sa. Di sicuro non era coi Dodici, ma gli Atti degli Apostoli di lui non dicono niente (per forza, li aveva scritti Luca prima che Giovanni partorisse il personaggio). È lo stesso Fan-Giovanni a suggerirci una spiegazione: i sacerdoti del sommo sinedrio volevano far accoppare anche lui, magari ci sono riusciti. Un'altra teoria, ma molto più tarda, è che Lazzaro sia stato occultato dai proto-cristiani proprio perché il sinedrio gli dava la caccia. Paolo di Tarso lo avrebbe portato a Larnaca, nell'isola di Cipro, di cui Lazzaro sarebbe diventato il vescovo fino alla sua seconda morte, trent'anni dopo. La leggenda orientale dice che non sorrise mai, per tutto il tempo, a causa di quello che aveva visto nei suoi tre giorni da morto. Dunque era stato all'inferno. Solo una volta gli sarebbe scappato un sorriso - davanti a un ladro di vasellame - dopo aver sentenziato: "L'argilla ruba l'argilla".
L'ipotesi occidentale, che i lettori di Dan Brown magari conoscono, è che Lazzaro sia miracolosamente approdato con le due sorelle nel Midi della Francia, diventando il primo vescovo di Marsiglia. La devozione dei marsigliesi fu tale che nel 1204, durante la Quarta Crociata, (detta anche saccheggio di Bisanzio) si portarono a casa le reliquie. Poi le persero, forse anche in seguito a una riflessione: se davvero le sue ossa erano custodite a Bisanzio, Lazzaro non avrebbe mai potuto evangelizzare Marsiglia. In ogni caso i suoi resti si possono venerare ad Autun e a Vézelay in Borgogna - oltre che naturalmente a Larnaca. A Vendome invece c'è un'ampolla con le lacrime che Gesù avrebbe pianto davanti al suo amico. Forse perché sapeva di averlo lasciato scendere all'inferno, anche solo per tre giorni. Oppure perché davvero gli voleva bene.
Comments (1)
Le canzoni dei Beatles (#40-31)
23-07-2020, 00:30PermalinkPuntate precedenti: (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#200-181), (#180-166), (#165-156), (#155-146), (#145-136), (#135-121), (#120-111), (#110-96), (#95-86), (#85-76), (#75-66), (#65-56), (#55-46), (#45-36)
Spero che stiate bene, io sto solo dormendo, che abbiamo in lista questa settimana? La canzone che qualcuno pensava parlasse di sparare alla gente e invece parlava di una giostra; quella che tutti pensavano che parlasse di droga e invece parlava di sparare alla gente; quella che sembrava parlasse di sesso e invece parlava di droga, e qualche altra ancora. Ricordo che la classifica non la faccio io: è una media di tutte le classifiche messe on line da critici specializzati. Certo che Happiness Is A Warm Gun andava messa più avanti. Sono d'accordissimo. Non sparate. Non su di me, almeno.
40. I'm Only Sleeping (Lennon-McCartney, Revolver, 1966).
Lying there and staring at the ceiling, waiting for a sleepy feeling... Tutti rimpiangono il vinile, pensano che la musica si sentisse meglio prima. Io penso siano pazzi, ma d'altro canto ho un rimpianto per i nastri magnetici... Ok, erano un disastro. Anche quelli che non si erano ancora rovinati avevano un fruscio tremendo – e comunque stavano per rovinarsi. Però nella mia testa la musica è rimasta un nastro magnetico. Se fermi il nastro, fermi la musica. Se inverti il lato, la musica scorre a rovescio. Ogni canzone era un percorso da un punto A a un punto B; se volevi riascoltarla, dovevi fare il percorso a ritroso. La stessa cosa non succede con le vostre giornate? Diciamo che A sia il momento in cui vi svegliate; B quello in cui vi addormentate: che cos'è il sonno? Il segmento BA, il momento in cui chiudete gli occhi e riavvolgete il nastro. E chi è John Lennon nel 1966-1966, quando i Beatles si ritirano dalle scene e non c'è più bisogno di tenersi svegli ingollando anfetamine? Un nastro rovesciato che non riesce più a raddrizzarsi e nemmeno ne sente l'esigenza. Dal suo giaciglio di Kenwood vede il mondo girare all'incontrario. Suona il telefono, è Paul, vorrebbe scrivere una canzone. Please don't wake me, no don't shake me, leave me where I am...
I'm Only Sleeping è il seguito di Nowhere Man, per come riprende l'attitudine diaristica di dedicare almeno una canzone dell'album al proprio stato d'animo dominante. Come si sentiva John Lennon nella primavera del 1966, all'apice della Swinging London? Ancora parecchio sonnacchioso. Poca voglia di uscire, scarsa disponibilità a recitare la parte dell'uomo di casa. Il brano che porta in studio sotto forma di demo è un lontano parente di Girl: attinge allo stesso serbatoio inconscio di melodie rétro, vecchie ballate in minore e frasi jazz ascoltate alla radio chissà quando . Il blend è già inconfondibilmente lennoniano: vedi il bridge ("keeping an eye on the world going by my window"), tagliato così corto ("taking my time") che non fai in tempo a notarlo ed è già ripartita la strofa ("When I wake up early in the morning"), quasi il ripensamento di un dormiglione che stava per alzarsi, e soprattutto quel magico accordo in maggiore settima, parente non lontano di quello che attutiva l'angoscia in No Reply: qui è soffice come il guanciale su cui casca il ritornello, quando Lennon canta "sleeping".
In studio John raffina il timbro della voce, incisiva ma fragile, e la correda di quei coretti vagamente swing che sembrano davvero usciti da una pigra radiosveglia mattutina. Nel bridge invece interviene Paul con un contrappunto più virile, come se tentasse di scrollare John e svegliarlo; ma niente da fare. Siccome George è occupato a sperimentare con la chitarra invertita, i fraseggi di connessione tra il ritornello e la strofa vengono delegati al basso di Paul e raggiungono il nostro orecchio attutiti, compressi, come i colpetti amorevoli di qualcuno che cercasse di svegliarci. Ma il punctum del brano ovviamente è la chitarra rovesciata di George.
I Quattro avevano iniziato a rovesciare i nastri con Rain; l'esperimento prosegue con I'm Only Sleeping ed è una trovata geniale non solo perché le sonorità rovesciate si adattano all'andamento languido e jazzeggiante. In I'm Only Sleeping quello che fino a quel momento era ancora un trucco di laboratorio diventa il correlato sonoro di un fenomeno tanto vicino all'esperienza di tutti quanto misterioso: il sonno, per la prima volta immaginato come il lato B della veglia. Suonare un assolo a rovescio è come mandare un messaggio a sé stessi in sogno: George compone l'assolo, ne incide una prova, lo rovescia per sentire come deve suonarlo, lo incide a rovescio e poi lo rivolta di nuovo. Se potessimo ricevere messaggi dal piccolo aldilà dei sogni, probabilmente avrebbero la consistenza sfuocata eppure familiare dei fraseggi di chitarra rovesciati di George. E non è una coincidenza che la chitarra invertita torni alla fine del pezzo: dopo averci pensato un po' su, John si è riaddormentato.
39. Happiness Is a Warm Gun (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968)
Non è una ragazza cui manchi qualcosa. Derek Taylor in un albergo aveva conosciuto un tale che usava i guanti di velluto con le ragazze, diceva che gli piaceva la "sensazione insolita". Come una di quelle lucertole che in California restano schiacciate tra i vetri scorrevoli delle finestre. In uno stadio di Manchester avevano beccato un tizio che nascondeva degli specchietti nella punta dei suoi stivali chiodati e li usava per guardare le mutandine delle ragazze della fila superiore (a quei tempi negli stadi inglesi si stava in piedi). C'è gente che finge di avere un braccio in gesso per rubare nei negozi ("while his hands are busy working overtime"). Nel Merseyside l'eufemismo per "defecare all'aperto" è "donare al Fondo Nazionale" ("donate to the National Trust"). Ho bisogno di una risistemata perché mi sto abbattendo, mi sto riducendo ai pezzi che ho lasciato in città. Madre Superiora, salta la pistola. La felicità è una pistola calda.
Lo disse Cechov, no? Se c'è una pistola in scena, prima o poi qualcuno sparerà. Se si eccettua il titolo un po' enigmatico dell'album del 1966, le armi da fuoco non entrano nel catalogo beatle fino al Disco Bianco, dove compaiono in almeno tre numeri: il siparietto western Rocky Raccoon, la satira animalista Bungalow Bill (dove "gun" fa rima con "mum") e ovviamente Happiness Is a Warm Gun. Anche qui c'è una Madre nei dintorni. Lennon per l'occasione ritorna al metodo che tante soddisfazioni aveva dato a lui e agli ascoltatori con A Day in the Life: distillare surrealismo dai titoli di giornale. "La felicità è una pistola calda" lo aveva scovato sulla rivista della National Rifle Association. "Una pistola calda significa che hai appena sparato a qualcuno. Pensavo che fosse una cosa favolosamente malata da dire". Forse aveva anche intenzione di scrivere una canzone d'amore sui generis a Yoko (nel demo di Anthology 3 si sente chiaramente il suo nome dopo il riferimento alla Madre Superiora), ma alla fine tutte le suggestioni si mescolano in un unico calderone surreale che forse è l'ultimo contributo del LSD alla creatività beatle. Ovviamente "I need a fix" e "jump the gun" furono subito interpretati come riferimenti all'eroina (anche McCartney nutriva sospetti in tal senso). Lennon lo ha sempre negato: non aveva ancora iniziato ad assumerne, e non avrebbe mai usato la siringa. Non importa: le immagini che gli vorticano incontro finiscono per confondersi. Sesso, droga, statuine di sapone, armi da fuoco, tutto preme per entrare, in un corpo che dovrebbe rilassarsi e accettare la pace – madre superiora, salta la pistola (su BeatleBible un tizio scrive di essersi svegliato nel cuore di una notte con un'intuizione: Lennon recita "Mother Superior jump the gun" sei volte, come i sei colpi nel tamburo di un revolver).
Il finale doo-wop in cui in un qualche modo Ringo riesce a tenere il 4/4 mentre tutto il resto frana in terzine, è un'esplicita "satira del R'n'R anni 50", lo stesso Lennon lo definiva così, ed è un esempio felice di come certe idee possano incubarci dentro per anni: uno dei più antichi documenti sonori che ci sono rimasti di John e Paul è proprio una registrazione domestica di un pezzo doo-wop parodistico. Nel 1960 Paul stava già mimando i coretti alti mentre John improvvisava fesserie al microfono con un vocione impostato. Una simile 'strofa parlata' compariva nel demo di I'm So Tired, finché Lennon non ha l'idea risolutiva di staccarla e rimontarla alla fine di Happiness... Il risultato è un collage d'immagini sospese tra iper-realismo, mistero e parodia, che ricorda irresistibilmente la pop art e in particolare i collage di Richard Hamilton che dieci anni fa lo avevano anticipato. È lo stesso Hamilton che Paul aveva appena presentato ai colleghi e che avrebbe 'disegnato' la copertina del Disco Bianco.
Si dice spesso che i Quattro durante la lavorazione del Bianco non riuscissero più a suonare assieme. Eppure la canzone in assoluto più provata in studio da tutti e quattro è Happiness Is a Warm Gun, più di settanta take. È un pezzo che solo John Lennon avrebbe potuto proporre agli altri tre, ed è un pezzo che solo gli altri tre non avrebbero respinto al mittente, ma che roba è, ci prendi in giro? Una decina di cambi di tempo? Paul McCartney non ha mai smesso di dire che Happiness è una delle sue preferite. Per Ringo (a cui il brano chiedeva un vero tour de force) fu una specie di nuovo inizio. Quanto a George, basta sentire quel che combina durante il pezzo: la credibilità blues che riesce a offrire con la sua chitarra in I need a fix, nel bel mezzo di un brano che sembrerebbe mandare tutto in burla. Happiness segue in scaletta a While My Guitar Gently Weeps. Quando chiedevano a George il suo brano preferito, rispondeva Happiness. Senza Happiness probabilmente nessuno avrebbe proposto il successivo progetto Get Back, l'idea di abolire le sovraincisioni e rimettersi a suonare in presa diretta. Una missione troppo impegnativa, col senno del poi. D'altro canto, erano appena riusciti a incidere Happiness: che altra sfida potevano darsi?
Musicalmente è il passo avanti più importante del Disco Bianco: non è la prima canzone a nascere come un patchwork di brani musicali distinti (anche in questo è A Day In the Life l'antecedente illustre), ma in Happiness per la prima volta viene a mancare l'elemento ricorrente che dia al patchwork una sensazione di unità. Happiness è un medley di tre-quattro brevi canzoni che non hanno altro collegamento fuori che la libera associazione di immagini che ruotano nella testa di John. Il procedimento sarà ripreso poi nel secondo lato di Abbey Road e diventerà un topos ricorrente nella carriera post-Beatles non di Lennon, ma di McCartney (Uncle Robert / Admiral Halsey, Band on the Run). Happiness resta un esempio folgorante di cosa potevano fare i Quattro ancora nel 1968 quando erano disposti a seguire John alla ricerca del metodo nella sua follia. Rimane uno dei loro brani più interessanti e memorabili: e lo sarebbe anche se qualcuno non avesse tirato fuori una pistola non metaforica, davanti in Central Park West, dodici anni dopo.
38. Helter Skelter (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968)
Nell'ultimo film di Tarantino, [SPOILER!!!] i killer della Manson Family sbagliano campanello, incontrano Brad Pitt, e Sharon Tate si salva. Tarantino sembra soffrire della stessa forma di follia che opprime alcuni beatlemani, come un'incapacità di elaborare il lutto. Se solo la data persona non avesse fatto la data cosa, oggi le cose sarebbero diverse, ad esempio i Beatles non si sarebbero sciolti. O Lennon sarebbe vivo. Si chiama 'razionalizzare', ma in realtà è un sistema per impazzire. Continui a ripensare e ripensare allo stesso giorno, alle cose che avresti potuto fare e che avrebbero potuto cambiare il destino. Ti fai domande oscene, ad esempio: se Helter Skelter non fosse diventata quell'orgia rumoristica che è, Sharon Tate e i suoi ospiti sarebbero ancora vivi? (No).
Per quanto possano avervi detto il contrario, la prima impressione è fondamentale, e questo separa gli ascoltatori di Helter Skelter in tre insiemi che praticamente ascoltano tre canzoni diverse. Vediamoli a ritroso, dal terzo insieme al primo.
3. Nel primo insieme ci sono quelli che l'hanno ascoltata dopo aver sentito parlare della strage a casa Polanski: Helter Skelter era per Charles Manson il nome in codice della guerra tra le razze che sarebbe scoppiata di lì a poco negli USA, e ai suoi adepti era stato dato il compito di fomentarla uccidendo giovani ricchi bianchi e famosi (Manson conosceva la casa perché per un po' era appartenuta a Terry Melcher, il produttore discografico che aveva stroncato senza appello i suoi demo e le sue velleità di aspirante rockstar). Questo insieme di persone non credo possa ascoltare Helter Skelter senza pensare a tutta la storia, che è oggettivamente pazzesca. Per loro Helter Skelter non può che essere la colonna sonora di quella storia, un segno rosso indelebile che pregiudica credo irrimediabilmente l'ascolto del Disco Bianco.
2. Nel secondo insieme ci sono quelli che hanno conosciuto i Beatles dopo lo scioglimento, in un periodo in cui i delitti della Family erano passati in secondo piano, e la musica dei Beatles no. Per loro Helter Skelter è un pezzo allegro, che si associa alla scoperta che ciascuno di loro un giorno ha fatto di questa buffa circostanza: il primo brano heavy metal della Storia è di Paul McCartney, l'autore di Obladì Obladà. È persino nello stesso disco! Helter Skelter in realtà non ha molto in comune con l'heavy metal, ma a un primo ascolto l'impressione è abbastanza forte (quella chitarra sferragliante in primo piano, quelle urla sguaiate, perfino i coretti prefigurano un certo glam rock) e questo mette di buonumore, perché un brano heavy dei Beatles non può essere che una parodia. Addirittura una parodia di un genere musicale che ancora non esisteva! Che geniacci questi Beatles. Gli appartenenti a questo gruppo hanno più possibilità di riconciliarsi con l'approccio sperimentale di Sir Paul McCartney, che parte quasi sempre dalle caratteristiche formali, laddove Lennon muove più spesso da una necessità espressiva: John fa cose nuove per cercare di spiegarsi in modo nuovo, Paul le fa per curiosità, a volte per rispondere a una sfida. In questo caso il guanto l'aveva gettato Pete Townshend degli Who, dichiarando da qualche parte: "Abbiamo appena registrato la canzone più sporca, rumorosa, lurida ever". A tutt'oggi Paul non sa di che canzone si trattasse – non l'ha mai voluto sapere. L'idea che un collega possa superarlo in qualsivoglia categoria lo fa sentire "geloso". E così, magari davanti a una tazza di tè, Paul delibera che i Beatles faranno qualcosa di ancora più sporco, rumoroso, lurido. Tanto di spazio sul disco ce n'è.
È un aneddoto che decostruisce completamente l'aggressività della canzone, e forse è questo il motivo per cui dopo la strage McCartney ha sentito la necessità di raccontarlo più e più volte. Non c'è nessuna violenza interiore a emergere nel fracasso di Helter Skelter: è solo un gioco. Prima che Paul decidesse di farlo esplodere, Helter Skelter era già un ottimo pezzo blues rock (lo si sente in Anthology 3), anzi forse era più promettente. Paul alternava momenti di calma apparente a improvvisi scoppi di impazienza, creando un effetto suspense che nella versione finale manca del tutto. Tra i vari effetti che Paul decide di "alzare a 11" c'è il riverbero, il che finisce per richiamare alla sua memoria i vecchi dischi rockabilly – a un certo punto durante le prove si mette a imitare Elvis intonando You're So Square. C'è in effetti una caricatura di Elvis sepolta tra i rottami di Helter Skelter. Il Disco Bianco è pur sempre una festa, e Charles Manson un imbucato psicotico che non riesce ad ambientarsi, non conosce i riferimenti, per esempio non sa che l'"helter skelter" britannico è una tipica attrazione da fiera, uno scivolo che ruota intorno a una torre smontabile. E decide, da psicotico, che un'espressione incomprensibile non può che essere un riferimento alla fine del mondo. Se non avesse ascoltato Helter Skelter, avrebbe trovato profezie di guerre fratricide in qualche altra canzone dei Beatles o di qualche altro gruppo.
1. Nel primo insieme (che con gli anni andrà riducendosi) rimane chi Helter Skelter l'ha sentita quando uscì e negli anni immediatamente successivi: quelli che non potevano liquidarla come una parodia del metal perché il metal, appunto, non era ancora nato. Per alcuni di loro Helter Skelter è stato uno choc al quale niente li aveva preparati – davvero, niente suonava così distorto, così rumoroso, così sporco. Quello che per Paul era uno scherzo, un esperimento di laboratorio, per qualche giovane ascoltatore poteva risultare un incubo. Come svegliarsi a un'ora imprevista sul divano e trovarsi davanti a una tv accesa nelle ore in cui trasmette le cose che capiscono solo i tuoi genitori, intercettando immagini incomprensibili che saltano dritte nella sala 101 del tuo materiale onirico. Forse semplicemente Helter Skelter era più di quello che molti giovani ascoltatori del tempo potevano sopportare – Charlie Manson incluso. È l'unica canzone beatle su duecento e più che ispira al musicologo Alan W. Pollack un genuino turbamento: "mettetela su di notte quando le luci sono spente ed è garantito che vi farà rizzare i peli sulla schiena: vi spaventerà e vi metterà a disagio". A me non succede (ci ho appena provato) ma è vero che sono di una generazione diversa, a cui è stata fatta ascoltare roba ancora più distorta, metallica, sporca, ecc.
A mettermi a disagio è Ringo, quando alla fine del secondo finale esclama: "ho le vesciche sulle dita". Se fino a quel momento poteva sembrare tutto un gioco ora è chiaro che qualcuno ha smesso di divertirsi da un pezzo. Quel che è peggio è che Paul non dà impressione di curarsene, lasciando lo sfogo di Ringo nel mix finale. Ancora Pollack confessa che Paul almeno in questo caso gli ricorda un suo compagno di liceo che amava imitare e impersonare personaggi veri o inventati. "Era quasi troppo bravo a fare questo genere di cose: spesso molto divertente, ma a volte un po' fastidioso e irritante. Qualche volta in effetti se ne arrivava nei panni di qualcuno o qualcosa che era semplicemente troppo strano o di cattivo gusto, e per un momento temevi che fosse impazzito e che non sarebbe più stato capace di uscirne. Anche voi siete andati a scuola con lo stesso compagno?"
37. Across the Universe (pubblicata per la prima volta nel 1969 in Our World, disco di Autori Vari per la WWF; poi in Let It Be, 1970).
Le parole stanno volando via come pioggia senza fine dentro una tazza di carta. Quando ti senti triste, pensa come poteva sentirsi Lennon. Tu almeno puoi ascoltare le canzoni dei Beatles, lui le detestava. In parte era una posa: ma solo in parte. Come molti della sua generazione, Lennon aveva un rapporto molto difficile con la sua voce registrata (così come con la sua immagine filmata). Lo imbarazzavano. A quel tempo si poteva arrivare fino a vent'anni senza riascoltarsi in cuffia e scoprire che la propria voce agli altri non suona come la senti tu, ovvero che le tue orecchie ti hanno mentito per tutto il tempo: uno choc. Il trasformismo di John, sia fisico che vocale, non ha nulla della giocosità con cui Paul cambiava costumi e pose: è l'inquietudine di una persona che non si trova a suo agio nell'unico corpo che ha. Per otto anni John le prova tutte: contorce la voce, la raddoppia, la schiarisce, la inverte, scopre un timbro femminile, lo alterna con uno più virile (durante una sessione di Let It Be lo dice esplicitamente: "questa è la mia voce da donna, questa è la mia voce da uomo"). Contemporaneamente gli capita di ingrassare e dimagrire, respingere gli occhiali e poi inforcarli: baffi, capelli, barba, un buon lennonologo è in grado di scoprire il mese in cui è scattata una foto semplicemente dall'acconciatura.
Per ogni canzone che noi possiamo scegliere di abbinare a ricordi felici, Lennon poteva ricordarne di frustranti. Paul che voleva aggiungere qualcosa o togliere qualcos'altro, George Martin che gli chiedeva di accelerarla, Harrison che pretendeva spazio, e soprattutto le bizze del suo nemico n.1, John Lennon: musicista volenteroso ma sempre un passo indietro rispetto alla musica che aveva in testa. Ogni canzone una battaglia: quasi sempre vinta, ma a che prezzo. Nelle interviste dopo lo scioglimento Lennon in sostanza ripartiva le sue canzoni del periodo beatle in due grandi insiemi: quelle che gli facevano schifo ("piece of garbage", "junk", "throwaway"), e quelle che lo facevano incazzare perché sarebbero state buone canzoni, ma per un motivo o per un altro non era mai riuscito a registrarle bene.
Across the Universe fa parte di questo secondo insieme: per John era il migliore testo che avesse scritto, o meglio gli si era scritto in testa da solo. Una sera Cynthia lo aveva svegliato per discutere di un qualche argomento, poi si era addormentata mentre lui continuava a sentire le sue parole "come un flusso senza fine. Andai al piano di sotto e si trasformò in una specie di canzone cosmica, invece che in una canzone arrabbiata [...] Una metrica così straordinaria, non potrei mai ripeterla! Non è una questione di abilità tecnica: si è scritta da sola. Mi ha fatto alzare dal letto". Il dio notturno che aveva regalato a Paul Yesterday, per John teneva in serbo un brano che non sarebbe riuscito a mettere in musica. "È come essere posseduti, come un medium. La cosa deve saltare fuori. Non ti lascerà dormire, così devi svegliarti, trasformarla in qualcosa, e a quel punto avrai il permesso di dormire. Succede sempre nel nel mezzo della notte del cazzo, quando sei mezzo addormentato o esausto e i tuoi dispositivi di controllo sono spenti" (1980).
Nonostante ne esistano ormai quattro versioni ufficiali, nessuna è l'Across the Universe che gli suonava in testa quella notte. L'insoddisfazione era tale che alla vigilia della partenza dall'India John si ritirò dalla competizione per il lato A del singolo, così che Across non uscì neanche come lato B di Lady Madonna, (fu sostituito da The Inner Light) e per la prima volta un singolo 'fuori album' dei Beatles uscì senza una composizione lennoniana. Non solo non riteneva il brano all'altezza, ma decise anche di abbandonarlo al suo destino, regalandola al WWF che la inserì in un disco celebrativo – da cui quei rumori di animali che avete presente se l'ascoltavate nella versione sul Disco Blu.
Un estremo tentativo di riprendere in mano il brano avviene durante le sessioni di Get Back: non approda a niente, ma offre a Phil Spector la scusa per inserire il brano nella scaletta del disco postumo che i Beatles gli hanno offerto di confezionare, Let It Be. Spector però non ci prova nemmeno a recuperare i tentativi del 1969: si limita a riprendere la versione mandata al WWF e a spalmarci sopra un po' di glassa spectoriana, cori e archi riverberati per dare all'ascoltatore l'impressione che il brano arrivi dalle stesse sessioni di The Long and Winding Road. Questo spiega la bizzarria di quell'invocazione indu, "Jai Guru Deva Om" ("Grazie e salute, divino Maestro"), che alla vigilia del viaggio in India testimoniava il fresco interesse di Lennon per la meditazione trascendentale mentre nel 1970 sembra un anacronismo, se non una presa in giro (nella cronologia dei Beatles i mesi sembrano anni, e gli anni secoli).
Un'altra caratteristica della versione WWF erano i coretti realizzati da Lennon con una voce accelerata, che scompaiono nella versione scelta da McCartney su Let It Be Naked (dove i violini di Spector sembra di sentirli ancora, o forse se ne avverte la mancanza: l'effetto che fa la nudità, in fondo). Su Anthology nel frattempo ne era uscita una altrettanto nuda ma un po' diversa. Nessuna può essere considerata quella definitiva, nessuna piaceva all'autore. È curioso perché alla fine ciò che cambia da una versione e l'altra è l'arrangiamento, mentre Lennon la canta allo stesso modo, commettendo sempre la stessa infrazione metrica alla fine della seconda strofa, che non finisce con un accordo minore come le altre due (come in quei tappeti persiani in cui una sola cucitura è sbagliata per dimostrare che sono fatti a mano). Il ritornello somiglia in qualche modo a un altro suo brano del 1969, Don't Let Me Down; dei due versi uguali ("Nothing's gonna change my world"), il primo crea tensione, il secondo la risolve, riportando la melodia al punto di partenza. L'ennesimo paradosso: della canzone che ci dice che ogni cambiamento è un'illusione non abbiamo nessuna versione definitiva. Solo tentativi, aggiustamenti, avvicinamenti: cambiamenti, appunto.
36. Lucy in the Sky With Diamonds (Lennon-McCartney, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967).
Waiting to take you away. Prima di convertirsi e venerarla come Santa Lucia, i popoli nordici raccontavano ai loro bambini che nelle lunghissime notti intorno all'equinozio d'inverno il cielo fosse solcato da una demone, una donna malvagia, forse una strega: Lussi, con tutti i suoi seguaci: i lussiferda. I bambini che proprio insistevano a non volersi mettere a letto se la sarebbero vista brutta, giacché Lussi poteva entrare dal camino e portarli via. (Wikipedia dice proprio "take them away"). Lennon ha sempre negato che Lucy in the Sky parlasse di allucinogeni, il che è abbastanza implausibile. A Dick Cavett racconta di essersi ispirato al titolo di un disegno del piccolo Julian (acquistato qualche anno fa da David Gilmour), e di avere scoperto soltanto dai giornali che il titolo contenesse la sigla LSD – a qual punto si sarebbe subito messo a controllare se le sigle delle altre canzoni significassero qualcosa. Ma è lui stesso a raccontarci che in quel periodo assumeva LSD quotidianamente (una volta ne prese per sbaglio durante una session di Sgt. Pepper e rischiò parecchio perché George Martin, vedendolo confuso, pensò che avesse bisogno di un po' d'aria fresca e lo portò sul tetto) (se avete mai visto qualche vecchio film o telefilm con giovani americani in pantaloni a zampa di elefante, lo sapete già: mai portare sul tetto un ragazzo che ha appena assunto dell'LSD. Ci mettono un attimo a spiccare il volo).
The girl with kaleidoscope eyes. Per realizzare un caleidoscopio è sufficiente montare almeno due superfici specchianti all'interno di un cilindro di cartone, meglio se inclinate a formare un angolo di 60°. Accostando l'occhio a un'estremità sarà possibile vedere figure geometriche simmetriche disposte a triangolo equilatero: l'immagine diretta su un lato, le due immagini riflesse sugli altri due lati. Una ragazza dagli occhi caleidoscopici non sarebbe in grado di distinguerci dallo sfondo su cui ci stagliamo. E forse è meglio così: dopotutto noi chi siamo, per stagliarci? Quando poi si avvicinasse a noi, ci vedrebbe scomposti in cento triangoli, il nostro ego trasformato in tappezzeria Op-Art. In un modo analogo secondo Timothy Leary l'LSD conduceva la coscienza personale alla "morte dell'Ego". Leary era convinto di avere letto qualcosa del genere nel Libro Tibetano dei Morti (anche Lennon se ne procurò una copia), ma l'idea proveniva meno indirettamente dalla psicologia junghiana. Era stato Carl G. Jung a formulare l'ipotesi che in ciascuno di noi si annidasse un inconscio collettivo, un'eredità ancestrale che in passato si era espressa in miti e in leggende. Forse Julian aveva sentito parlare a scuola della donna-demone Lussi. Forse John la vede, con occhi di caleidoscopio, pronta a ghermirlo. In quel momento si riscuote: Ringo batte 1-2-3, John canta: "Lucia nel cielo coi diamanti!" È un'invocazione o un grido d'allarme?
Ovviamente c'è chi a Jung non crede: macché inconscio collettivo, tutto quello che puoi trovare sotto il tuo ego non rimanda ad altri che a te. La morte dell'Ego è un'illusione, come uno specchio caleidoscopico che ti mostra diamanti presi da chissà dove, nient'altro che frammenti della tua stessa immagine. Arthur Janov, che ebbe in cura Lennon nel 1970, aveva un'opinione pessima di Leary e dell'LSD ("la cosa più devastante mai esistita per la salute mentale"). Lennon a quel punto aveva già smesso per i fatti suoi (troppi bad trip), ma l'opinione così netta di Janov avrebbe potuto indurlo a respingere ufficialmente ogni riferimento con la canzone. Era un padre di famiglia, dopotutto.
Picture yourself in a boat on a river. Abbiamo già notato come il valzer porti una nota lugubre alle canzoni dei Quattro. L'ultima canzone registrata dai Beatles nel 1970 è un valzer, con un breve inserto r'n'r. La prima canzone in tre quarti di Lennon è anche la prima in cui si parla di morte. Un ritmo ternario compariva anche a sorpresa al termine del bridge di She Said She Said, la prima canzone a descrivere un viaggio di LSD ("Lei disse: so come ci si sente da morti"). È un curioso paradosso che una droga che avrebbe dovuto portare alla scoperta di una nuova dimensione della coscienza ripeschi dall'inconscio di Lennon una melodia in tre quarti che i suoi nonni avrebbero potuto ascoltare alle feste danzanti; nel frattempo dall'altra parte del mondo, a San Francisco, cinque illustratori cominciavano a disegnare i poster del Fillmore West in una specie di Art Nouveau delirante e strafatto che corrisponde visivamente alle suggestioni rétro di cui i Beatles cominciano ad abusare insieme con gli allucinogeni. Come se l'LSD schiudesse alcune botole sospese sulle soffitte del subconscio infantile.
Lucy in the Sky è una canzone che insiste sul ritmo ternario con l'ossessività di un caleidoscopio. Sin dal titolo, tutto compare in gruppi di tre. La metrica stessa del testo non ammetterebbe una cadenza diversa: Lennon compone dattili come se non avesse mai fatto altro nella vita ("Pict/ure/ your // self / in/ a // boat / on / a // ri/ver/ with...). Eppure, malgrado tutto, c'è ancora un ritmo quaternario nascosto da qualche parte, un principio di realtà che impedisce a John di spiccare il volo e perdersi per sempre. Lucy in the Sky malgrado tutto è ancora una canzone, e il buon senso quadrato prescrive che le canzoni vadano avanti a coppie di due versi. Dopo quattro versi infatti la strofa cambia tonalità – dal La al Si bemolle, ed è come se ci trovassimo sulla seconda rampa di una scala escheriana triangolare, un triangolo di Penrose. Persino i gradini di questa rampa compaiono in gruppi di tre (Si bemolle, Do e Fa: la progressione del ritornello Strawberry Fields). "Cellophane flowers of yellow and green / towering over your head". Ma proprio quando pensavamo di avere capito, il caleidoscopio ci tradisce, il senso quadrato della realtà comincia a perturbare l'ordine triangolare del sogno: su "your head" siamo tornati al Si bemolle di partenza: quando il verso successivo comincia ("Look for the girl") siamo già al Do: la simmetria sta per spezzarsi, nel caleidoscopio compare all'improvviso un accordo nuovo, un Sol. La tonalità sta già cambiando, siamo pronti per la terza rampa, sennonché tutto si ferma all'improvviso. Il terzo lato del caleidoscopio è quello senza specchi. Ringo batte 1-2-3 e la canzone riparte... in quattro quarti. Come osserva questo youtuber (che è bravissimo), Ringo sembra accelerare il battito, ma in realtà azzecca senza metronomo un rapporto quasi esatto tra il ritmo ternario della seconda rampa e quello quaternario della terza – proprio come se quel 4/4 esistesse già, sepolto sotto gli strumenti e le immagini lisergiche, e a Ringo spettasse soltanto riportarlo alla luce. Gli accordi ora sono Sol, Do e Re, nella più classica delle disposizioni: I-IV-V. Ovvero (ci avevate fatto caso?) il ritornello di Lucy in the Sky è Twist and Shout. O se preferite: Lucy in the Sky è quel che succede a Twist and Shout se la infili in un caleidoscopio. Non hai fatto in tempo ad accorgertene, che alla terza invocazione ricompare il La iniziale, e siamo di nuovo sulla prima rampa. Il ciclo si ripeterà, indovinate, altre due volte (la terza, per evitare la noia, si salta la rampa intermedia).
Climb in the back with your hands in the clouds and you're gone. Oltre a Twist and Shout – la cui cadenza ritorna ovviamente tre volte nella canzone, Lucy ricorda un altro brano di metà anni Sessanta che aveva incastonato la stessa progressione I-IV-V nel ritornello: Like a Rolling Stone (potete benissimo cantare i ritornelli uno sull'altro, se non c'è nessuno in casa a sentirvi: "Lucy" parte nel momento in cui Bob canta "Stone"). Lucy è un valzer: anche Rolling Stone all'inizio era un 3/4, almeno nella testa di Dylan. Nella traiettoria lisergica di Lennon, Lucy è il punto più alto: quello in cui rischia seriamente di perdersi in volo. Non è così chiaro se Lucy sia l'emissaria di una divinità che vorrebbe portarselo via o una donna che lo salva riportandolo a terra: sia come sia, nel momento in cui la realtà bussa alla porta, è fantastico che bussi con le bacchette di Ringo e che faccia partire un rock'n'roll.
35. For No One (Lennon-McCartney, Revolver, 1966)
You want her, you need her, and yet you don't believe her. Dei tre verbi che di solito arrivano assieme (want, need, love) manca il più importante, al suo posto c'è il più amaro. Tra i titoli possibili per il disco del 1966, una volta scoperto che Abracadabra era già stato preso, accanto a Four Sides to the Circle, After Geography e Rock'n'Roll Hits of 1966, Bob Spitz include anche Pendulum. Non c'è dubbio che Revolver suoni meglio, e che la rotazione sia una metafora più dinamica e coinvolgente rispetto all'oscillazione. E tuttavia c'è qualcosa di manifestamente pendolare in Revolver, un movimento abbastanza meccanico tra due identità sempre più definite e in contrasto fra loro: Lennon e McCartney ormai sono due polarità. Oppure in certi casi è lo stesso McCartney a oscillare tra due opposti: allo spettro della solitudine di Eleanor Rigby fa specchio l'utopia infantile di Yellow Submarine. Quanto a For No One, è difficile non immaginarla come la risposta gelida al sentimentalismo di Here, There and Everywhere. L'arrangiamento barocco è meno vistoso di quello di Eleanor e ha una funzione opposta: invece di accrescere il pathos, mantiene una sensazione di estraniamento. Lo senti già dal ritmo della strofa, una specie di valzer quadrato (un colpo in battere e tre in levare) spigoloso e artefatto – l'opposto di quel senso di liquida intimità che i cori conferivano alla strofa di Here, There. Quest'ultima cominciava con un languido verso introduttivo: For No One parte immediatamente col cantato, come se Paul non avesse tempo da perdere e in effetti uno dei suoi argomenti è che le relazioni fallite sono una gran perdita di tempo.
For No One è la più classica delle canzoni di disamore di McCartney, a questo punto ormai diventate un sottogenere codificato. È la più amara: la prima in cui la partner assume la terza persona, segno che ormai la separazione si è consumata. È anche l'ultima: fa un certo effetto pensare che Paul e Jane Asher avrebbero continuato a vedersi per altri due anni. Per trovare di nuovo un'amarezza del genere in un brano di Paul bisognerà attendere Abbey Road, e a quel punto non sarà la fine di una coppia, ma la fine del gruppo. Come ogni altra canzone di disamore, è disarmante: quando al colmo dell'amarezza Paul canta "A love that should have lasted years!" non puoi fare a meno di pensare che di solito nelle canzoni l'amore è eterno, anche solo per convenzione. Non per Paul: Paul aveva previsto un tot di anni insieme a questa persona e adesso è un problema, bisognerà trovare un rimpiazzo, una supplente, allestire dei provini in corsa, che fatica.
C'è un assolo smagliante di corno inglese accelerato (George Martin e Paul McCartney stavano inventando in laboratorio strumenti che non esistevano) che ti lascia lucido e impassibile. Ci sono versi di una freddezza definitiva, costruiti con un lessico di base ma con l'abilità necessaria per metterti nella posizione di disagio in cui si trova l'io narrante: "tu stai a casa, lei esce, dice che tanto tempo fa conosceva qualcuno ma adesso se n'è andato, non ha più bisogno di lui". Non riesci nemmeno a capire se sta parlando di te, non è il caso di chiedere, l'unica cosa è far finta di niente e ci provi, stai osservando più te stesso che lei, è quel tipo di emozione che sperimenti quando stai pilotando una relazione verso la fine riducendo i danni. Non proprio l'emozione che vorresti provare ascoltando un disco pop o rock, ma è un'emozione pure questa e Paul l'ha messa in una breve canzone per il grande pubblico. È stato probabilmente il primo della sua generazione a riuscirci (in America c'era Dylan che però poteva girare intorno al concetto per otto strofe). Tutt'intorno c'erano ancora innamorati o semplici ingrifati che ululavano alla luna. Lei piange, ma per chi? Come aveva già scoperto John in I'm a Loser, siamo tutti soli quando piangiamo. Le lacrime servono solo a noi stessi: o a nessuno.
34. Dear Prudence (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968).
"...Nessuno poteva sapere che presto o tardi sarebbe andata completamente fuori di testa sotto la cura di Maharishi Mahesh Yogi. Tutta la gente intorno era molto preoccupata per la ragazza, perché stava diventando matta, così noi le abbiamo cantato..." (recitativo di Lennon, dal demo di Dear Prudence registrato ad Esher).
La prima cosa che sentiamo emergere dal frastuono aeroportuale di Back in the USSR è un arpeggio di chitarra acustica. Non è il primo, ma suona come se lo fosse. I Beatles hanno scoperto il fingerpicking: per impararlo hanno dovuto davvero prendere l'aereo e viaggiare nell'altro capo del mondo, anche se alla fine il loro maestro era un chitarrista di Glasgow, Donovan Phillips Leitch. È uno degli aspetti che dividono il Disco Bianco dai precedenti: a partire dal 1966 e fino a tutto il Magical Mystery Tour, i tre compositori dei Beatles avevano preferito cercare nuove melodie su strumenti a tastiera. Il soggiorno in India cambia tutto: i Beatles passano più tempo all'aria aperta e si ritrovano più facilmente una chitarra tra le mani. C'è un bel sole, il cielo è azzurro, solo la sorellina di Mia Farrow non vuole uscire a giocare. Che in inglese si dice "play", e indica anche i giochi che si fanno con gli strumenti: la musica, insomma. "Scelsero me e George per cercare di tirarla fuori perché di noi si sarebbe fidata. Se fosse stata in Occidente, l'avrebbero ricoverata... Era rimasta rinchiusa per tre settimane, cercando di arrivare a Dio più rapidamente di chiunque altro. Questa era la competizione al campo di Maharishi: chi sarebbe diventato cosmico per primo".
I due ingredienti di molte canzoni del Bianco sono tipicamente chitarristici: riff insistiti e arpeggi. In Dear Prudence, oltre all'arpeggio così tipicamente lennoniano, verso la coda si aggiunge anche un riff a mò di contrappunto in classico stile George Harrison. Salvo che né Lennon né Harrison avevano mai suonato le chitarre così: è un nuovo inizio per entrambi. In sostanza la miscela di suoni hard rock e folk che costituirà la formula del rock milionario della prima metà degli anni Settanta era già a disposizione dei Beatles dalla primavera del 1968. Nel giro di due brani, il Disco Bianco è già oscillato da Chuck Berry ai Led Zeppelin.
Dear Prudence è una canzone che ha mantenuto una sua 'credibilità rock' per molto più tempo di altre composizioni di Lennon-McCartney: tornerà in classifica addirittura nel 1983 nella versione postpunk ma non troppo infedele di Siouxsie and the Banshees (con Robert Smith alla chitarra). Nel frattempo il fingerpicking era diventato un fenomeno di massa. Le nozioni che Donovan generosamente aveva condiviso con John venivano scambiate da milioni di chitarristi da falò ai loro discepoli ansiosi di far bella figura con ragazze. Tutte queste cose però Lennon non poteva ancora saperle, quando escogitava un arpeggio per snidare Prudence Farrow dal suo bungalow. Il canovaccio che milioni di ragazzi avrebbero recitato sulle spiagge del mondo libero per almeno vent'anni, comincia nel resort del Maharishi. Lennon si trova a essere un pioniere anche stavolta, e anche stavolta ci regala qualcosa di meno banale di tante cose venute dopo. Il suo arpeggio è una ruota di note gentili, delicate, ma anche insistenti, ossessive. Cara Prudence, bisogna proprio che vieni fuori. Gli accordi scorrono con grazia, ma il mi cantino continua a suonare quella nota assillante che dà tregua né a chi ascolta né a chi suona. C'è un limite oltre il quale l'insistenza diventa stalking, e non è escluso che Lennon in Dear Prudence lo oltrepassi. D'altro canto, perché dobbiamo sempre fissarci sul lato negativo? Il sole è alto, il cielo e blu, Dear Prudence è una bella canzone e John Lennon quel pomeriggio un tipo simpatico che si preoccupava per una ragazza che meditava troppo.
33. Please Please Me (Lennon-McCartney, lato A del primo singolo del 1963; poi nell'album omonimo).
Last night I said these words. E se decidessimo che è tutto cominciato con i Beatles? Come il Big Bang. Potremmo stabilire che tutta la cultura pop prima di loro non esistesse, e un attimo dopo fosse completamente compresa in loro, già in fase di espansione. Il rock, il pop, le boyband, la psichedelia, la musica elettronica... tutto ciò che ora popola galassie lontane, già in embrione nei Beatles. In questo caso Please Please Me sarebbe una delle prime rapidissime ere dell'universo, magari l'era della nucleosintesi (in cui la maggior parte dei neutroni decadde in protoni). Durò più o meno 100 secondi; Please Please Me non molti di più. Ma in quei secondi possiamo ingegnarci a trovare le tracce di qualsiasi cosa. C'è il rock, ovviamente ("Come on! Come on!), c'è la sfida al pentagramma di Paul che cantando tiene la stessa nota anche quando John è appena un semitono più sotto; c'è un riff di armonica ma anche due rapidi riff di chitarra a metà strofa, i giochi di parole ammiccanti (quei due "please" che suonano uguali e dicono l'esatto opposto: "ti prego, soddisfami"), un certo tasso di possessività maschile ancora confusa con un sentimentalismo sfacciato e persino qualche timida incursione nel surreale ("c'è sempre pioggia nel mio cuore"). Ci sono i ritornelli e c'è un bridge, c'è un finale con Ringo in gran spolvero perché deve dimostrare che merita di suonare in studio con gli altri tre. Potremmo decidere che è tutto cominciato così, con l'armonica di John Lennon che separa la luce dalle tenebre. Ma dobbiamo proprio?
È come se avessimo bisogno di leggende ed eroi, ci spiegava Stephen Jay Gould in Bravo Brontosauro. Ogni volta che ci viene proposto di scegliere tra un mito della creazione e una teoria dell'evoluzione, il primo ci sembra più praticabile. Gould faceva l'esempio del baseball: se gli americani avessero accettato che era nato dall'evoluzione continua di altri giochi con la mazza e con la palla provenienti dalle isole britanniche, non avrebbero avuto eroi da onorare e musei da visitare. Niente simboli, niente storie epiche: una storia che ti priva di queste cose, è ancora una storia che vale la pena raccontare?
"Sono nato nel 1963, quello che, per ragioni varie e non solo narcisistiche, considero il Primo Anno del Rock. (Il rock'n'roll anni cinquanta era più grezzo e spettacolare; è nel 1963 – l'anno di Beatles, Dylan e degli Stones – che l'idea del rock come Arte, del rock come Rivoluzione, del rock come Stile di Vita e del rock come Forma Consapevolmente Innovativa cominciò davvero a esistere)". In questo brano di Retromania (2011) Simon Reynolds afferma la sua fede in un mito della creazione: non è che non si suonasse qualcosa di simile al rock anche prima del 1963, ma... in un qualche modo non conta; l'Arte, la Rivoluzione, lo Stile di Vita, la Consapevolezza cominciano con l'armonica di Lennon. Eppure.
Eppure basta avvicinarci al supposto Big Bang per scoprire che tante cose esistevano già. Persino quell'armonica, sappiamo che Lennon l'aveva ripresa in mano perché ne aveva sentita una nel brano che aveva appena scalato le classifiche inglesi. La stessa Please Please Me, che all'inizio era più lenta e confidenziale, per sua ammissione era un tentativo di imitare, "tra tutti, proprio Roy Orbison". E se il risultato finale dopo l'accelerazione impressa da George Martin, non assomiglia a nessuna canzone di Orbison in particolare, sembra però adattarsi alla descrizione che ne dà Dylan nella sua autobiografia: "Orbison andava al di là di tutti i generi, folk, country, rock and roll o qualunque altra cosa. Mescolava tutti gli stili, compresi quelli che non erano ancora stati inventati. In un verso cantava veramente da cattivo, in quello dopo se ne usciva con un falsetto alla Frankie Valli. Con Roy non si sapeva mai se stavi ascoltando del mariachi o un'opera lirica". L'Orbison idealizzato da Dylan è già un autore postmoderno, un'enciclopedia di stili che sfoglia e ricombina a suo piacimento, sempre con l'obiettivo di stupire l'ascoltatore. Please Please Me è un brano che conserva questa imprevedibilità: anche dal cantante non sappiamo cosa aspettarci, è una canzone d'amore o di frustrazione?
"I don't want to sound complaining", mente John, che nel brano si lamenta eccome: ma il prodotto finito è così scoppiettante che anche le sue recriminazioni sembrano uno scherzo. I più smaliziati in effetti leggono in Please Please Me l'auspicio di una più generosa disponibilità della partner al sesso orale ("as I please you"), e se la cosa può sembrare un po' osée per il 1963, bisogna ricordare che anche in questo i Beatles non facevano che rispondere alle sollecitazioni dell'ambiente: se non avessero inciso Please l'alternativa sarebbe stata l'altrettanto ammiccante How Do You Do It di Mitch Murray ("Come fai a fare le cose che mi fai? Se sapessi come fai te le farei"). Dopotutto la Parlophone era famosa per i dischi di varietà. I Beatles non avevano ancora messo a fuoco il loro target: nel giro di pochi mesi, man mano che si chiariva l'età piuttosto bassa e la preponderanza femminile del loro pubblico, i riferimenti al sesso si sarebbero stemperati..
C'è veramente tanta roba in Please Please Me, come se i Beatles ritenessero di avere a disposizione solo un altro singolo per sparare tutte le cartucce che avevano: e forse era così. Ma se Reynolds avesse voluto guardare più da vicino, avrebbe constatato che è tutta roba che esisteva già: i Beatles muovono i primi passi in un mondo già saturo di stili musicali. Quello che dal nostro remoto punto di vista sembra il Big Bang, non era che una collisione di elementi già disponibili in natura. Certo, accettarlo implica una concessione pesante: ammettere che l'universo esisteva, e suonava musica interessante, anche prima che nascessimo noi.
32. Day Tripper (Lennon-McCartney, singolo, dicembre 1965)
Ci ho messo così tanto ad accorgermene. Dando un'occhiata alle classifiche appare abbastanza chiaro che Day Tripper fu un mezzo passo falso, soprattutto negli USA. Dopo tre anni, John Lennon aveva anche il diritto di farne. Eppure in un certo senso non se ne riprese più: su Day Tripper aveva scommesso, si era impuntato contro il parere dei colleghi; aveva preteso che non fosse considerato un Lato B, ma una canzone a pari dignità con quella della facciata opposta. Col senno del poi, la posta in gioco era la direzione artistica del quartetto, che dal 1966 passa inesorabilmente al collega che nell'anno precedente aveva associato la sua voce e la sua immagine a Yesterday e Michelle. Paul si assumerà la responsabilità del lato A del singolo successivo (Paperback Writer), di entrambi i lati del seguente (Eleanor Rigby / Yellow Submarine) e di quasi tutti i singoli da lì in poi, pur con eccezioni importanti (Strawberry Fields almeno ottenne pari dignità rispetto a Penny Lane). È interessante notare che il 1965 che termina con passo falso di Day Tripper, era iniziato con un singolo completamente lennoniano: Ticket to Ride / Yes It Is.
Ma anche nei confronti di un brano innovativo come Ticket, questa Day Tripper risultava un po' deludente, al punto che gli stessi autori sentirono abbastanza presto la necessità di giustificarsi: era un brano scritto in fretta per rispettare una scadenza. Il che in realtà si potrebbe dire quasi di tutti i brani dei Beatles – soprattutto dei primi quattro anni – ma non particolarmente di Day Tripper, che cronologicamente appartiene al blocco delle canzoni di Rubber Soul: per dire, tre giorni prima di inciderla avevano già completato Drive My Car; nello stesso giorno finirono If I Needed Someone, due giorni dopo In My Life, quattro giorni dopo la canzone "rivale", We Can Work It Out. Non è che fossero a corto di buone canzoni, insomma. Ma in un qualche modo Lennon pensava che Day Tripper avrebbe funzionato come singolo meglio di tutte le altre: e si sbagliava. Un anno prima aveva scommesso su I Feel Fine e aveva portato a casa la quinta Numero Uno in due anni. Il riff di Day Tripper nasce proprio come un'evoluzione di quello di I Feel Fine: è più incisivo ma ancora piuttosto ingombrante. Per Lennon la direzione era segnata: i Beatles dovevano indurirsi, lasciare perdere i coretti sdolcinati che ancora incrostavano il bridge di I Feel Fine, assumere un atteggiamento più disincantato nei confronti delle relazioni con l'altro sesso.
Day Tripper è una risposta alla sfida dei gruppi che stavano avendo successo con pubblici più maschili: gli Who di My Generation, i Rolling Stones di Satisfaction. Prima ancora che con le parole, Lennon risponde con la chitarra: suonate questo riff se ne siete capaci (il riff dal vivo però lo suonava George). Proprio quando la solita alternanza di Mi, La e ancora Mi ti ha convinto che Day Tripper è il solito blues, e che stavolta insomma i Beatles non si sono sprecati a inventare qualcosa di nuovo, proprio quando stai per aspettarti il solito Si, la progressione tradisce le tue aspettative con un Fa#: per una coincidenza che forse non lo è, è anche il momento in cui John e Paul scoprono che la tizia è un'impostora, una poser, una che che vuole essere a casa in giornata ("She was a day tripper!") Da lì in poi non c'è più nessun sentiero tracciato: per una battuta si torna al La ("It took me so"...), ma solo per scivolare un semitono più sotto ("...long"), dal La bemolle si rimbalza di una quinta al Do# ("to find out"), e a quel punto per una strada completamente nuova ritroviamo il caro vecchio Si: e per una coincidenza che forse non lo è, il testo ripete "And I found out". Un bel viaggio, anche se breve. Ma purtroppo quando fai uscire un singolo la prima impressione è molto importante: e la prima impressione che lasciava Day Tripper veniva impressa dalle prime battute: un riff pentatonico su un blues, niente che gli stessi Beatles non ci avessero già fatto ascoltare con I Feel Fine, appunto. Quanto al bridge, tutto su un accordo solo con le voci armonizzate che salgono di tono e di volume, sembra quasi ritagliato da Twist and Shout, uno dei primi esempi di autocitazione.
Per quanto riguarda le parole, si fa fatica a non interpretare Day Tripper come un'evoluzione cinica di Ticket to Ride: la presa di distanza da una ragazza che simulava una disponibilità che non aveva intenzione di concedere davvero. Per l'ennesimo buffo paradosso, questa canzone che evidentemente parla di sesso e di quanto sia frustrante a volte cercarlo, è una delle poche che sia per John sia per Paul parlerebbe invece di stupefacenti. Lucy no, Cold Turkey neanche, ma questa sì. Dovremmo dunque credere che "tripper" alluda già alle prime esperienze di LSD; che i Beatles a fine 1965 avessero spalancato le porte della coscienza al punto da dedicare mezzo singolo di Natale a irridere i "viaggiatori della domenica", quei poveri mortali che facevano della droga ancora un banale uso ricreativo. Uno sfoggio di snobismo mai svelato fino a quel momento, e nemmeno in seguito. Dovremmo credere a tutto questo quando sappiamo benissimo che durante le prove Paul e John cantavano "she's a prick teaser". Ma forse negli anni successivi ammettere di avere fatto uso di droghe era più socialmente accettabile di essersi comportati da stronzi con una o più groupie. Forse uno dei motivi per cui Day Tripper non aveva funzionato era proprio questo tipo di stronzaggine, perfetta nella bocca larga di un Mick Jagger, ma che non si adattava né all'immagine pulitina dei Beatles pre-Day Tripper né a quella peace and love che si sarebbe messa a fuoco nei mesi successivi. I Beatles potevano assumere tante forme, ma non potevano fare gli stronzi. Lennon ogni tanto ci provava, ma pensare di poterlo fare sul singolo di Natale fu imperdonabile.
31. She Said She Said (Lennon-McCartney, Revolver, 1966).
"Peter Fonda continuava a sedermi di fianco e a mormorare: "so come ci si sente a essere morti". Gli dicevamo "Per l'amore del cielo, taci, non ci interessa! Non vogliamo saperlo!"
She said: you don't understand what I said. I said no no no, you're wrong. Ecco, questa è la prima volta che m'incazzo io. Cosa ci fa fuori dalle prime trenta un brano da podio? Delle due tracce di Revolver che suonavano ancora attuali ancora negli anni '90, She Said She Said è apparentemente meno innovativa di Tomorrow Never Knows. Eppure quando penso a tutti i tentativi di stravolgere la forma "canzone rock" nell'ultimo mezzo secolo, continua a non venirmi in mente niente di più estremo del passaggio a 3/4 di She Said She Said. Una soluzione che in altri casi viene dispensata con compiacimento e qui invece è tanto inattesa quanto necessaria – come rompere la tela di un quadro, e poi riaggiustarla appiccicandoci il disegno di un bambino ("when I was a boy...")
Lennon mi stava fissando e disse: "Sai cosa significa essere morti? Chi è che ti ha messo tutta quella merda in testa? Lo sai, mi stai facendo sentire come se non fossi mai nato".
In She Said She Said manca Paul McCartney – un fatto rarissimo in tutta la discografia beatle: succede soltanto in qualche altro brano fortemente idiosincratico, come Julia o Revolution 9. Lo stesso Paul ha ricordi confusi, ma potrebbe essere l'unica volta che se n'è andato dopo una discussione. Il sospetto che non riuscisse a mandar giù quel bridge in 3/4 è irresistibile. Magari era convinto che avrebbe rovinato la canzone e oggettivamente non avrebbe tutti i torti – ma cosa significa "oggettivamente". Paul era anche l'unico dei quattro a non avere assunto LSD durante la festa nella residenza californiana di Zsa Zsa Gabor, il 24 agosto 1965. Per Ringo fu la prima volta: per John e George la seconda dopo un primo test involontario in primavera, quando un dentista gliene aveva somministrato senza avvertirli.
Forse è solo una coincidenza: fatto sta che gli altri tre ci danno dentro come se non ci fosse un domani (Ringo è nella modalità Rain) e il risultato è un rock trasudante un'angoscia esistenziale che diventerà moneta corrente solo due generazioni più tardi. Nessun altro gruppo nel 1966 sarebbe riuscito a suonare o anche solo a concepire She Said She Said: ci voleva una fantasia e un coraggio che solo i Beatles potevano permettersi. Come molte canzoni di Revolver, She Said parla di droga, ma senza condividere i toni euforici di Got to Get You né quelli estatici di Tomorrow Never Knows: qui si comincia a intuire che la droga è un altro punto di vista sul disagio di vivere. She Said è la prima canzone sugli acidi ed è anche la canzone che ti avverte che gli acidi sono un casino, meglio evitarli se hai cattivi pensieri, e chi non ne ha? No no no chi vi ha messo tutte queste sciocchezze nel cervello, sarebbe meglio non essere mai nati.
Spero che stiate bene, io sto solo dormendo, che abbiamo in lista questa settimana? La canzone che qualcuno pensava parlasse di sparare alla gente e invece parlava di una giostra; quella che tutti pensavano che parlasse di droga e invece parlava di sparare alla gente; quella che sembrava parlasse di sesso e invece parlava di droga, e qualche altra ancora. Ricordo che la classifica non la faccio io: è una media di tutte le classifiche messe on line da critici specializzati. Certo che Happiness Is A Warm Gun andava messa più avanti. Sono d'accordissimo. Non sparate. Non su di me, almeno.
40. I'm Only Sleeping (Lennon-McCartney, Revolver, 1966).
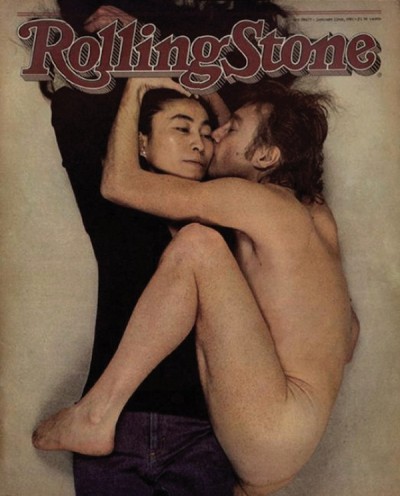 |
| La foto è di Annie Leibovitz. La scattò proprio l'8 dicembre del 1980. |
I'm Only Sleeping è il seguito di Nowhere Man, per come riprende l'attitudine diaristica di dedicare almeno una canzone dell'album al proprio stato d'animo dominante. Come si sentiva John Lennon nella primavera del 1966, all'apice della Swinging London? Ancora parecchio sonnacchioso. Poca voglia di uscire, scarsa disponibilità a recitare la parte dell'uomo di casa. Il brano che porta in studio sotto forma di demo è un lontano parente di Girl: attinge allo stesso serbatoio inconscio di melodie rétro, vecchie ballate in minore e frasi jazz ascoltate alla radio chissà quando . Il blend è già inconfondibilmente lennoniano: vedi il bridge ("keeping an eye on the world going by my window"), tagliato così corto ("taking my time") che non fai in tempo a notarlo ed è già ripartita la strofa ("When I wake up early in the morning"), quasi il ripensamento di un dormiglione che stava per alzarsi, e soprattutto quel magico accordo in maggiore settima, parente non lontano di quello che attutiva l'angoscia in No Reply: qui è soffice come il guanciale su cui casca il ritornello, quando Lennon canta "sleeping".
In studio John raffina il timbro della voce, incisiva ma fragile, e la correda di quei coretti vagamente swing che sembrano davvero usciti da una pigra radiosveglia mattutina. Nel bridge invece interviene Paul con un contrappunto più virile, come se tentasse di scrollare John e svegliarlo; ma niente da fare. Siccome George è occupato a sperimentare con la chitarra invertita, i fraseggi di connessione tra il ritornello e la strofa vengono delegati al basso di Paul e raggiungono il nostro orecchio attutiti, compressi, come i colpetti amorevoli di qualcuno che cercasse di svegliarci. Ma il punctum del brano ovviamente è la chitarra rovesciata di George.
I Quattro avevano iniziato a rovesciare i nastri con Rain; l'esperimento prosegue con I'm Only Sleeping ed è una trovata geniale non solo perché le sonorità rovesciate si adattano all'andamento languido e jazzeggiante. In I'm Only Sleeping quello che fino a quel momento era ancora un trucco di laboratorio diventa il correlato sonoro di un fenomeno tanto vicino all'esperienza di tutti quanto misterioso: il sonno, per la prima volta immaginato come il lato B della veglia. Suonare un assolo a rovescio è come mandare un messaggio a sé stessi in sogno: George compone l'assolo, ne incide una prova, lo rovescia per sentire come deve suonarlo, lo incide a rovescio e poi lo rivolta di nuovo. Se potessimo ricevere messaggi dal piccolo aldilà dei sogni, probabilmente avrebbero la consistenza sfuocata eppure familiare dei fraseggi di chitarra rovesciati di George. E non è una coincidenza che la chitarra invertita torni alla fine del pezzo: dopo averci pensato un po' su, John si è riaddormentato.
39. Happiness Is a Warm Gun (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968)
 |
| "American Rifleman", maggio 1968. |
 |
| Just what is it that makes today's homes so different, so appealing? (Richard Hamilton, 1956). |
Il finale doo-wop in cui in un qualche modo Ringo riesce a tenere il 4/4 mentre tutto il resto frana in terzine, è un'esplicita "satira del R'n'R anni 50", lo stesso Lennon lo definiva così, ed è un esempio felice di come certe idee possano incubarci dentro per anni: uno dei più antichi documenti sonori che ci sono rimasti di John e Paul è proprio una registrazione domestica di un pezzo doo-wop parodistico. Nel 1960 Paul stava già mimando i coretti alti mentre John improvvisava fesserie al microfono con un vocione impostato. Una simile 'strofa parlata' compariva nel demo di I'm So Tired, finché Lennon non ha l'idea risolutiva di staccarla e rimontarla alla fine di Happiness... Il risultato è un collage d'immagini sospese tra iper-realismo, mistero e parodia, che ricorda irresistibilmente la pop art e in particolare i collage di Richard Hamilton che dieci anni fa lo avevano anticipato. È lo stesso Hamilton che Paul aveva appena presentato ai colleghi e che avrebbe 'disegnato' la copertina del Disco Bianco.
Si dice spesso che i Quattro durante la lavorazione del Bianco non riuscissero più a suonare assieme. Eppure la canzone in assoluto più provata in studio da tutti e quattro è Happiness Is a Warm Gun, più di settanta take. È un pezzo che solo John Lennon avrebbe potuto proporre agli altri tre, ed è un pezzo che solo gli altri tre non avrebbero respinto al mittente, ma che roba è, ci prendi in giro? Una decina di cambi di tempo? Paul McCartney non ha mai smesso di dire che Happiness è una delle sue preferite. Per Ringo (a cui il brano chiedeva un vero tour de force) fu una specie di nuovo inizio. Quanto a George, basta sentire quel che combina durante il pezzo: la credibilità blues che riesce a offrire con la sua chitarra in I need a fix, nel bel mezzo di un brano che sembrerebbe mandare tutto in burla. Happiness segue in scaletta a While My Guitar Gently Weeps. Quando chiedevano a George il suo brano preferito, rispondeva Happiness. Senza Happiness probabilmente nessuno avrebbe proposto il successivo progetto Get Back, l'idea di abolire le sovraincisioni e rimettersi a suonare in presa diretta. Una missione troppo impegnativa, col senno del poi. D'altro canto, erano appena riusciti a incidere Happiness: che altra sfida potevano darsi?
 |
| Una riproduzione dell'opera più famosa di Richard Hamilton (ma non rende l'idea, dovete vederla dal vero). |
Musicalmente è il passo avanti più importante del Disco Bianco: non è la prima canzone a nascere come un patchwork di brani musicali distinti (anche in questo è A Day In the Life l'antecedente illustre), ma in Happiness per la prima volta viene a mancare l'elemento ricorrente che dia al patchwork una sensazione di unità. Happiness è un medley di tre-quattro brevi canzoni che non hanno altro collegamento fuori che la libera associazione di immagini che ruotano nella testa di John. Il procedimento sarà ripreso poi nel secondo lato di Abbey Road e diventerà un topos ricorrente nella carriera post-Beatles non di Lennon, ma di McCartney (Uncle Robert / Admiral Halsey, Band on the Run). Happiness resta un esempio folgorante di cosa potevano fare i Quattro ancora nel 1968 quando erano disposti a seguire John alla ricerca del metodo nella sua follia. Rimane uno dei loro brani più interessanti e memorabili: e lo sarebbe anche se qualcuno non avesse tirato fuori una pistola non metaforica, davanti in Central Park West, dodici anni dopo.
38. Helter Skelter (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968)
 |
| Sharon Tate e Roman Polanski nel 1969. |
Per quanto possano avervi detto il contrario, la prima impressione è fondamentale, e questo separa gli ascoltatori di Helter Skelter in tre insiemi che praticamente ascoltano tre canzoni diverse. Vediamoli a ritroso, dal terzo insieme al primo.
3. Nel primo insieme ci sono quelli che l'hanno ascoltata dopo aver sentito parlare della strage a casa Polanski: Helter Skelter era per Charles Manson il nome in codice della guerra tra le razze che sarebbe scoppiata di lì a poco negli USA, e ai suoi adepti era stato dato il compito di fomentarla uccidendo giovani ricchi bianchi e famosi (Manson conosceva la casa perché per un po' era appartenuta a Terry Melcher, il produttore discografico che aveva stroncato senza appello i suoi demo e le sue velleità di aspirante rockstar). Questo insieme di persone non credo possa ascoltare Helter Skelter senza pensare a tutta la storia, che è oggettivamente pazzesca. Per loro Helter Skelter non può che essere la colonna sonora di quella storia, un segno rosso indelebile che pregiudica credo irrimediabilmente l'ascolto del Disco Bianco.
 |
| Patricia Krenwinkel, Susan Atkins e Leslie Van Houten della "famiglia" di Charles Manson prima di un'udienza per il processo sull'omicidio Tate, nel 1971 a Los Angeles |
 |
| "The dirtiest, loudiest, filthiest ever". (Chi?) |
 |
| Charles Manson, 3 dicembre 1969 |
A mettermi a disagio è Ringo, quando alla fine del secondo finale esclama: "ho le vesciche sulle dita". Se fino a quel momento poteva sembrare tutto un gioco ora è chiaro che qualcuno ha smesso di divertirsi da un pezzo. Quel che è peggio è che Paul non dà impressione di curarsene, lasciando lo sfogo di Ringo nel mix finale. Ancora Pollack confessa che Paul almeno in questo caso gli ricorda un suo compagno di liceo che amava imitare e impersonare personaggi veri o inventati. "Era quasi troppo bravo a fare questo genere di cose: spesso molto divertente, ma a volte un po' fastidioso e irritante. Qualche volta in effetti se ne arrivava nei panni di qualcuno o qualcosa che era semplicemente troppo strano o di cattivo gusto, e per un momento temevi che fosse impazzito e che non sarebbe più stato capace di uscirne. Anche voi siete andati a scuola con lo stesso compagno?"
37. Across the Universe (pubblicata per la prima volta nel 1969 in Our World, disco di Autori Vari per la WWF; poi in Let It Be, 1970).
 |
| (No One's Gonna Change) Our World, l'album pubblicato dal WWF nel 1969. |
Per ogni canzone che noi possiamo scegliere di abbinare a ricordi felici, Lennon poteva ricordarne di frustranti. Paul che voleva aggiungere qualcosa o togliere qualcos'altro, George Martin che gli chiedeva di accelerarla, Harrison che pretendeva spazio, e soprattutto le bizze del suo nemico n.1, John Lennon: musicista volenteroso ma sempre un passo indietro rispetto alla musica che aveva in testa. Ogni canzone una battaglia: quasi sempre vinta, ma a che prezzo. Nelle interviste dopo lo scioglimento Lennon in sostanza ripartiva le sue canzoni del periodo beatle in due grandi insiemi: quelle che gli facevano schifo ("piece of garbage", "junk", "throwaway"), e quelle che lo facevano incazzare perché sarebbero state buone canzoni, ma per un motivo o per un altro non era mai riuscito a registrarle bene.
Across the Universe fa parte di questo secondo insieme: per John era il migliore testo che avesse scritto, o meglio gli si era scritto in testa da solo. Una sera Cynthia lo aveva svegliato per discutere di un qualche argomento, poi si era addormentata mentre lui continuava a sentire le sue parole "come un flusso senza fine. Andai al piano di sotto e si trasformò in una specie di canzone cosmica, invece che in una canzone arrabbiata [...] Una metrica così straordinaria, non potrei mai ripeterla! Non è una questione di abilità tecnica: si è scritta da sola. Mi ha fatto alzare dal letto". Il dio notturno che aveva regalato a Paul Yesterday, per John teneva in serbo un brano che non sarebbe riuscito a mettere in musica. "È come essere posseduti, come un medium. La cosa deve saltare fuori. Non ti lascerà dormire, così devi svegliarti, trasformarla in qualcosa, e a quel punto avrai il permesso di dormire. Succede sempre nel nel mezzo della notte del cazzo, quando sei mezzo addormentato o esausto e i tuoi dispositivi di controllo sono spenti" (1980).
 |
| Cynthia Powell Lennon |
Un estremo tentativo di riprendere in mano il brano avviene durante le sessioni di Get Back: non approda a niente, ma offre a Phil Spector la scusa per inserire il brano nella scaletta del disco postumo che i Beatles gli hanno offerto di confezionare, Let It Be. Spector però non ci prova nemmeno a recuperare i tentativi del 1969: si limita a riprendere la versione mandata al WWF e a spalmarci sopra un po' di glassa spectoriana, cori e archi riverberati per dare all'ascoltatore l'impressione che il brano arrivi dalle stesse sessioni di The Long and Winding Road. Questo spiega la bizzarria di quell'invocazione indu, "Jai Guru Deva Om" ("Grazie e salute, divino Maestro"), che alla vigilia del viaggio in India testimoniava il fresco interesse di Lennon per la meditazione trascendentale mentre nel 1970 sembra un anacronismo, se non una presa in giro (nella cronologia dei Beatles i mesi sembrano anni, e gli anni secoli).
Un'altra caratteristica della versione WWF erano i coretti realizzati da Lennon con una voce accelerata, che scompaiono nella versione scelta da McCartney su Let It Be Naked (dove i violini di Spector sembra di sentirli ancora, o forse se ne avverte la mancanza: l'effetto che fa la nudità, in fondo). Su Anthology nel frattempo ne era uscita una altrettanto nuda ma un po' diversa. Nessuna può essere considerata quella definitiva, nessuna piaceva all'autore. È curioso perché alla fine ciò che cambia da una versione e l'altra è l'arrangiamento, mentre Lennon la canta allo stesso modo, commettendo sempre la stessa infrazione metrica alla fine della seconda strofa, che non finisce con un accordo minore come le altre due (come in quei tappeti persiani in cui una sola cucitura è sbagliata per dimostrare che sono fatti a mano). Il ritornello somiglia in qualche modo a un altro suo brano del 1969, Don't Let Me Down; dei due versi uguali ("Nothing's gonna change my world"), il primo crea tensione, il secondo la risolve, riportando la melodia al punto di partenza. L'ennesimo paradosso: della canzone che ci dice che ogni cambiamento è un'illusione non abbiamo nessuna versione definitiva. Solo tentativi, aggiustamenti, avvicinamenti: cambiamenti, appunto.
36. Lucy in the Sky With Diamonds (Lennon-McCartney, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967).
Waiting to take you away. Prima di convertirsi e venerarla come Santa Lucia, i popoli nordici raccontavano ai loro bambini che nelle lunghissime notti intorno all'equinozio d'inverno il cielo fosse solcato da una demone, una donna malvagia, forse una strega: Lussi, con tutti i suoi seguaci: i lussiferda. I bambini che proprio insistevano a non volersi mettere a letto se la sarebbero vista brutta, giacché Lussi poteva entrare dal camino e portarli via. (Wikipedia dice proprio "take them away"). Lennon ha sempre negato che Lucy in the Sky parlasse di allucinogeni, il che è abbastanza implausibile. A Dick Cavett racconta di essersi ispirato al titolo di un disegno del piccolo Julian (acquistato qualche anno fa da David Gilmour), e di avere scoperto soltanto dai giornali che il titolo contenesse la sigla LSD – a qual punto si sarebbe subito messo a controllare se le sigle delle altre canzoni significassero qualcosa. Ma è lui stesso a raccontarci che in quel periodo assumeva LSD quotidianamente (una volta ne prese per sbaglio durante una session di Sgt. Pepper e rischiò parecchio perché George Martin, vedendolo confuso, pensò che avesse bisogno di un po' d'aria fresca e lo portò sul tetto) (se avete mai visto qualche vecchio film o telefilm con giovani americani in pantaloni a zampa di elefante, lo sapete già: mai portare sul tetto un ragazzo che ha appena assunto dell'LSD. Ci mettono un attimo a spiccare il volo).
The girl with kaleidoscope eyes. Per realizzare un caleidoscopio è sufficiente montare almeno due superfici specchianti all'interno di un cilindro di cartone, meglio se inclinate a formare un angolo di 60°. Accostando l'occhio a un'estremità sarà possibile vedere figure geometriche simmetriche disposte a triangolo equilatero: l'immagine diretta su un lato, le due immagini riflesse sugli altri due lati. Una ragazza dagli occhi caleidoscopici non sarebbe in grado di distinguerci dallo sfondo su cui ci stagliamo. E forse è meglio così: dopotutto noi chi siamo, per stagliarci? Quando poi si avvicinasse a noi, ci vedrebbe scomposti in cento triangoli, il nostro ego trasformato in tappezzeria Op-Art. In un modo analogo secondo Timothy Leary l'LSD conduceva la coscienza personale alla "morte dell'Ego". Leary era convinto di avere letto qualcosa del genere nel Libro Tibetano dei Morti (anche Lennon se ne procurò una copia), ma l'idea proveniva meno indirettamente dalla psicologia junghiana. Era stato Carl G. Jung a formulare l'ipotesi che in ciascuno di noi si annidasse un inconscio collettivo, un'eredità ancestrale che in passato si era espressa in miti e in leggende. Forse Julian aveva sentito parlare a scuola della donna-demone Lussi. Forse John la vede, con occhi di caleidoscopio, pronta a ghermirlo. In quel momento si riscuote: Ringo batte 1-2-3, John canta: "Lucia nel cielo coi diamanti!" È un'invocazione o un grido d'allarme?
Ovviamente c'è chi a Jung non crede: macché inconscio collettivo, tutto quello che puoi trovare sotto il tuo ego non rimanda ad altri che a te. La morte dell'Ego è un'illusione, come uno specchio caleidoscopico che ti mostra diamanti presi da chissà dove, nient'altro che frammenti della tua stessa immagine. Arthur Janov, che ebbe in cura Lennon nel 1970, aveva un'opinione pessima di Leary e dell'LSD ("la cosa più devastante mai esistita per la salute mentale"). Lennon a quel punto aveva già smesso per i fatti suoi (troppi bad trip), ma l'opinione così netta di Janov avrebbe potuto indurlo a respingere ufficialmente ogni riferimento con la canzone. Era un padre di famiglia, dopotutto.
 |
| La copertina di Aoxomoxoa, dei Grateful Dead (1969) disegnata da Rick Griffin, uno dei Big Five di San Francisco. |
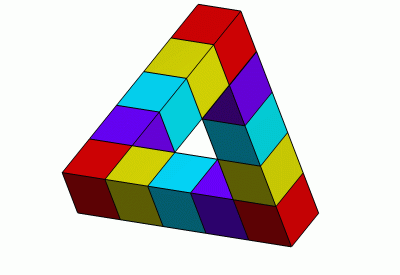 |
| Un triangolo di Penrose. By Tomruen - Own work, CC BY-SA 4.0 |
Climb in the back with your hands in the clouds and you're gone. Oltre a Twist and Shout – la cui cadenza ritorna ovviamente tre volte nella canzone, Lucy ricorda un altro brano di metà anni Sessanta che aveva incastonato la stessa progressione I-IV-V nel ritornello: Like a Rolling Stone (potete benissimo cantare i ritornelli uno sull'altro, se non c'è nessuno in casa a sentirvi: "Lucy" parte nel momento in cui Bob canta "Stone"). Lucy è un valzer: anche Rolling Stone all'inizio era un 3/4, almeno nella testa di Dylan. Nella traiettoria lisergica di Lennon, Lucy è il punto più alto: quello in cui rischia seriamente di perdersi in volo. Non è così chiaro se Lucy sia l'emissaria di una divinità che vorrebbe portarselo via o una donna che lo salva riportandolo a terra: sia come sia, nel momento in cui la realtà bussa alla porta, è fantastico che bussi con le bacchette di Ringo e che faccia partire un rock'n'roll.
35. For No One (Lennon-McCartney, Revolver, 1966)
You want her, you need her, and yet you don't believe her. Dei tre verbi che di solito arrivano assieme (want, need, love) manca il più importante, al suo posto c'è il più amaro. Tra i titoli possibili per il disco del 1966, una volta scoperto che Abracadabra era già stato preso, accanto a Four Sides to the Circle, After Geography e Rock'n'Roll Hits of 1966, Bob Spitz include anche Pendulum. Non c'è dubbio che Revolver suoni meglio, e che la rotazione sia una metafora più dinamica e coinvolgente rispetto all'oscillazione. E tuttavia c'è qualcosa di manifestamente pendolare in Revolver, un movimento abbastanza meccanico tra due identità sempre più definite e in contrasto fra loro: Lennon e McCartney ormai sono due polarità. Oppure in certi casi è lo stesso McCartney a oscillare tra due opposti: allo spettro della solitudine di Eleanor Rigby fa specchio l'utopia infantile di Yellow Submarine. Quanto a For No One, è difficile non immaginarla come la risposta gelida al sentimentalismo di Here, There and Everywhere. L'arrangiamento barocco è meno vistoso di quello di Eleanor e ha una funzione opposta: invece di accrescere il pathos, mantiene una sensazione di estraniamento. Lo senti già dal ritmo della strofa, una specie di valzer quadrato (un colpo in battere e tre in levare) spigoloso e artefatto – l'opposto di quel senso di liquida intimità che i cori conferivano alla strofa di Here, There. Quest'ultima cominciava con un languido verso introduttivo: For No One parte immediatamente col cantato, come se Paul non avesse tempo da perdere e in effetti uno dei suoi argomenti è che le relazioni fallite sono una gran perdita di tempo.
For No One è la più classica delle canzoni di disamore di McCartney, a questo punto ormai diventate un sottogenere codificato. È la più amara: la prima in cui la partner assume la terza persona, segno che ormai la separazione si è consumata. È anche l'ultima: fa un certo effetto pensare che Paul e Jane Asher avrebbero continuato a vedersi per altri due anni. Per trovare di nuovo un'amarezza del genere in un brano di Paul bisognerà attendere Abbey Road, e a quel punto non sarà la fine di una coppia, ma la fine del gruppo. Come ogni altra canzone di disamore, è disarmante: quando al colmo dell'amarezza Paul canta "A love that should have lasted years!" non puoi fare a meno di pensare che di solito nelle canzoni l'amore è eterno, anche solo per convenzione. Non per Paul: Paul aveva previsto un tot di anni insieme a questa persona e adesso è un problema, bisognerà trovare un rimpiazzo, una supplente, allestire dei provini in corsa, che fatica.
C'è un assolo smagliante di corno inglese accelerato (George Martin e Paul McCartney stavano inventando in laboratorio strumenti che non esistevano) che ti lascia lucido e impassibile. Ci sono versi di una freddezza definitiva, costruiti con un lessico di base ma con l'abilità necessaria per metterti nella posizione di disagio in cui si trova l'io narrante: "tu stai a casa, lei esce, dice che tanto tempo fa conosceva qualcuno ma adesso se n'è andato, non ha più bisogno di lui". Non riesci nemmeno a capire se sta parlando di te, non è il caso di chiedere, l'unica cosa è far finta di niente e ci provi, stai osservando più te stesso che lei, è quel tipo di emozione che sperimenti quando stai pilotando una relazione verso la fine riducendo i danni. Non proprio l'emozione che vorresti provare ascoltando un disco pop o rock, ma è un'emozione pure questa e Paul l'ha messa in una breve canzone per il grande pubblico. È stato probabilmente il primo della sua generazione a riuscirci (in America c'era Dylan che però poteva girare intorno al concetto per otto strofe). Tutt'intorno c'erano ancora innamorati o semplici ingrifati che ululavano alla luna. Lei piange, ma per chi? Come aveva già scoperto John in I'm a Loser, siamo tutti soli quando piangiamo. Le lacrime servono solo a noi stessi: o a nessuno.
34. Dear Prudence (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968).
"...Nessuno poteva sapere che presto o tardi sarebbe andata completamente fuori di testa sotto la cura di Maharishi Mahesh Yogi. Tutta la gente intorno era molto preoccupata per la ragazza, perché stava diventando matta, così noi le abbiamo cantato..." (recitativo di Lennon, dal demo di Dear Prudence registrato ad Esher).
La prima cosa che sentiamo emergere dal frastuono aeroportuale di Back in the USSR è un arpeggio di chitarra acustica. Non è il primo, ma suona come se lo fosse. I Beatles hanno scoperto il fingerpicking: per impararlo hanno dovuto davvero prendere l'aereo e viaggiare nell'altro capo del mondo, anche se alla fine il loro maestro era un chitarrista di Glasgow, Donovan Phillips Leitch. È uno degli aspetti che dividono il Disco Bianco dai precedenti: a partire dal 1966 e fino a tutto il Magical Mystery Tour, i tre compositori dei Beatles avevano preferito cercare nuove melodie su strumenti a tastiera. Il soggiorno in India cambia tutto: i Beatles passano più tempo all'aria aperta e si ritrovano più facilmente una chitarra tra le mani. C'è un bel sole, il cielo è azzurro, solo la sorellina di Mia Farrow non vuole uscire a giocare. Che in inglese si dice "play", e indica anche i giochi che si fanno con gli strumenti: la musica, insomma. "Scelsero me e George per cercare di tirarla fuori perché di noi si sarebbe fidata. Se fosse stata in Occidente, l'avrebbero ricoverata... Era rimasta rinchiusa per tre settimane, cercando di arrivare a Dio più rapidamente di chiunque altro. Questa era la competizione al campo di Maharishi: chi sarebbe diventato cosmico per primo".
I due ingredienti di molte canzoni del Bianco sono tipicamente chitarristici: riff insistiti e arpeggi. In Dear Prudence, oltre all'arpeggio così tipicamente lennoniano, verso la coda si aggiunge anche un riff a mò di contrappunto in classico stile George Harrison. Salvo che né Lennon né Harrison avevano mai suonato le chitarre così: è un nuovo inizio per entrambi. In sostanza la miscela di suoni hard rock e folk che costituirà la formula del rock milionario della prima metà degli anni Settanta era già a disposizione dei Beatles dalla primavera del 1968. Nel giro di due brani, il Disco Bianco è già oscillato da Chuck Berry ai Led Zeppelin.
Dear Prudence è una canzone che ha mantenuto una sua 'credibilità rock' per molto più tempo di altre composizioni di Lennon-McCartney: tornerà in classifica addirittura nel 1983 nella versione postpunk ma non troppo infedele di Siouxsie and the Banshees (con Robert Smith alla chitarra). Nel frattempo il fingerpicking era diventato un fenomeno di massa. Le nozioni che Donovan generosamente aveva condiviso con John venivano scambiate da milioni di chitarristi da falò ai loro discepoli ansiosi di far bella figura con ragazze. Tutte queste cose però Lennon non poteva ancora saperle, quando escogitava un arpeggio per snidare Prudence Farrow dal suo bungalow. Il canovaccio che milioni di ragazzi avrebbero recitato sulle spiagge del mondo libero per almeno vent'anni, comincia nel resort del Maharishi. Lennon si trova a essere un pioniere anche stavolta, e anche stavolta ci regala qualcosa di meno banale di tante cose venute dopo. Il suo arpeggio è una ruota di note gentili, delicate, ma anche insistenti, ossessive. Cara Prudence, bisogna proprio che vieni fuori. Gli accordi scorrono con grazia, ma il mi cantino continua a suonare quella nota assillante che dà tregua né a chi ascolta né a chi suona. C'è un limite oltre il quale l'insistenza diventa stalking, e non è escluso che Lennon in Dear Prudence lo oltrepassi. D'altro canto, perché dobbiamo sempre fissarci sul lato negativo? Il sole è alto, il cielo e blu, Dear Prudence è una bella canzone e John Lennon quel pomeriggio un tipo simpatico che si preoccupava per una ragazza che meditava troppo.
33. Please Please Me (Lennon-McCartney, lato A del primo singolo del 1963; poi nell'album omonimo).
Last night I said these words. E se decidessimo che è tutto cominciato con i Beatles? Come il Big Bang. Potremmo stabilire che tutta la cultura pop prima di loro non esistesse, e un attimo dopo fosse completamente compresa in loro, già in fase di espansione. Il rock, il pop, le boyband, la psichedelia, la musica elettronica... tutto ciò che ora popola galassie lontane, già in embrione nei Beatles. In questo caso Please Please Me sarebbe una delle prime rapidissime ere dell'universo, magari l'era della nucleosintesi (in cui la maggior parte dei neutroni decadde in protoni). Durò più o meno 100 secondi; Please Please Me non molti di più. Ma in quei secondi possiamo ingegnarci a trovare le tracce di qualsiasi cosa. C'è il rock, ovviamente ("Come on! Come on!), c'è la sfida al pentagramma di Paul che cantando tiene la stessa nota anche quando John è appena un semitono più sotto; c'è un riff di armonica ma anche due rapidi riff di chitarra a metà strofa, i giochi di parole ammiccanti (quei due "please" che suonano uguali e dicono l'esatto opposto: "ti prego, soddisfami"), un certo tasso di possessività maschile ancora confusa con un sentimentalismo sfacciato e persino qualche timida incursione nel surreale ("c'è sempre pioggia nel mio cuore"). Ci sono i ritornelli e c'è un bridge, c'è un finale con Ringo in gran spolvero perché deve dimostrare che merita di suonare in studio con gli altri tre. Potremmo decidere che è tutto cominciato così, con l'armonica di John Lennon che separa la luce dalle tenebre. Ma dobbiamo proprio?
È come se avessimo bisogno di leggende ed eroi, ci spiegava Stephen Jay Gould in Bravo Brontosauro. Ogni volta che ci viene proposto di scegliere tra un mito della creazione e una teoria dell'evoluzione, il primo ci sembra più praticabile. Gould faceva l'esempio del baseball: se gli americani avessero accettato che era nato dall'evoluzione continua di altri giochi con la mazza e con la palla provenienti dalle isole britanniche, non avrebbero avuto eroi da onorare e musei da visitare. Niente simboli, niente storie epiche: una storia che ti priva di queste cose, è ancora una storia che vale la pena raccontare?
"Sono nato nel 1963, quello che, per ragioni varie e non solo narcisistiche, considero il Primo Anno del Rock. (Il rock'n'roll anni cinquanta era più grezzo e spettacolare; è nel 1963 – l'anno di Beatles, Dylan e degli Stones – che l'idea del rock come Arte, del rock come Rivoluzione, del rock come Stile di Vita e del rock come Forma Consapevolmente Innovativa cominciò davvero a esistere)". In questo brano di Retromania (2011) Simon Reynolds afferma la sua fede in un mito della creazione: non è che non si suonasse qualcosa di simile al rock anche prima del 1963, ma... in un qualche modo non conta; l'Arte, la Rivoluzione, lo Stile di Vita, la Consapevolezza cominciano con l'armonica di Lennon. Eppure.
Eppure basta avvicinarci al supposto Big Bang per scoprire che tante cose esistevano già. Persino quell'armonica, sappiamo che Lennon l'aveva ripresa in mano perché ne aveva sentita una nel brano che aveva appena scalato le classifiche inglesi. La stessa Please Please Me, che all'inizio era più lenta e confidenziale, per sua ammissione era un tentativo di imitare, "tra tutti, proprio Roy Orbison". E se il risultato finale dopo l'accelerazione impressa da George Martin, non assomiglia a nessuna canzone di Orbison in particolare, sembra però adattarsi alla descrizione che ne dà Dylan nella sua autobiografia: "Orbison andava al di là di tutti i generi, folk, country, rock and roll o qualunque altra cosa. Mescolava tutti gli stili, compresi quelli che non erano ancora stati inventati. In un verso cantava veramente da cattivo, in quello dopo se ne usciva con un falsetto alla Frankie Valli. Con Roy non si sapeva mai se stavi ascoltando del mariachi o un'opera lirica". L'Orbison idealizzato da Dylan è già un autore postmoderno, un'enciclopedia di stili che sfoglia e ricombina a suo piacimento, sempre con l'obiettivo di stupire l'ascoltatore. Please Please Me è un brano che conserva questa imprevedibilità: anche dal cantante non sappiamo cosa aspettarci, è una canzone d'amore o di frustrazione?
"I don't want to sound complaining", mente John, che nel brano si lamenta eccome: ma il prodotto finito è così scoppiettante che anche le sue recriminazioni sembrano uno scherzo. I più smaliziati in effetti leggono in Please Please Me l'auspicio di una più generosa disponibilità della partner al sesso orale ("as I please you"), e se la cosa può sembrare un po' osée per il 1963, bisogna ricordare che anche in questo i Beatles non facevano che rispondere alle sollecitazioni dell'ambiente: se non avessero inciso Please l'alternativa sarebbe stata l'altrettanto ammiccante How Do You Do It di Mitch Murray ("Come fai a fare le cose che mi fai? Se sapessi come fai te le farei"). Dopotutto la Parlophone era famosa per i dischi di varietà. I Beatles non avevano ancora messo a fuoco il loro target: nel giro di pochi mesi, man mano che si chiariva l'età piuttosto bassa e la preponderanza femminile del loro pubblico, i riferimenti al sesso si sarebbero stemperati..
C'è veramente tanta roba in Please Please Me, come se i Beatles ritenessero di avere a disposizione solo un altro singolo per sparare tutte le cartucce che avevano: e forse era così. Ma se Reynolds avesse voluto guardare più da vicino, avrebbe constatato che è tutta roba che esisteva già: i Beatles muovono i primi passi in un mondo già saturo di stili musicali. Quello che dal nostro remoto punto di vista sembra il Big Bang, non era che una collisione di elementi già disponibili in natura. Certo, accettarlo implica una concessione pesante: ammettere che l'universo esisteva, e suonava musica interessante, anche prima che nascessimo noi.
32. Day Tripper (Lennon-McCartney, singolo, dicembre 1965)
Ci ho messo così tanto ad accorgermene. Dando un'occhiata alle classifiche appare abbastanza chiaro che Day Tripper fu un mezzo passo falso, soprattutto negli USA. Dopo tre anni, John Lennon aveva anche il diritto di farne. Eppure in un certo senso non se ne riprese più: su Day Tripper aveva scommesso, si era impuntato contro il parere dei colleghi; aveva preteso che non fosse considerato un Lato B, ma una canzone a pari dignità con quella della facciata opposta. Col senno del poi, la posta in gioco era la direzione artistica del quartetto, che dal 1966 passa inesorabilmente al collega che nell'anno precedente aveva associato la sua voce e la sua immagine a Yesterday e Michelle. Paul si assumerà la responsabilità del lato A del singolo successivo (Paperback Writer), di entrambi i lati del seguente (Eleanor Rigby / Yellow Submarine) e di quasi tutti i singoli da lì in poi, pur con eccezioni importanti (Strawberry Fields almeno ottenne pari dignità rispetto a Penny Lane). È interessante notare che il 1965 che termina con passo falso di Day Tripper, era iniziato con un singolo completamente lennoniano: Ticket to Ride / Yes It Is.
Ma anche nei confronti di un brano innovativo come Ticket, questa Day Tripper risultava un po' deludente, al punto che gli stessi autori sentirono abbastanza presto la necessità di giustificarsi: era un brano scritto in fretta per rispettare una scadenza. Il che in realtà si potrebbe dire quasi di tutti i brani dei Beatles – soprattutto dei primi quattro anni – ma non particolarmente di Day Tripper, che cronologicamente appartiene al blocco delle canzoni di Rubber Soul: per dire, tre giorni prima di inciderla avevano già completato Drive My Car; nello stesso giorno finirono If I Needed Someone, due giorni dopo In My Life, quattro giorni dopo la canzone "rivale", We Can Work It Out. Non è che fossero a corto di buone canzoni, insomma. Ma in un qualche modo Lennon pensava che Day Tripper avrebbe funzionato come singolo meglio di tutte le altre: e si sbagliava. Un anno prima aveva scommesso su I Feel Fine e aveva portato a casa la quinta Numero Uno in due anni. Il riff di Day Tripper nasce proprio come un'evoluzione di quello di I Feel Fine: è più incisivo ma ancora piuttosto ingombrante. Per Lennon la direzione era segnata: i Beatles dovevano indurirsi, lasciare perdere i coretti sdolcinati che ancora incrostavano il bridge di I Feel Fine, assumere un atteggiamento più disincantato nei confronti delle relazioni con l'altro sesso.
Day Tripper è una risposta alla sfida dei gruppi che stavano avendo successo con pubblici più maschili: gli Who di My Generation, i Rolling Stones di Satisfaction. Prima ancora che con le parole, Lennon risponde con la chitarra: suonate questo riff se ne siete capaci (il riff dal vivo però lo suonava George). Proprio quando la solita alternanza di Mi, La e ancora Mi ti ha convinto che Day Tripper è il solito blues, e che stavolta insomma i Beatles non si sono sprecati a inventare qualcosa di nuovo, proprio quando stai per aspettarti il solito Si, la progressione tradisce le tue aspettative con un Fa#: per una coincidenza che forse non lo è, è anche il momento in cui John e Paul scoprono che la tizia è un'impostora, una poser, una che che vuole essere a casa in giornata ("She was a day tripper!") Da lì in poi non c'è più nessun sentiero tracciato: per una battuta si torna al La ("It took me so"...), ma solo per scivolare un semitono più sotto ("...long"), dal La bemolle si rimbalza di una quinta al Do# ("to find out"), e a quel punto per una strada completamente nuova ritroviamo il caro vecchio Si: e per una coincidenza che forse non lo è, il testo ripete "And I found out". Un bel viaggio, anche se breve. Ma purtroppo quando fai uscire un singolo la prima impressione è molto importante: e la prima impressione che lasciava Day Tripper veniva impressa dalle prime battute: un riff pentatonico su un blues, niente che gli stessi Beatles non ci avessero già fatto ascoltare con I Feel Fine, appunto. Quanto al bridge, tutto su un accordo solo con le voci armonizzate che salgono di tono e di volume, sembra quasi ritagliato da Twist and Shout, uno dei primi esempi di autocitazione.
Per quanto riguarda le parole, si fa fatica a non interpretare Day Tripper come un'evoluzione cinica di Ticket to Ride: la presa di distanza da una ragazza che simulava una disponibilità che non aveva intenzione di concedere davvero. Per l'ennesimo buffo paradosso, questa canzone che evidentemente parla di sesso e di quanto sia frustrante a volte cercarlo, è una delle poche che sia per John sia per Paul parlerebbe invece di stupefacenti. Lucy no, Cold Turkey neanche, ma questa sì. Dovremmo dunque credere che "tripper" alluda già alle prime esperienze di LSD; che i Beatles a fine 1965 avessero spalancato le porte della coscienza al punto da dedicare mezzo singolo di Natale a irridere i "viaggiatori della domenica", quei poveri mortali che facevano della droga ancora un banale uso ricreativo. Uno sfoggio di snobismo mai svelato fino a quel momento, e nemmeno in seguito. Dovremmo credere a tutto questo quando sappiamo benissimo che durante le prove Paul e John cantavano "she's a prick teaser". Ma forse negli anni successivi ammettere di avere fatto uso di droghe era più socialmente accettabile di essersi comportati da stronzi con una o più groupie. Forse uno dei motivi per cui Day Tripper non aveva funzionato era proprio questo tipo di stronzaggine, perfetta nella bocca larga di un Mick Jagger, ma che non si adattava né all'immagine pulitina dei Beatles pre-Day Tripper né a quella peace and love che si sarebbe messa a fuoco nei mesi successivi. I Beatles potevano assumere tante forme, ma non potevano fare gli stronzi. Lennon ogni tanto ci provava, ma pensare di poterlo fare sul singolo di Natale fu imperdonabile.
31. She Said She Said (Lennon-McCartney, Revolver, 1966).
"Peter Fonda continuava a sedermi di fianco e a mormorare: "so come ci si sente a essere morti". Gli dicevamo "Per l'amore del cielo, taci, non ci interessa! Non vogliamo saperlo!"
She said: you don't understand what I said. I said no no no, you're wrong. Ecco, questa è la prima volta che m'incazzo io. Cosa ci fa fuori dalle prime trenta un brano da podio? Delle due tracce di Revolver che suonavano ancora attuali ancora negli anni '90, She Said She Said è apparentemente meno innovativa di Tomorrow Never Knows. Eppure quando penso a tutti i tentativi di stravolgere la forma "canzone rock" nell'ultimo mezzo secolo, continua a non venirmi in mente niente di più estremo del passaggio a 3/4 di She Said She Said. Una soluzione che in altri casi viene dispensata con compiacimento e qui invece è tanto inattesa quanto necessaria – come rompere la tela di un quadro, e poi riaggiustarla appiccicandoci il disegno di un bambino ("when I was a boy...")
 |
| Peter Fonda uscito da un tribunale a Los Angeles, dov'era stato interrogato per possesso di marijuana, nel 1966 (AP Photo/Ellis R. Bosworth) |
In She Said She Said manca Paul McCartney – un fatto rarissimo in tutta la discografia beatle: succede soltanto in qualche altro brano fortemente idiosincratico, come Julia o Revolution 9. Lo stesso Paul ha ricordi confusi, ma potrebbe essere l'unica volta che se n'è andato dopo una discussione. Il sospetto che non riuscisse a mandar giù quel bridge in 3/4 è irresistibile. Magari era convinto che avrebbe rovinato la canzone e oggettivamente non avrebbe tutti i torti – ma cosa significa "oggettivamente". Paul era anche l'unico dei quattro a non avere assunto LSD durante la festa nella residenza californiana di Zsa Zsa Gabor, il 24 agosto 1965. Per Ringo fu la prima volta: per John e George la seconda dopo un primo test involontario in primavera, quando un dentista gliene aveva somministrato senza avvertirli.
Forse è solo una coincidenza: fatto sta che gli altri tre ci danno dentro come se non ci fosse un domani (Ringo è nella modalità Rain) e il risultato è un rock trasudante un'angoscia esistenziale che diventerà moneta corrente solo due generazioni più tardi. Nessun altro gruppo nel 1966 sarebbe riuscito a suonare o anche solo a concepire She Said She Said: ci voleva una fantasia e un coraggio che solo i Beatles potevano permettersi. Come molte canzoni di Revolver, She Said parla di droga, ma senza condividere i toni euforici di Got to Get You né quelli estatici di Tomorrow Never Knows: qui si comincia a intuire che la droga è un altro punto di vista sul disagio di vivere. She Said è la prima canzone sugli acidi ed è anche la canzone che ti avverte che gli acidi sono un casino, meglio evitarli se hai cattivi pensieri, e chi non ne ha? No no no chi vi ha messo tutte queste sciocchezze nel cervello, sarebbe meglio non essere mai nati.
Comments (4)
La santa prostituta che non lo era (prostituta)
22-07-2020, 17:51Cristo, repliche, santiPermalink22 luglio - Santa Maria Maddalena, non più peccatrice (I secolo).
[2012]. A Maddalena, che lo vede per prima risorto, Gesù dice una cosa curiosa, che nella versione latina suona Noli me tangere, "non mi toccare". Perché Maddalena non lo può toccare? Eppure più tardi Gesù acconsentirà a farsi tastare le piaghe da Tommaso, l'apostolo incredulo. Forse perché Maddalena è donna? perché ha un passato discutibile? Ma in realtà nell'originale greco si capisce che Maddalena è già riuscito a toccarlo: più che "non mi toccare" è un "lasciami andare", "mollami". Toccarsi insomma era consentito, ma forse Maddalena insisteva troppo, non lo lasciava andare più, mentre Gesù aveva altre cose da fare, un impegno a Emmaus di lì a poche ore, eccetera. Eppure per secoli in occidente i pittori la scena l'hanno dipinta come se tra Gesù risorto e la donna a lui più vicina ci fosse un abisso. È che Maddalena è proprio difficile da maneggiare.
Di solito scrivere un'agiografia consiste nel trasformare un peccatore in un santo. Si tratta insomma di prendere la vita di un uomo / una donna, enfatizzare le buone azioni e levare le magagne più grosse. Con Santa Maria Maddalena, che pure è un personaggio di primo piano, la cosa è andata in un modo diverso: è da duemila anni che la consideriamo una ex prostituta, e semplicemente non è vero. Cioè, basta tornare ai vangeli: in nessun punto vi è scritto che Maria di Magdala facesse quel mestiere. C'è poi qualche 'peccatrice', nei vangeli, con le quali Gesù si mostra piuttosto tollerante, ma non è chiaro se siano prostitute o semplicemente adultere. C'è quella che lava i piedi a Gesù con le sue lacrime, glieli asciuga coi capelli (portare i capelli sciolti nella Giudea del tempo era già un segno eloquente di vita non irreprensibile), e forse è la stessa che lo unge davanti a tutti, in quella che un fariseo del tempo avrebbe potuto prendere per una caricatura di un'unzione regale. Il vangelo di Giovanni, che è il più tardo, ma come vedremo ha un rapporto particolare con la figura di Maddalena, chiama questa peccatrice "Maria", e soggiunge che era la sorella di Lazzaro e Marta, che si venerano tra sette giorni. Vale la pena di ricordare che il nome "Maria" ("Miriam", la sorella di Mosè) era già al tempo il più diffuso nella zona: basandosi sulle incisioni funerarie, gli archeologi hanno calcolato che il 25% della popolazione femminile portasse quel nome.
Nei vangeli di Marie ce ne sono parecchie, al punto che risulta impossibile contarle perché è chiaro che gli stessi evangelisti – già piuttosto elusivi sui nomi e i ruoli degli apostoli – semplicemente non ci si raccapezzano. Questo è un dettaglio verosimile: chi si metteva a scrivere dopo decenni di narrazioni orali poteva facilmente confondere le figure femminili che dalla morte di Gesù non avevano più avuto molto peso nel movimento dei cristiani, e stavano invecchiando da qualche parte in Palestina o altrove. Per prima c'è la madre di Gesù (che non in tutti i vangeli è chiamata "Maria"); poi la Maddalena, che non necessariamente si prostituisce ma sicuramente viene esorcizzata da Gesù, che le toglie dal corpo "sette demoni", fa parte del suo entourage più ristretto ed è testimone oculare della resurrezione (il nome forse deriva da un paese sul lago di Tiberiade, Magdala appunto, forse dall'ebraico migdal, "torre", "fortezza"); c'è poi la sorella di Marta e di Lazzaro, detta anche Maria di Betania; e ancora un'altra figura dell'entourage apostolico, Maria madre di Giacomo (il quale a sua volta potrebbe anche essere il fratello di Gesù...) A un certo punto a papa Gregorio le tre Marie sodali degli apostoli devono essere sembrate troppe, visto che si permise in un'omelia di ridurle a una sola; poi, siccome almeno una delle tre, in almeno un Vangelo, era chiamata "peccatrice", se ne dedusse che oltre a una e trina la Maddalena dovesse pure essere prostituta.
Se è stata una calunnia, pure non è mancata qualche conseguenza positiva. Pur restando ai margini della società, le prostitute hanno potuto contare su una protettrice di primo rango, una che a Gesù dava del tu. E il fatto che Cristo risorto preferisse apparire per primo a un'ex puttana, piuttosto che agli undici patriarchi della Chiesa Apostolica, ha dato a qualcuno la possibilità di intendere il cristianesimo come una religione un pelo meno maschilista ed elitaria di altre (anche se l'immagine di un Gesù gioviale frequentatore di meretrici è un'altra proiezione; non le lapida, ma le perdona, purché "non pecchino più"). Nel frattempo i pittori hanno potuto raffigurare, nelle crocefissioni e deposizioni e apparizioni, almeno una donna coi capelli sciolti. Molto presto hanno deciso che doveva averli rossi. La riduzione di una seguace di Gesù a prostituta potrebbe avere avuto semplicemente questo senso: più basso era il peccato, più orribile il mestiere, più gloriosa appariva la redenzione. Un Dio che perdona le puttane è uno che davvero può salvare chiunque, non fa una grinza.
Però forse c'è dell'altro. C'è che se le togli quella patina di peccatrice, Maddalena diventa un personaggio un po' più difficile da gestire, per una Chiesa governata dai maschi. Alcuni dettagli sono imbarazzanti: per esempio: da Luca e Marco sappiamo che prima di incontrare Gesù era un'ossessa. Non sappiamo che tipo di disturbi avesse: deliri? Allucinazioni? Però lo stesso Marco - e Giovanni è d'accordo - affermano che fu lei la prima a vedere Gesù risorto. A quel punto non sorprende che gli apostoli non ci abbiano creduto; altrimenti saremmo portati a pensare che si siano lasciati suggestionare da una persona che in passato aveva manifestato segni di squilibrio mentale. Peraltro ai tempi di Gesù la testimonianza delle donne, ossesse o no, non era accettata in sede legale. Non stupisce che Paolo qualche anno dopo non ne faccia menzione ai Corinti: per lui Gesù risorto era riapparso, prima a Pietro "e poi ai Dodici" (Giuda Iscariota era già stato rimpiazzato). Maddalena è come se non ci fosse mai stata. Probabilmente Paolo non si pone nemmeno il problema se la sua apparizione sia reale o no; in ogni caso è stata un'apparizione a una donna, e le donne, per Paolo, non contano. Però, per sgombrare proprio ogni dubbio, a un certo punto si fa strada almeno nella Chiesa d'occidente l'idea che i "sette demoni" scacciati da Gesù non siano i sintomi di una possessione demoniaca, ma i peccati associati alla professione del meretricio. Meglio puttana che isterica - se mi è consentito condensare in poche parole il risultato di un dibattito secolare tra padri della Chiesa, teologi e agiografi e pontefici. Non puoi costruire seri dogmi di fede sulle testimonianze di un'indemoniata: puttana è meglio, dà più affidamento.
Poi c'è la questione del rapporto con Gesù. Per quanto scarsi, i riferimenti dei vangeli alla Maddalena sono sufficienti a farne la seconda donna più importante, dopo la Madonna – però Gesù non le risponde mai male, come si permette di fare qualche volta con la mamma. A quel punto la chiacchiera era inevitabile: insomma, Gesù è un trentenne, c'è questa tizia che lo segue per tutti i vangeli, vuoi vedere che...? Non è una deviazione moderna, se ne parlava già nei primi secoli, lontano dai centri di irradiazione maschile del credo ortodosso, nei circoli (spesso femminili) dove ribolliva quel brodo di credenze che per comodità chiamiamo Gnosi.
La Gnosi è un fenomeno un po' troppo complesso per spiegarlo qui. Grosso modo si trattava della new age del primo secolo: una serie di credenze misteriche che a volte pre-esistevano al cristianesimo, ma non tardarono ad agganciarsi alla figura di Gesù. C'è ancora da precisare che quelle che oggi chiamiamo "sette gnostiche" non avevano la percezione di esserlo: si consideravano cristiani pure loro. Ci volle qualche secolo, qualche concilio, qualche processo per eresia, perché si chiarisse il discrimine tra cristianesimo e gnosi. E siccome la storia la scrivono i vincitori, e spesso i libri dei perdenti vanno distrutti, noi non abbiamo un'idea nitida di quella che poi si è deciso di chiamare Gnosi. Però qualche paletto interessante possiamo piantarlo. Per esempio: gli gnostici si rifanno a rivelazioni che Gesù non avrebbe fatto a tutti, ma solo a un gruppo ristretto di "iniziati". Per contro, il cristianesimo è orgogliosamente essoterico, con due S: dogmi e insegnamenti sono accessibili a tutti, e anche i misteri sono misteri per tutti, non è che il Papa li comprenda meglio di noi.
Un'altra differenza notevole è che mentre il cristianesimo, già dalla generazione di Paolo, sembra affidato a una gerarchia maschile, nella gnosi le figure femminili mantengono ruoli di primo piano: e Maddalena assume un ruolo ancora più importante. Di questa cosa resta un'eco nei vangeli apocrifi più gnosizzanti, come quello secondo Filippo, dove addirittura Gesù "la bacia spesso" (gli esegeti si precipitano a precisare che il bacio gnostico non è quel che pensiamo noi, ma una trasmissione di saperi e di energie eccetera), al punto che gli altri apostoli fanno una scenata di gelosia perché ritengono che Gesù non li baci abbastanza. Nel vangelo di Tommaso c'è addirittura una promessa di transessualità: a Pietro che si lamenta che una femmina sia ammessa tra gli iniziati, Gesù replica che la trasformerà in un maschio, "perché ogni donna che farà di sé un uomo entrerà nel Regno dei Cieli". Il testo mantiene ancora un maschilismo di fondo: altrove l'eterno femminino è reclamato come portatore di saggezza, verità, energia, tutto quell'insieme di cose. Nel Pistis Sophia, il testo gnostico più completo che ci è rimasto, Cristo risponde a 64 quesiti dei discepoli iniziati. Di questi, 39 li pone Maddalena, e Cristo non cessa di lodarla. Da lì a considerarla sua sposa il passo era breve. C'è pure chi la voleva autrice del Vangelo di Giovanni, visto che l'autore si presenta come "il discepolo che Gesù amava": meglio lei del ragazzino, in fondo.
Un'altra possibilità è che fosse la moglie di Giovanni, oppure la sua fidanzata, poi votatasi alla verginità: ipotesi liquidata come fantasia da Iacopo di Varazze, il che è molto buffo perché Iacopo è l'agiografo di bocca buona per eccellenza, non c'è drago o mostro o supplizio che non valga la pena riportare: però una liaison tra Maddalena e Giovanni no, quella era meno verosimile del drago di San Giorgio. In ogni caso per la Chiesa ufficiale era meglio prostituta. Le prostitute sono simpatiche e non pretendono d'insegnare niente ai maggiorenni. Se poi si pentono tutti sono contenti, ma nessuno si aspetta di trovarsele in cima alla scala gerarchica, sopra gli apostoli o addirittura sullo stesso piano di Cristo.
Nel Pendolo di Foucault (1988), tre avventurieri da casa editrice si fanno stampare dal computer una sequenza randomizzata di frasi enigmatiche, e poi provano a utilizzarle per costruire una teoria del complotto. Il risultato finale è: Gesù non è morto, ha sposato Maddalena e ha fondato la dinastia merovingia. Quello è il senso del mistero del Graal: non un semplice calice che contiene il sangue di Cristo, ma l'utero pregno di Maria. Uno dei tre nota che la storia non gli è nuova, l'ha appena letta su un manoscritto che gli è stato proposto. In realtà il manoscritto era già stato pubblicato nel 1982 col titolo The Holy Blood and The Holy Grail, e aveva avuto un certo successo, tanto che nel 1987 i suoi autori (Michael Baigent, Richard Leigh e Henry Lincoln) ne avevano pubblicato un seguito. Questa nozione è fondamentale per evitare di considerare Umberto Eco un profeta, che pubblica stringhe randomizzate in un libro del 1988 che diventano nel 2003 la trama di un best seller mondiale, Il codice da Vinci. In realtà sia Eco che Dan Brown si rifacevano a The Holy Blood, quest'ultimo così apertamente che il nome del protagonista, Leigh Teabing, è un anagramma di Michael Baigent. Il testo del 1982 è considerato un incunabulo della letteratura pseudostorica, e in particolare di un filone così fortunato da essere diventato un genere a sé, all'incrocio tra la ricerca del Graal, le derive sui templari e il fantomatico priorato di Sion: il mistero di Rennes-le-Château (di solito evito di lincare wikipedia, ma meglio guardare lì che in altri siti, potreste imbattervi in troll antropomorfi e no).
Tra pseudostoria e fantarcheologia sta anche il documentario di Discovery Channel prodotto da James Cameron qualche anno fa, The Lost Tomb of Jesus, in cui veniva esibita una possibile tomba di Cristo, a Gerusalemme. Non solo la tomba custodiva delle ossa, il che ovviamente metterebbe in crisi duemila anni di fede nella resurrezione dei corpi; ma si tratterebbe di una tomba di famiglia, Gesù figlio di Giuseppe ("Yeshua bar Yehoseph" in un'iscrizione) sarebbe sepolto vicino a sua madre ("Miriam"), al padre o a un fratello ("Yose", diminutivo di Yehoseph), e a una donna con la quale non ha DNA in comune, di nome "Mariamene", variante di Miriam. Ci sarebbe anche un figlio, col nome meno intuitivo che Gesù avrebbe potuto dare a un figlio suo, Yehuda (Giuda). D'altro canto se Gesù ha avuto un figlio, forse non è nemmeno morto in croce e quindi Giuda non l'ha tradito e, insomma, il cristianesimo sarebbe tutto da rifare. Ma la storia fa acqua da tutte le parti: l'unico argomento a favore è la possibilità statistica di ritrovare, in Palestina, una famiglia con tante coincidenze con quella descritta dai vangeli: un Gesù che sia figlio di un Giuseppe e di una Maria, e sposato a un'altra Maria. In realtà come si è visto erano tutti nomi comunissimi, e poi perché mai dei galilei avrebbero dovuto comprarsi una tomba di famiglia nei pressi di Gerusalemme? E poi il non avere un DNA in comune non è un argomento molto probante per considerare Mariamene la moglie di Yeshua; e poi chi l'ha detto che Mariamene sta per Maddalena? Eccetera eccetera.
Nel frattempo la Chiesa cattolica ha chiesto scusa, con la sua proverbiale tempestività, nel 1969, ammettendo che Maddalena non è la buona donna nel senso eufemistico dell'epiteto. È stata persino cambiato un verso del Dies Irae: Qui Mariam absolvisti è diventato Peccatricem qui solvisti. Ma conta poco. Ormai il vangelo non è più proprietà della Chiesa, Vallo a spiegare a chi si è inflitto L'ultima tentazione di Scorsese, vallo a spiegare a chi guarda Jesus Christ Superstar e si commuove quando Yvonne Elliman canta Everything's alright o Could we start again, please? Rischi che ti diano del revisionista, uno che vuole purgare i vangeli dalle prostitute, mentre lo sanno tutti che nei vangeli c'è un sacco di prostitute, e Maddalena è la rappresentante di categoria...
A lei poi probabilmente la cosa neanche scoccia, voglio dire, quando sei a quei livelli possono dire di te quel che vogliono: indemoniata, isterica, puttana, regina merovingia, sposa di Cristo, eterno femminino, che differenza fa. Non ti tocca più niente.
 |
| "(Non sarò mai) Maria Maddalena". |
Di solito scrivere un'agiografia consiste nel trasformare un peccatore in un santo. Si tratta insomma di prendere la vita di un uomo / una donna, enfatizzare le buone azioni e levare le magagne più grosse. Con Santa Maria Maddalena, che pure è un personaggio di primo piano, la cosa è andata in un modo diverso: è da duemila anni che la consideriamo una ex prostituta, e semplicemente non è vero. Cioè, basta tornare ai vangeli: in nessun punto vi è scritto che Maria di Magdala facesse quel mestiere. C'è poi qualche 'peccatrice', nei vangeli, con le quali Gesù si mostra piuttosto tollerante, ma non è chiaro se siano prostitute o semplicemente adultere. C'è quella che lava i piedi a Gesù con le sue lacrime, glieli asciuga coi capelli (portare i capelli sciolti nella Giudea del tempo era già un segno eloquente di vita non irreprensibile), e forse è la stessa che lo unge davanti a tutti, in quella che un fariseo del tempo avrebbe potuto prendere per una caricatura di un'unzione regale. Il vangelo di Giovanni, che è il più tardo, ma come vedremo ha un rapporto particolare con la figura di Maddalena, chiama questa peccatrice "Maria", e soggiunge che era la sorella di Lazzaro e Marta, che si venerano tra sette giorni. Vale la pena di ricordare che il nome "Maria" ("Miriam", la sorella di Mosè) era già al tempo il più diffuso nella zona: basandosi sulle incisioni funerarie, gli archeologi hanno calcolato che il 25% della popolazione femminile portasse quel nome.
Nei vangeli di Marie ce ne sono parecchie, al punto che risulta impossibile contarle perché è chiaro che gli stessi evangelisti – già piuttosto elusivi sui nomi e i ruoli degli apostoli – semplicemente non ci si raccapezzano. Questo è un dettaglio verosimile: chi si metteva a scrivere dopo decenni di narrazioni orali poteva facilmente confondere le figure femminili che dalla morte di Gesù non avevano più avuto molto peso nel movimento dei cristiani, e stavano invecchiando da qualche parte in Palestina o altrove. Per prima c'è la madre di Gesù (che non in tutti i vangeli è chiamata "Maria"); poi la Maddalena, che non necessariamente si prostituisce ma sicuramente viene esorcizzata da Gesù, che le toglie dal corpo "sette demoni", fa parte del suo entourage più ristretto ed è testimone oculare della resurrezione (il nome forse deriva da un paese sul lago di Tiberiade, Magdala appunto, forse dall'ebraico migdal, "torre", "fortezza"); c'è poi la sorella di Marta e di Lazzaro, detta anche Maria di Betania; e ancora un'altra figura dell'entourage apostolico, Maria madre di Giacomo (il quale a sua volta potrebbe anche essere il fratello di Gesù...) A un certo punto a papa Gregorio le tre Marie sodali degli apostoli devono essere sembrate troppe, visto che si permise in un'omelia di ridurle a una sola; poi, siccome almeno una delle tre, in almeno un Vangelo, era chiamata "peccatrice", se ne dedusse che oltre a una e trina la Maddalena dovesse pure essere prostituta.
 |
| Maddalena penitente, Georges de La Tour, 1640. |
 |
| Mary, mmm, that is good. |
Poi c'è la questione del rapporto con Gesù. Per quanto scarsi, i riferimenti dei vangeli alla Maddalena sono sufficienti a farne la seconda donna più importante, dopo la Madonna – però Gesù non le risponde mai male, come si permette di fare qualche volta con la mamma. A quel punto la chiacchiera era inevitabile: insomma, Gesù è un trentenne, c'è questa tizia che lo segue per tutti i vangeli, vuoi vedere che...? Non è una deviazione moderna, se ne parlava già nei primi secoli, lontano dai centri di irradiazione maschile del credo ortodosso, nei circoli (spesso femminili) dove ribolliva quel brodo di credenze che per comodità chiamiamo Gnosi.
La Gnosi è un fenomeno un po' troppo complesso per spiegarlo qui. Grosso modo si trattava della new age del primo secolo: una serie di credenze misteriche che a volte pre-esistevano al cristianesimo, ma non tardarono ad agganciarsi alla figura di Gesù. C'è ancora da precisare che quelle che oggi chiamiamo "sette gnostiche" non avevano la percezione di esserlo: si consideravano cristiani pure loro. Ci volle qualche secolo, qualche concilio, qualche processo per eresia, perché si chiarisse il discrimine tra cristianesimo e gnosi. E siccome la storia la scrivono i vincitori, e spesso i libri dei perdenti vanno distrutti, noi non abbiamo un'idea nitida di quella che poi si è deciso di chiamare Gnosi. Però qualche paletto interessante possiamo piantarlo. Per esempio: gli gnostici si rifanno a rivelazioni che Gesù non avrebbe fatto a tutti, ma solo a un gruppo ristretto di "iniziati". Per contro, il cristianesimo è orgogliosamente essoterico, con due S: dogmi e insegnamenti sono accessibili a tutti, e anche i misteri sono misteri per tutti, non è che il Papa li comprenda meglio di noi.
Un'altra differenza notevole è che mentre il cristianesimo, già dalla generazione di Paolo, sembra affidato a una gerarchia maschile, nella gnosi le figure femminili mantengono ruoli di primo piano: e Maddalena assume un ruolo ancora più importante. Di questa cosa resta un'eco nei vangeli apocrifi più gnosizzanti, come quello secondo Filippo, dove addirittura Gesù "la bacia spesso" (gli esegeti si precipitano a precisare che il bacio gnostico non è quel che pensiamo noi, ma una trasmissione di saperi e di energie eccetera), al punto che gli altri apostoli fanno una scenata di gelosia perché ritengono che Gesù non li baci abbastanza. Nel vangelo di Tommaso c'è addirittura una promessa di transessualità: a Pietro che si lamenta che una femmina sia ammessa tra gli iniziati, Gesù replica che la trasformerà in un maschio, "perché ogni donna che farà di sé un uomo entrerà nel Regno dei Cieli". Il testo mantiene ancora un maschilismo di fondo: altrove l'eterno femminino è reclamato come portatore di saggezza, verità, energia, tutto quell'insieme di cose. Nel Pistis Sophia, il testo gnostico più completo che ci è rimasto, Cristo risponde a 64 quesiti dei discepoli iniziati. Di questi, 39 li pone Maddalena, e Cristo non cessa di lodarla. Da lì a considerarla sua sposa il passo era breve. C'è pure chi la voleva autrice del Vangelo di Giovanni, visto che l'autore si presenta come "il discepolo che Gesù amava": meglio lei del ragazzino, in fondo.
Un'altra possibilità è che fosse la moglie di Giovanni, oppure la sua fidanzata, poi votatasi alla verginità: ipotesi liquidata come fantasia da Iacopo di Varazze, il che è molto buffo perché Iacopo è l'agiografo di bocca buona per eccellenza, non c'è drago o mostro o supplizio che non valga la pena riportare: però una liaison tra Maddalena e Giovanni no, quella era meno verosimile del drago di San Giorgio. In ogni caso per la Chiesa ufficiale era meglio prostituta. Le prostitute sono simpatiche e non pretendono d'insegnare niente ai maggiorenni. Se poi si pentono tutti sono contenti, ma nessuno si aspetta di trovarsele in cima alla scala gerarchica, sopra gli apostoli o addirittura sullo stesso piano di Cristo.
 |
| Ecco, in effetti se vai in giro acconciata così nella Palestina del I secolo poi per forza la gente si fa certe idee. |
Tra pseudostoria e fantarcheologia sta anche il documentario di Discovery Channel prodotto da James Cameron qualche anno fa, The Lost Tomb of Jesus, in cui veniva esibita una possibile tomba di Cristo, a Gerusalemme. Non solo la tomba custodiva delle ossa, il che ovviamente metterebbe in crisi duemila anni di fede nella resurrezione dei corpi; ma si tratterebbe di una tomba di famiglia, Gesù figlio di Giuseppe ("Yeshua bar Yehoseph" in un'iscrizione) sarebbe sepolto vicino a sua madre ("Miriam"), al padre o a un fratello ("Yose", diminutivo di Yehoseph), e a una donna con la quale non ha DNA in comune, di nome "Mariamene", variante di Miriam. Ci sarebbe anche un figlio, col nome meno intuitivo che Gesù avrebbe potuto dare a un figlio suo, Yehuda (Giuda). D'altro canto se Gesù ha avuto un figlio, forse non è nemmeno morto in croce e quindi Giuda non l'ha tradito e, insomma, il cristianesimo sarebbe tutto da rifare. Ma la storia fa acqua da tutte le parti: l'unico argomento a favore è la possibilità statistica di ritrovare, in Palestina, una famiglia con tante coincidenze con quella descritta dai vangeli: un Gesù che sia figlio di un Giuseppe e di una Maria, e sposato a un'altra Maria. In realtà come si è visto erano tutti nomi comunissimi, e poi perché mai dei galilei avrebbero dovuto comprarsi una tomba di famiglia nei pressi di Gerusalemme? E poi il non avere un DNA in comune non è un argomento molto probante per considerare Mariamene la moglie di Yeshua; e poi chi l'ha detto che Mariamene sta per Maddalena? Eccetera eccetera.
Nel frattempo la Chiesa cattolica ha chiesto scusa, con la sua proverbiale tempestività, nel 1969, ammettendo che Maddalena non è la buona donna nel senso eufemistico dell'epiteto. È stata persino cambiato un verso del Dies Irae: Qui Mariam absolvisti è diventato Peccatricem qui solvisti. Ma conta poco. Ormai il vangelo non è più proprietà della Chiesa, Vallo a spiegare a chi si è inflitto L'ultima tentazione di Scorsese, vallo a spiegare a chi guarda Jesus Christ Superstar e si commuove quando Yvonne Elliman canta Everything's alright o Could we start again, please? Rischi che ti diano del revisionista, uno che vuole purgare i vangeli dalle prostitute, mentre lo sanno tutti che nei vangeli c'è un sacco di prostitute, e Maddalena è la rappresentante di categoria...
A lei poi probabilmente la cosa neanche scoccia, voglio dire, quando sei a quei livelli possono dire di te quel che vogliono: indemoniata, isterica, puttana, regina merovingia, sposa di Cristo, eterno femminino, che differenza fa. Non ti tocca più niente.
Schizogene e la sposa inventata
21-07-2020, 21:5721tw, fascismo, fb2020, giornalistiPermalink– Il dibattito su Indro Schizogene Montanelli, che si è trascinato per quasi un mese, ci ha lasciato pochi punti fermi e uno è lo stato necrotico del giornalismo italiano. Invece di discutere il contesto, di improvvisarsi storici o antropologi, i giornali riguardo a Montanelli avrebbero dovuto fare una sola cosa, molto semplice: andare a verificare la notizia. Magari non nel 2020, con tutti i problemi del lockdown; ma se ne parla già da un anno buono, il pubblico sembra interessato, e da Fiumicino partono voli per l'Africa orientale tutte le settimane: c'era il tempo e l'agio per mandare un reporter in Eritrea a controllare se risultasse un "Indro" nato nel 1938. Visto che è lo stesso Montanelli a raccontarci che Fatima (o Destà) aveva dato il suo nome al primo figlio. "Indro" è un nome strano in italiano, figurarsi in tigrino. Dovrebbe stare sull'ottantina: magari ha avuto figli, magari qualcosa hanno sentito raccontare della nonna. Ecco, una volta si pensava che i giornalisti dovessero fare questa cosa, la caccia alle notizie. Almeno provarci. Invece tra 2019 e 2020 siamo stati più di un anno a discutere una storia che ha una fonte sola: e questa fonte è lo stesso Montanelli, che ogni volta la raccontava un po' diversa. Prima si chiamava in un modo e aveva dodici anni, poi si chiamava in un altro modo e ne aveva quattordici, ecc. ecc. Finché qualcuno giustamente non si è domandato: ma non potrebbe essersi inventato tutto? E nessuno ha sentito la necessità di rispondere.
– Su Montanelli forse avevo ragione quando scrivevo: tiratene giù il monumento prima che il giornalismo italiano prenda la decisione di difenderlo a tutti i costi, prima che ne faccia il suo Fort Apache. Troppo tardi: e così ho potuto leggere e sentire cose straordinarie. Montanelli innamorato. Montanelli che voleva diventare abissino. Montanelli che va relativizzato perché anche nella Bibbia fanno i sacrifici umani (ma veramente no, nella Bibbia non li fanno; ma anche se li facessero, cosa c'entra la Bibbia col 1936... vabbe'). Montanelli giustificato così, Montanelli giustificato colà, neanche fosse un ricco vivo che vi tiene a libro paga, no: l'arte che avete imparato per tenervi a galla tra salotti e redazioni la state impiegando per relativizzare un tizio che se ne strafotteva e raccontava allegramente avventure africane vere o immaginate. E più ne parlavate, più ci confermavate l'unico fatto concreto: ovvero che il tizio si fosse affittato una ragazzina. Le vostre chiacchiere sfumano, e il fatto resta lì incontestato. Ma è questo sul serio il vostro mestiere?
– Di Montanelli forse ho avuto torto a fidarmi. Dettaglio imbarazzante: 19 anni fa, appena tornato da Genova, le pale degli elicotteri ancora nelle orecchie, mentre cerco di scrivere qualcosa di leggibile per le dieci persone che mi leggono e si stanno preoccupando, scopro che IM è appena morto e gli dedico il resoconto che sto scrivendo. Non sono mai stato tanto lontano dalle sue idee, che in quel momento non mi interessano minimamente. Della sposa bambina avevo già sentito parlare e mi sembrava un dettaglio lontanissimo nel tempo, impossibile da accostare all'anziano giornalista che faceva parte del mio paesaggio mediatico sin da quando ero bambino. L'unica cosa che mi muove in quel momento è l'immagine mentale del reporter con la macchina da scrivere sulle ginocchia, il mito del reporter che scrive mentre osserva e scrive solo quello che osserva. Precisamente il monumento che gli hanno fatto. E che al di là di ogni considerazione sugli abusi coloniali, probabilmente non si merita.
– Per me Montanelli era questo: un tizio con opinioni terribili ma un certo rispetto per la verità. Questa cosa m'interessava salvare: ho un approccio storico, m'interessano le testimonianze, non i moralismi. Se avesse avuto scrupoli morali, avrebbe cercato di occultare l'episodio: meno male che non li aveva, meno male che non hai mai pensato di chiedere scusa (come se chiedere scusa servisse a qualcosa) (sul serio, se avesse chiesto scusa 50 anni dopo la statua non gliel'imbrattereste lo stesso?) Finché non ho letto questo pezzo che mi ha messo in crisi. In effetti un tizio che ha raccontato di aver incontrato Adolf Hitler perché si era attardato a pisciare in un cespuglio potrebbe anche essersi inventato una sposa bambina. Perché? Per i motivi per cui i mitomani mitomaneggiano, e che cambiano col tempo: nel 1950 per vantarsi con gli amici, nel 1976 per trollare le femministe, nel 2000 perché ormai era troppo tardi per cambiare versione – come Enrico IV. Tutto plausibile, salvo i cortigiani che continuano a recitare a soggetto dopo vent'anni che il re è morto. E così continuiamo a discutere di una ragazza che magari nemmeno esiste, magari è una foto che IM si è comprato a un mercatino di Asmara. Oppure è esistita ed è la protagonista di un abuso coloniale, ma insomma, sarebbe utile saperlo. O no? Perché ho anche sentito dire questo, in questi giorni. Che alla fine non è necessario che Montanelli abbia abusato di una ragazzina: basta che se ne sia vantato. Non è che non abbia senso: alla fine anche una bugia può servirci a capire la psicologia di chi la racconta e di chi se la fa raccontare. Ma anche quella di chi ci casca, e a volte vuole cascarci.
– Di Montanelli ho sentito dire di tutto. Mi ha colpito la difficoltà di molti a contestualizzare non già le vicende di un graduato italiano nel 1936, ma i discorsi di un giornalista italiano nel 2000. Perché non chiedeva scusa? Perché le scuse non servono mai, e comunque riteneva di non aver fatto nulla di male. Perché ha cambiato l'età, che nel 1969 era 12 anni e nel 2000 diventa 14? Perché nel 2000 (anno 5 post Marcinelle) la pedofilia era diventata uno stigma sociale; sarebbe utile tenere conto che prima non lo era; a proposito, uno storico dovrebbe trovare interessante il fatto che racconti l'infibulazione, un dettaglio che nel 1969 avrebbe considerato ributtante o forse nemmeno conosceva. In ogni caso difficilmente nel 1976 o nel 2000 avrebbe potuto conoscere l'età precisa della ragazza africana dal momento che... non so, avete mai giocato con le figurine? Io da bambino avevo l'album Panini Espana 1982; non lo completai, ma scoprii nell'occasione che dei calciatori africani non veniva riportata la data di nascita. Non si sapeva. Nel 1982. Parliamo dei giocatori delle nazionali, non di abitanti della jungla. Può anche darsi che cinquant'anni prima Montanelli avesse accesso al certificato di nascita della sposa, ma è lecito dubitarne. Il vero discrimine in molte culture rurali (Italia compresa) è il menarca: prima si è bambini, dopo si è adulti, fine della questione. Montanelli insiste sul concetto, anche se ne parla col linguaggio di un giornalista del dopoguerra: non si abbassa a dire "mestruazioni", si limita a scrivere cose come "in Africa a quell'età si è adulte" e si aspetta che lo capiamo.
– Invece Montanelli noi non lo capiamo più. Non capiamo più quello del 2000, figurarsi quello che affittava ragazzine o sosteneva di averlo fatto. Tra i tanti che si affannano a giudicarlo ho trovato notevoli coloro che invece di adoperare il loro personale metro morale del 2020, cercano di fabbricarsene uno vintage: ovvero desiderano dimostrare quanto Montanelli fosse considerabile un maniaco sessuale anche per i costumi e i codici dell'Italia fascista. Col risultato indiretto di rivalutare i costumi e i codici di siffatta Italia. Ho letto cose come: quello che Montanelli faceva in Africa, in Italia sarebbe stato reato! Già, e questo era il motivo per cui certe cose venivano promesse ai volontari in Africa: Faccetta nera, l'avete mai sentita? Scrivono: ma il madamato era esecrato anche dal generale, dal tale politico. Sì ma forse a questo punto vi sfugge il quadro: il tale generale e il tale politico erano contrari al madamato in quanto razzisti che intendevano stabilire un regime di segregazione. È un dato acquisito dagli storici che la propaganda di regime abbia attirato i volontari con un'esca sessuale, e dopo i primi matrimoni abbia virato direzione.
– Abbiamo bisogno di mostri, così come abbiamo bisogno di eroi. La statua in effetti si potrebbe togliere (o museificare), ma poi toccherebbe individuare qualche altro feticcio e scoperchiare cose più noiose (il Risorgimento?) L'esigenza di fare di Montanelli un mostro sottopone alcuni antifascisti a una tale torsione che finiscono per riabilitare il contesto; per dimostrare che Montanelli era un mostro anche per le leggi fasciste e per i costumi fascisti, e per i fascisti che passavano e osservavano. E così dopo un lungo giro si ritorna all'archetipo degli italiani brava gente. Per quel che interessa, io non credo in una Storia di eroi, né di mostri. L'eventuale Montanelli-mela-marcia interessa molto meno del sistema che ha permesso, ispirato e tollerato le sue eventuali mostruosità.
– Se però accettiamo che Montanelli invece di un mostro sia un mitomane, c'è da riscrivere un pezzetto di Storia d'Italia magari non cospicuo ma trasversale. Alcuni dettagli di quello che sappiamo cambiano significato. Com'è noto, Montanelli dopo l'otto settembre fu arrestato dai tedeschi e tradotto in una prigione a Gallarate – dove fucilarono quasi tutti i suoi vicini di cella – e poi a San Vittore, dove tra i prigionieri conobbe un giovanissimo Mike Bongiorno e il cosiddetto generale Della Rovere – in realtà un truffatore infiltrato dai nazisti. Anche a San Vittore dopo un po' cominciarono le esecuzioni. A Fossoli finì fucilato anche il sedicente generale, su cui qualche anno dopo Montanelli scriverà un soggetto cinematografico per Rossellini (il ruolo sembrava tagliato addosso a Vittorio De Sica) e poi in un romanzo. Il generale Della Rovere è un prototipo dell'antieroe della commedia all'italiana, un imbroglione senza scrupoli che viene introdotto in una prigione per fare la spia, ma proprio grazie al suo istrionismo riesce a riscattarsi e dopo un'improvvisa alzata d'orgoglio muore da eroe come capiterà a Sordi e Gassman nella Grande Guerra. A questo punto però concedetemi il dubbio notturno: se il generale Della Rovere fosse un alter ego di Indro Montanelli? Se fosse lui l'imbroglione che teneva alto il morale dei prigionieri? Se nel romanzo Montanelli avesse esorcizzato il suo rimorso per essersi salvato la vita tradendo i compagni di prigionia, inventandosi un gemello buono che faceva tutto il contrario e moriva da eroe?
– La cancel culture (che per ora da noi è una più modesta imbratta-di-vernice-culture) si propaga attraverso prove di forza. Si individua un obiettivo e si martella finché l'obiettivo diventa indifendibile. Non ha così tanta importanza cosa abbia realmente detto o fatto l'obiettivo, quanti abusi abbia realmente commesso un Kevin Spacey o l'oggettiva incidenza del ruolo di Cristoforo Colombo nella diffusione dello schiavismo. Si individua un punto debole del nemico e si batte sullo stesso punto finché non cede. Non è che prima di Twitter si lottasse diversamente. A chi si sente sotto assedio consiglierei di dare un'occhiata ai punti deboli del nemico; di confondere le acque, magari mandando un'ambasciata a stabilire qualche punto fermo, qualche convenzione tra belligeranti (ad esempio: fino a prova contraria si è innocenti). Ai giornalisti italiani non consiglio niente perché nulla più hanno da difendere – giusto un'altra serata a raccontarsi quanto erano bravi, quanto erano furbi, nell'attico di un quartiere abbandonato. Che Montanelli li abbia presi per il culo tutta la vita: che si sia fatto trattare da maestro mentre li stordiva di frottole, è una circostanza che troverei appropriata – una volta dimostrata.
 |
| Ma pensa se davvero si è comprato la foto in un mercatino, e poi la mostrava ai colleghi appesa accanto a quella delle altre mogli. |
– Di Montanelli forse ho avuto torto a fidarmi. Dettaglio imbarazzante: 19 anni fa, appena tornato da Genova, le pale degli elicotteri ancora nelle orecchie, mentre cerco di scrivere qualcosa di leggibile per le dieci persone che mi leggono e si stanno preoccupando, scopro che IM è appena morto e gli dedico il resoconto che sto scrivendo. Non sono mai stato tanto lontano dalle sue idee, che in quel momento non mi interessano minimamente. Della sposa bambina avevo già sentito parlare e mi sembrava un dettaglio lontanissimo nel tempo, impossibile da accostare all'anziano giornalista che faceva parte del mio paesaggio mediatico sin da quando ero bambino. L'unica cosa che mi muove in quel momento è l'immagine mentale del reporter con la macchina da scrivere sulle ginocchia, il mito del reporter che scrive mentre osserva e scrive solo quello che osserva. Precisamente il monumento che gli hanno fatto. E che al di là di ogni considerazione sugli abusi coloniali, probabilmente non si merita.
– Per me Montanelli era questo: un tizio con opinioni terribili ma un certo rispetto per la verità. Questa cosa m'interessava salvare: ho un approccio storico, m'interessano le testimonianze, non i moralismi. Se avesse avuto scrupoli morali, avrebbe cercato di occultare l'episodio: meno male che non li aveva, meno male che non hai mai pensato di chiedere scusa (come se chiedere scusa servisse a qualcosa) (sul serio, se avesse chiesto scusa 50 anni dopo la statua non gliel'imbrattereste lo stesso?) Finché non ho letto questo pezzo che mi ha messo in crisi. In effetti un tizio che ha raccontato di aver incontrato Adolf Hitler perché si era attardato a pisciare in un cespuglio potrebbe anche essersi inventato una sposa bambina. Perché? Per i motivi per cui i mitomani mitomaneggiano, e che cambiano col tempo: nel 1950 per vantarsi con gli amici, nel 1976 per trollare le femministe, nel 2000 perché ormai era troppo tardi per cambiare versione – come Enrico IV. Tutto plausibile, salvo i cortigiani che continuano a recitare a soggetto dopo vent'anni che il re è morto. E così continuiamo a discutere di una ragazza che magari nemmeno esiste, magari è una foto che IM si è comprato a un mercatino di Asmara. Oppure è esistita ed è la protagonista di un abuso coloniale, ma insomma, sarebbe utile saperlo. O no? Perché ho anche sentito dire questo, in questi giorni. Che alla fine non è necessario che Montanelli abbia abusato di una ragazzina: basta che se ne sia vantato. Non è che non abbia senso: alla fine anche una bugia può servirci a capire la psicologia di chi la racconta e di chi se la fa raccontare. Ma anche quella di chi ci casca, e a volte vuole cascarci.
– Di Montanelli ho sentito dire di tutto. Mi ha colpito la difficoltà di molti a contestualizzare non già le vicende di un graduato italiano nel 1936, ma i discorsi di un giornalista italiano nel 2000. Perché non chiedeva scusa? Perché le scuse non servono mai, e comunque riteneva di non aver fatto nulla di male. Perché ha cambiato l'età, che nel 1969 era 12 anni e nel 2000 diventa 14? Perché nel 2000 (anno 5 post Marcinelle) la pedofilia era diventata uno stigma sociale; sarebbe utile tenere conto che prima non lo era; a proposito, uno storico dovrebbe trovare interessante il fatto che racconti l'infibulazione, un dettaglio che nel 1969 avrebbe considerato ributtante o forse nemmeno conosceva. In ogni caso difficilmente nel 1976 o nel 2000 avrebbe potuto conoscere l'età precisa della ragazza africana dal momento che... non so, avete mai giocato con le figurine? Io da bambino avevo l'album Panini Espana 1982; non lo completai, ma scoprii nell'occasione che dei calciatori africani non veniva riportata la data di nascita. Non si sapeva. Nel 1982. Parliamo dei giocatori delle nazionali, non di abitanti della jungla. Può anche darsi che cinquant'anni prima Montanelli avesse accesso al certificato di nascita della sposa, ma è lecito dubitarne. Il vero discrimine in molte culture rurali (Italia compresa) è il menarca: prima si è bambini, dopo si è adulti, fine della questione. Montanelli insiste sul concetto, anche se ne parla col linguaggio di un giornalista del dopoguerra: non si abbassa a dire "mestruazioni", si limita a scrivere cose come "in Africa a quell'età si è adulte" e si aspetta che lo capiamo.
– Invece Montanelli noi non lo capiamo più. Non capiamo più quello del 2000, figurarsi quello che affittava ragazzine o sosteneva di averlo fatto. Tra i tanti che si affannano a giudicarlo ho trovato notevoli coloro che invece di adoperare il loro personale metro morale del 2020, cercano di fabbricarsene uno vintage: ovvero desiderano dimostrare quanto Montanelli fosse considerabile un maniaco sessuale anche per i costumi e i codici dell'Italia fascista. Col risultato indiretto di rivalutare i costumi e i codici di siffatta Italia. Ho letto cose come: quello che Montanelli faceva in Africa, in Italia sarebbe stato reato! Già, e questo era il motivo per cui certe cose venivano promesse ai volontari in Africa: Faccetta nera, l'avete mai sentita? Scrivono: ma il madamato era esecrato anche dal generale, dal tale politico. Sì ma forse a questo punto vi sfugge il quadro: il tale generale e il tale politico erano contrari al madamato in quanto razzisti che intendevano stabilire un regime di segregazione. È un dato acquisito dagli storici che la propaganda di regime abbia attirato i volontari con un'esca sessuale, e dopo i primi matrimoni abbia virato direzione.
– Abbiamo bisogno di mostri, così come abbiamo bisogno di eroi. La statua in effetti si potrebbe togliere (o museificare), ma poi toccherebbe individuare qualche altro feticcio e scoperchiare cose più noiose (il Risorgimento?) L'esigenza di fare di Montanelli un mostro sottopone alcuni antifascisti a una tale torsione che finiscono per riabilitare il contesto; per dimostrare che Montanelli era un mostro anche per le leggi fasciste e per i costumi fascisti, e per i fascisti che passavano e osservavano. E così dopo un lungo giro si ritorna all'archetipo degli italiani brava gente. Per quel che interessa, io non credo in una Storia di eroi, né di mostri. L'eventuale Montanelli-mela-marcia interessa molto meno del sistema che ha permesso, ispirato e tollerato le sue eventuali mostruosità.
– Se però accettiamo che Montanelli invece di un mostro sia un mitomane, c'è da riscrivere un pezzetto di Storia d'Italia magari non cospicuo ma trasversale. Alcuni dettagli di quello che sappiamo cambiano significato. Com'è noto, Montanelli dopo l'otto settembre fu arrestato dai tedeschi e tradotto in una prigione a Gallarate – dove fucilarono quasi tutti i suoi vicini di cella – e poi a San Vittore, dove tra i prigionieri conobbe un giovanissimo Mike Bongiorno e il cosiddetto generale Della Rovere – in realtà un truffatore infiltrato dai nazisti. Anche a San Vittore dopo un po' cominciarono le esecuzioni. A Fossoli finì fucilato anche il sedicente generale, su cui qualche anno dopo Montanelli scriverà un soggetto cinematografico per Rossellini (il ruolo sembrava tagliato addosso a Vittorio De Sica) e poi in un romanzo. Il generale Della Rovere è un prototipo dell'antieroe della commedia all'italiana, un imbroglione senza scrupoli che viene introdotto in una prigione per fare la spia, ma proprio grazie al suo istrionismo riesce a riscattarsi e dopo un'improvvisa alzata d'orgoglio muore da eroe come capiterà a Sordi e Gassman nella Grande Guerra. A questo punto però concedetemi il dubbio notturno: se il generale Della Rovere fosse un alter ego di Indro Montanelli? Se fosse lui l'imbroglione che teneva alto il morale dei prigionieri? Se nel romanzo Montanelli avesse esorcizzato il suo rimorso per essersi salvato la vita tradendo i compagni di prigionia, inventandosi un gemello buono che faceva tutto il contrario e moriva da eroe?
– La cancel culture (che per ora da noi è una più modesta imbratta-di-vernice-culture) si propaga attraverso prove di forza. Si individua un obiettivo e si martella finché l'obiettivo diventa indifendibile. Non ha così tanta importanza cosa abbia realmente detto o fatto l'obiettivo, quanti abusi abbia realmente commesso un Kevin Spacey o l'oggettiva incidenza del ruolo di Cristoforo Colombo nella diffusione dello schiavismo. Si individua un punto debole del nemico e si batte sullo stesso punto finché non cede. Non è che prima di Twitter si lottasse diversamente. A chi si sente sotto assedio consiglierei di dare un'occhiata ai punti deboli del nemico; di confondere le acque, magari mandando un'ambasciata a stabilire qualche punto fermo, qualche convenzione tra belligeranti (ad esempio: fino a prova contraria si è innocenti). Ai giornalisti italiani non consiglio niente perché nulla più hanno da difendere – giusto un'altra serata a raccontarsi quanto erano bravi, quanto erano furbi, nell'attico di un quartiere abbandonato. Che Montanelli li abbia presi per il culo tutta la vita: che si sia fatto trattare da maestro mentre li stordiva di frottole, è una circostanza che troverei appropriata – una volta dimostrata.
Comments (6)
Le canzoni dei Beatles (#50-41)
15-07-2020, 11:29beatles, musicaPermalinkPuntate precedenti: (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#200-181), (#180-166), (#165-156), (#155-146), (#145-136), (#135-121), (#120-111), (#110-96), (#95-86), (#85-76), (#75-66), (#65-56)
PS: vi amo. No, in realtà volevo ricordare che la classifica non la faccio io: è una media di tutte le classifiche messe on line da critici specializzati. Sono loro che tifano John, io non c'entro...
50. If I Fell (Lennon-McCartney, A Hard Day's Night, 1964)
"Se mi innamorassi di te, mi prometteresti di essere fedele?" Certe canzoni parlano di sé stesse, al punto che potremmo chiamarle metacanzoni (ma forse è meglio di no). Per esempio If I Fell parla della necessità di fare le cose sul serio, ed è effettivamente la canzone più sofisticata che i Beatles avessero scritto fino a quel momento. Dunque, se da una parte c'è un'aspirante innamorata che deve capire che "l'amore è più che stringersi le mani", dall'altra ci siamo noi, che dobbiamo capire che John Lennon non è solo l'idolo delle teenager che ha appena sbancato le top10 di mezzo mondo con una canzoncina sullo stringersi le mani. John Lennon è un compositore coi controcazzi, altroché, senti che progressioni, senti che armonie. E sia noi sia la ragazzina in effetti restiamo impressionati da tanto sfoggio di argomenti, ma... non riusciamo a fidarci.
C'è qualcosa di troppo artefatto, costruito – sofisticato, appunto. Persino sul piano sintattico: già il verso introduttivo è un periodo ipotetico del secondo tipo, detto anche periodo della possibilità (ovvero sì, ci sono ancora effettive chance che io mi innamori di te). Da un punto di vista musicale, stiamo ascoltando una lunga introduzione lenta, uno stilema tipico degli standard confidenziali (ad esempio Night and Day). Così, sin dai primi istanti ("from the very start") sia la musica che la sintassi del testo ci hanno avvisato: questa non sarà la solita facile canzone d'amore in balera, qui le cose cominciano a farsi intricate. Se non proprio contorte. Eppure lo scambio proposto è lo stesso descritto basilarmente in Love Me Do: amore in cambio di fedeltà ("I'll always be true, so please love me do"). Ma ora è tutto ipotetico, come durante una contrattazione.
In inglese l'innamoramento si esprime con un verbo che implica una caduta: to fall in love (in italiano invece l'amore è qualcosa in cui si entra). Dunque innamorarsi in inglese è un lasciarsi cadere compromissorio. Lennon non può farlo senza precise garanzie. Non è proprio il modo più romantico di descrivere l'inizio di una relazione, ma Lennon aggiunge un ulteriore livello di sofisticazione: il motivo per cui non è così sicuro di lasciarsi cadere è che comunque ha già (avuto?) una partner, quindi si tratta di capire se un'eventuale seconda caduta possa comportare un'esperienza più appagante.
Ma più appagante in cosa? Non lo sapremo mai – anche e soprattutto in questo consiste l'ambiguità della canzone. Cosa significa "l'amore è più che stringersi le mani", cosa vogliono esattamente John e Paul quando chiedono di essere amati "di più": una più alta comunione delle anime? O una più lieta disposizione al sesso prematrimoniale? Non lo sapremo mai, ma su wikipedia qualcuno ha annotato che cantandola dal vivo avevano spesso difficoltà a trattenere le risate (anche la sequenza di A Hard Day's Night propone una lettura goliardica, con Ringo che diventa oggetto delle affettuose attenzioni di John). In cambio di questa non meglio precisata prova d'amore, la partner otterrà non solo le gioie dell'amore corrisposto, ma quelle più sofisticate che si ottengono soltanto quando si diventa oggetto d'invidia: "Spero che tu veda che mi piacerebbe amarti e che lei piangerà scoprendo che noi siamo in due, se m'innamorassi di te". Questa strofa finale merita uno schema, perché concentra in quattro versi una complessità sintattica che non credo di aver trovato in nessun'altra canzone pop: addirittura la frase "If I fell in love with you", quando torna alla fine (suggerendo l'idea della chiusura di un cerchio), è diventata una subordinata di quinto grado!
E va bene mr Lennon, abbiamo scoperto che lei non è solo uno scimunito che agita la frangetta sul palco in costume di scena. Lei è un musicista capace di comporre progressioni armoniche originalissime e un cantante in grado di seguire melodie complesse; inoltre è un seduttore/manipolatore, ben disposto a innamorarsi ma solo dietro precise garanzie, espresse con una retorica fin troppo forbita e intricata, che forse esprime anche un certo disagio, l'imbarazzo dei negoziatori. Beh, se le cose stanno così, forse è meglio che ti rimetti il costume, John, e che ricominci a raccontarci qualche amorazzo da balera...
49. All My Loving (Lennon-McCartney, With the Beatles, 1963).
Chiudi gli occhi e ti darò un bacio. A chi vi dice che John Lennon era un chitarrista scarso, chiedete di suonare la chitarra ritmica di All My Loving. Quattro terzine a battuta, si era mai sentita una cosa del genere? Si è mai sentita in seguito? Forse aveva in mente il banjo di sua madre, anche se alle nostre orecchie mediterranee può ricordare più facilmente un mandolino. Rimane il tratto distintivo di All My Loving, ulteriormente impreziosita dalla linea di walking bass di Paul e dai gorgheggi di quest'ultimo, armonizzati con parsimonia. All My Loving potrebbe essere il primo vero caso in cui i Quattro hanno cercato di dimostrare che sotto i caschetti c'erano dei musicisti, anche se la loro idea di virtuosismo era sensibilmente diversa dalla nostra (e non fu ripresa dai gruppi coevi): vedi l'assolo countryeggiante di George, che invece di essere il vertice tecnico del brano è quasi un momento di riposo tra due strofe che sono una tempesta di accordi e una mitraglia di note di basso.
Non era affatto semplice da suonare All My Loving, e ce ne possiamo accorgere ascoltandola nella versione live all'Hollywood Bowl, con Ringo che parte un po' troppo veloce e John e Paul che con tutta la più buona volontà non riescono a stargli dietro. E possiamo notare due cose: la prima è che non erano effettivamente i bravi musicisti che avrebbero voluto essere. Il che avrebbe potuto consigliare loro più prudenza in sede di studio, e invece no, tutto il contrario: continueranno a suonare cose più difficili di loro e al limite smetteranno di suonarle dal vivo. La loro musica non smetterà mai di essere una sfida alle loro capacità di strumentisti, un modo per sorpassare i propri limiti. La seconda cosa è che all'Hollywood Bowl malgrado gli errori a catena la canzone funziona lo stesso, come se tutta l'intelaiatura meticolosamente costruita in sala prove alla fine non fosse che un dettaglio: la vera energia della canzone pulsa più in profondità. Per quante volte abbiamo biasimato le ragazzine che ebbero il privilegio di ascoltare i Quattro dal vivo e l'hanno sprecato a urlare tutto il tempo sovrastando gli amplificatori, vale la pena di farsi venire il dubbio: forse era l'unico modo di vivere davvero l'evento, spogliando le canzoni dalla prestazione occasionale dei Quattro, coprendo i suoni imperfetti con un rumore bianco oltre il quale resiste poco più del ricordo della canzone che ci siamo già ascoltati centinaia di volte su giradischi di casa. Proprio come chiudere gli occhi e fingere di baciare quelle labbra (invece di quelle di chiunque altro).
48. Don't Let Me Down (Lennon-McCartney, lato B di Get Back!, 1969; inserita in Let It Be Naked).
Un giorno finalmente qualcuno chiese ad Arthur Janov, lo psicoterapeuta che ideò la terapia primaria: quanto c'è di vero nella scenetta tipica delle biografie di John Lennon? Cioè davvero lui si metteva in un angolo a urlare e lei lo stuzzicava a rovistare nel profondo dei suoi traumi infantili? Lui rispose: "Nonsense. Non facevamo nulla del genere". È che ai biografi piace romanzare, senz'altro, e il fatto che il bestseller di Janov si chiamasse L'urlo primordiale è una circostanza troppo ghiotta. Ma Lennon aveva già iniziato a emettere urla primordiali molto prima di conoscere Janov. Anzi è probabile che tra tanti terapeuti scelse Janov, malgrado non fosse proprio il più comodo (esercitava in un altro continente) proprio perché questa idea dell'urlo risuonava con quello che aveva già sperimentato cantando "yes I'm lonely, wanna die", o "I want you so bad it's driving me mad", e soprattutto "don't let me down", questo piccolo enorme verso intraducibile in italiano.
Non è che John stia semplicemente supplicando di non essere deluso: John vuole essere sorretto. Ne va della sua vita. Il primo "don't let me down" è una supplica, che lo sospende sull'orlo di un Fa#minore; il secondo è già una risposta, che lo riaccoglie nell'abbraccio di un confortevole Mi. Lennon era già in una fase di autoterapia: tutti e Quattro in un certo senso lo erano. Negli studi di Twickenham nel gennaio del 1969 stavano cercando di ritrovare un senso al loro stare insieme. Forse avevano aspettative troppo alte: suonare dal vivo, ma senza tradire gli standard che avevano raggiunto ad Abbey Road con le sovraincisioni. L'unico sistema era provare, provare e ancora provare. Si sarebbe rivelato ben presto un metodo troppo sfibrante per i Quattro, eppure i due brani che furono stampati in aprile su un 45 giri (Get Back! e Don't Let Me Down), sono di ottima fattura. Registrati a fine gennaio dopo che il gruppo era tornato agli studi della Apple, con l'apporto non secondario di Billy Preston, non assomigliano già più ai brani del Disco Bianco che era uscito da pochi mesi (a uccidere i Beatles fu anche questa terribile fretta). Sono brani apparentemente semplici, ma realizzati in un modo unico, da cinque musicisti che li hanno suonati e risuonati fino a dare uno stile personale a ogni nota. L'amore per gli arrangiamenti sovraincisi è stato sostituito da un gusto per la prestazione: anche se non c'è il pubblico ti sorprendi a pensare "speriamo che ce la facciano stavolta". In effetti qualche errorino verso la fine c'è, ma sono pur sempre i Beatles, e non era così facile suonare i Beatles, per i Beatles. Ho sempre trovato straordinario quel contrappunto scandito nel bridge centrale all'unicono dal basso di George e dalla chitarra di Paul, mentre John canta che è innamorato per la prima volta ("non capisci? Durerà! È un amore senza fine, un amore senza età"). Sembra di sentire una sezione di fiati. Non c'è, ma se ci fosse suonerebbe esattamente le note di George e Paul. Sembra una scelta talmente ovvia: un po' di Esercito della Salvezza a fare il verso a John che ha quasi trent'anni e insiste nel ruolo di orfano.
A Don't Let Me Down capita quello che succedeva ad altre canzoni dei primi Beatles dopo un po' che le suonavano: una specie di progressivo insorgere della parodia. Dovrebbe essere un grido d'amore assoluto, ma qua e là è lo stesso John a fomentare il sospetto che si stia facendo il verso da solo. Il vezzo melodrammatico di allungare di un quarto gratuito la prima battuta della strofa ("Nobody ever love me like she does", quell'"ever" è del tutto ridondante, come ogni avverbio) quando arriva alla strofa finale sembra autoparodico ("I guess nobody ever really done me"), addirittura due avverbi! Nel film sorridono tutti parecchio, tranne Ringo che è preoccupato di sbagliare le entrate. Paul accenna anche qualche posa in favore del cameraman; per lui più che un urlo primordiale è un ballabile lento.
Nessuno ha mai capito davvero perché Don't Let Me Down fu esclusa da Let It Be, il disco postumo che documentava quelle sessioni: tanto più che nel film omonimo la canzone viene eseguita sul tetto della Apple (in Let It Be Naked c'è una versione del concerto, ottenuta montando due take diverse). Non va presa necessariamente come una sconfessione del brano; magari aveva un senso commerciale. I Beatles avevano sempre evitato di far confluire tutto il materiale dei singoli negli album. E allo stesso tempo non si può ignorare come Don't Let Me Down sia una delle testimonianze più importanti e riuscite di quel particolare periodo della storia dei Beatles – uno dei pochi episodi che danno un senso a un'esperienza altrimenti fallimentare. Di lì a poco sarebbero tornati in uno studio coperto e si sarebbero rimessi a sovraincidere come se non ci fosse un domani (che in effetti non ci fu).
47. I Want You (She's So Heavy) (Lennon-McCartney, Abbey Road, 1969).
A proposito voi come immaginate la vostra morte? Lo so, chiedo scusa. Con tutti i problemi che ci sono al mondo, eravate venuti qui apposta a leggere qualcosa di leggero, qualcosa che per un attimo vi facesse passare di mente un paio di preoccupazioni: qualcosa sui Beatles. Cascate male: 47, Morto che Parla (giuro, non l'ho fatto apposta). Secondo alcuni I Want You e She's So Heavy sono due canzoni diverse: un blues e una coda sinfonica, che per quanto mescolate assieme (la coda è anche l'introduzione) mantengono una loro specifica identità. Mixare il blues e Beethoven era qualcosa che tutto sommato non aveva ancora fatto nessuno; dopo I Want You una generazione di virtuosi musicisti prog ci avrebbe provato, concentrandosi però sugli aspetti formali più che sull'impatto emotivo: tutto il contrario di quello che fa qui John Lennon, che il blues lo conosceva di seconda mano e di Beethoven magari giusto le sonate che gli strimpellava al piano la moglie; però era in grado di intuire quella frequenza in comune che Beethoven condivide persino con Robert Johnson: un senso di fatalità ineluttabile, un Destino che bussa alla porta e non c'è niente da fare. Voi come immaginate la vostra morte? Un giorno busserà pure alla vostra porta, chiedo scusa. E sarà solo l'inizio.
Se ammettiamo che I Want You (il blues) e She's So Heavy (Beethoven) siano due canzoni separate ma montate assieme, su Abbey Road di medley ce ne sarebbero due: quello lungo sul secondo lato che termina con La Fine, e quello breve lennoniano sul primo lato, che finisce con una lunga coda strumentale e un silenzio improvviso. Sappiamo che Lennon pensava ormai di divorziare dai tre colleghi. Sappiamo anche che avrebbe voluto invertire i lati del disco, ovvero farlo cominciare con Here Comes the Sun e chiuderlo nell'abrupto modo in cui finisce She's So Heavy, quello stacco netto che probabilmente portò qualche acquirente a riportare il disco in negozio come copia fallata. Alla fine vinse Paul, che aveva più voglia di preoccuparsi di dettagli come la scaletta del disco e il mix finale; ma soprattutto un'idea di finale molto più conciliante col pubblico: un bel carosello di chitarre, una bella frase proverbiale e cerimoniosa al punto giusto, magari ancora un ultimo scherzo per gli amici, e poi a casa: che non è mica finito il mondo, eh? Al limite saranno finiti i Beatles.
Invece per Lennon stava finendo proprio il mondo. Il confronto tra i finali dei due medley tradisce proprio questo enorme scarto esistenziale: è come se dai due lati del disco John dicesse a Paul: ma ancora ti preoccupi per i Beatles? Non capisci che sto morendo? Potrebbe essere domani come tra vent'anni, non lo sai che il tempo è un dettaglio, un'illusione? che tutto è già stato scritto, come un serpente di note che si mangia la coda, e inoltre sono passato all'eroina? E anche ammesso che sopravviva all'oppiaceo più forte sul mercato, cosa può esserci dopo di più potente, di più definitivo, di più pesante?
Il brano comincia, ironicamente, con un assaggio della coda finale, interrotto dopo dieci secondi dal riff di I Want You. Che sia un blues lo capiamo al primo ascolto, anche solo dal fatto che Lennon canti all'unisono con la chitarra, come aveva cominciato a fare durante le sessioni di Twickenham, e sembra non potersene stancare. Diventa ancora più chiaro dopo dieci battute, quando il riff viene ripetuto una quinta più in alto: è un blues lentissimo dunque, quasi fermo, ed è in minore: ma è un blues. Lennon desidera qualcosa, la desidera così forte che ne sta impazzendo, e questo è tutto. Non c'è neanche più spazio per il bestiario allegorico di Yer Blues, qui non ci sono più né immagini né metafore, la coscienza è ridotta a una voce che grida il suo desiderio nel deserto. Può essere il desiderio di una persona o di una sostanza, ma è un desiderio nudo, che non lascia scampo, al punto che non sembra più avere molta importanza se sarà alla fine soddisfatto o no: follia e morte seguiranno in ogni caso. Nei momenti in cui gli viene lasciato spazio il basso di Paul non sta fermo un attimo, un canarino in una gabbia pentatonica; alla fine di ogni strofa Billy Preston pesta l'organo come uno strumento a percussione: finché sulla soglia dei due minuti tutto tace all'improvviso per un istante brevissimo – neanche il tempo di inalare, e John sta già intonando "She's So..." Ed entra il Destino.
Entra senza bussare e non è che possa passare inosservato – ugualmente, al primo arrivo potremmo ancora non aver capito chi è davvero. Siamo distratti dai cori ("heavy, heavy, heavy") e dall'assolo di Preston che non sa di essere stato convocato a un funerale: per lui è una passerella e non se la fa sfuggire (il suo assolo si disperde nel riff come uno schizzo di qualcosa in un liquido più scuro). Così farà la morte con molti di noi: la prima volta la scambieremo per un male passeggero, o un'avventura folle ma con una via di uscita. Niente di così terribile. Dura venti secondi, e poi riparte il blues, che a dire il vero non è più lo stesso blues: fu registrato in un secondo momento, anche se poi quasi tutti gli strumenti furono doppiati, il che fa sembrare la versione finale molto più coesa di quanto non sia. È una I Want You 2, una specie di cover vagamente caraibica, alla maniera di Black Magic Woman dei Fleetwood Mac. Anzi, per essere più precisi: sarà Santana nel 1970 a immortalare Black Magic Woman suonandola sul ritmo vagamente caraibico di questa porzione di I Want You. Lennon continua a ribadire il suo desiderio mortale ma troviamo meno facile credergli: magari è ancora sotto botta. Segue un ulteriore scambio tra I Want You2 e She's So Heavy che confesso di trovare abbastanza ridondante, malgrado McCartney e Preston ce la mettano tutta per non annoiare l'ascoltatore: così che siamo già a 4:30 quando Lennon lancia il suo grido primordiale e fa entrare il Destino per l'ultima volta (tra le altre cose, I Want You – She's So Heavy è anche una funebre parodia di Hey Jude: prendi una canzone triste e fanne un requiem).
È abbastanza ironico che la parte beethoveniana della canzone sia più semplice della parte blues: e allo stesso tempo è giusto così, Lennon non ricorre a Beethoven per mitigare un complesso di inferiorità musicale: Lennon cerca nel romanticismo qualcosa di molto più semplice e mortale. Il serpente di note che si mangia la coda è formato da una breve scala ascendente di quattro semiminime che appena sembrano essersi assestate su un plateau, cascano subito in basso con una terzina (dal sapore vagamente blues); cominciano ad annaspare con un'altra terzina e finalmente ritrovano la via per risalire verso l'alto: ma a questo punto siamo di nuovo sullo stesso plateau, stiamo di nuovo per ricadere con la stessa terzina, stiamo di nuovo annaspando: è un loop, non se ne esce, non se ne può più uscire. Dopo qualche ciclo non ricordiamo neanche più qual era l'inizio e quale la fine: è tutto perfettamente circolare e autoconseguente e noi ne siamo prigionieri. Ci alziamo, prendiamo fiato, ricadiamo, annaspiamo, ci rialziamo. Sarà sempre così: desiderio, parziale appagamento, delusione, angoscia, desiderio. Possiamo cambiare donna e cambiare sostanza, ma non possiamo cambiare il nostro destino: siamo nati desiderando e il Desiderio ci farà girare finché non sarà stanco di noi: finché senza preavviso non ci saremo più e non avremo nemmeno il tempo per accorgercene, sarà uno stacco netto, ecco, John Lennon la sua morte la immaginava così. Sì, lo so, voi volevate soltanto riascoltare una vecchia canzone, mi dispiace. Non succederà più, prometto. Non si poteva più fare niente dopo I Want You. John lo aveva fatto presente, ma Paul non capiva e poi vabbe', chissenefrega, divertitevi pure coi vostri dischi di canzoncine, mentre io muoio.
46. Drive My Car (Lennon-McCartney, Rubber Soul, 1965)
Ho detto a questa ragazza che avevo buone prospettive, lei mi ha risposto, seh vabbe' lo sappiamo. È tutto ok quando lavori per due noccioline, ma io ti farò vedere cos'è il successo. Baby, puoi guidarmi la macchina, lo sai che io sarò una star. Se vi chiedessero di spiegare l'ottimismo della Swinging London con una canzone sola, avreste qualche dubbio? Beep Beep, Beep Beep, Yeah! Philip Norman racconta come Paul in quel periodo andasse in giro travestito, baffi finti e cose del genere, giusto per il gusto di stare in mezzo alla gente. Dopo averlo letto diventa impossibile non immaginare che Drive My Car parli proprio di questo: Paul che si diverte ad attaccar bottone con una ragazza che ha Grandi Aspettative: lei sarà una star del grande schermo, tu nel frattempo puoi farle da chaffeur. Non c'è neanche bisogno di decifrare il doppio senso – che comunque c'è, autorizzato dallo stesso Paul ("Drive my car era un vecchio eufemismo blues per il sesso"). La ragazza ce la può fare, in fondo è sfrontata il giusto, probabilmente ha anche già riconosciuto chi è quel tizio con i baffi finti che può davvero guidarla al successo.
Con Drive My Car Paul sta giocando a nascondino col suo personaggio pubblico. La protagonista sta confessando i suoi sogni di gloria all'unico ventenne a Londra che non ne ha più, li ha realizzati tutti – cos'altro poteva chiedere alla fortuna Paul McCartney, nel 1965? Magari giusto una ragazza ingenua e intraprendente da rimorchiare al parco, un pomeriggio da persona normale a fare sogni a occhi aperti. Anche da un punto di vista musicale, Drive My Car rappresenta i Beatles formato rock al massimo della forma: sembra tutto semplice ma non c'è niente di banale. Paul, che per una volta ha una storia coerente da raccontare (con tanto di battuta finale!), opta per la più classica alternanza di strofa e ritornello. Per la strofa rispolvera il suo timbro littlerichardiano: una scelta singolare visto che sta dando la parola a una ragazza: ma serve a ribadirne la sfrontatezza: e soprattutto a marcare il contrasto col momento in cui da sfrontata si fa ammiccante, e le seconde voci si dispongono un accordo di settima minore ("but you can do something in between"). Il riff di chitarra raddoppiato dal basso è un'idea di George, un prestito riconosciuto da Respect di Otis Redding.
Drive My Car è in effetti uno dei rari casi in tutto il catalogo Beatles in cui una donna parla. Il caso è ancora più eccezionale dal momento che parla per tutto il ritornello, ed è suo lo stesso titolo della canzone: non succederà più, mi pare, fino a Let It Be. Molti titoli dei primi Beatles erano richieste d'amore da declinare in modo più o meno fisico: Love Me Do, Please Please Me, Hold Me Tight, I Want to Hold Your Hand, eccetera. Ma il più provocatorio di tutti Paul lo mette in bocca a questa ragazza che forse è meno ingenua di quanto appare: puoi guidarmi la macchina, baby. E forse ti amerò. Chi sta guidando davvero, dei due?
45. I Feel Fine (Lennon-McCartney, singolo, 1964)
I'm so glad that she's my little girl. Non solo i Beatles dei primi due anni cantavano esclusivamente canzoni d'amore, ma con qualche eccezione (cover, per lo più) si tratta di amore corrisposto. Io la amo, lei ti ama, tu mi fai piacere, io ti faccio piacere, stringiamoci le mani, abbracciamoci forte, adesso seriamente non è fantastico? Mettiamo che possiate scegliere di assumere una droga in questo istante: preferireste un oppiaceo, un vasodilatatore, un allucinogeno, o una sorsata della dopamina di quando eravate adolescenti e lei vi amava e voi l'amavate e quel giorno tutti hanno scoperto che stavate assieme? Purtroppo non è in commercio, mi dispiace (ma potete sempre ascoltare i Beatles).
L'effetto dopante è amplificato da una condizione che Lennon e McCartney avevano scoperto verso la fine del 1962, e che ne ha decretato il successo: gli osservatori esterni. Essi ci guardano (If I Fell), a volte ci aiutano (She Loves You), sempre ci invidiano. Non ci fossero loro che ci spìano non ci sarebbe neanche tutto questo gusto ad appartarsi. Questo può spiegare come mai il ritornello di I Feel Fine reciti: "I'm in love with her", che sintatticamente non ha molto senso, perché viene dopo una strofa ("Baby says she's fine, you know, she tells me all the time, you know") che termina con un "she said so", "lei ha detto così". A questo punto ci aspettiamo che il cantante riporti ancora un discorso diretto della partner, e invece dopo quel "she said so" Lennon parla in prima persona: "I'm in love with her and I feel fine". Ok, da un punto di vista sintattico "I'm in love with him" avrebbe avuto più senso, ma si può comprendere la ritrosia di Lennon a cantare un ritornello del genere in un singolo del 1964 (solo Ringo aveva la flemma per gridare "I'm talking 'bout boys now"!)
Un'altra possibilità era passare al discorso indiretto e cantare "She's in love with me and I feel fine": che è poi quello che fa Lennon a fine canzone. Ma all'inizio no, perché? Perché ha bisogno di un interlocutore. "I'm in love with her" aggiunge questo alla canzone: la presenza di un confidente, muto, che non deve far altro che ascoltare l'estasiata testimonianza di John: oh, sono così felice, lei dice a tutto il mondo che le compro un sacco di cose, sai, le compro gli anelli di diamanti, lei dice proprio così. Che senso ha avere una ragazza felice di stare con te se non lo stai raccontando a qualcuno?
I Feel Fine viene in soccorso del musicologo che ci tiene a dimostrare come l'evoluzione di Lennon/McCartney proceda in modo progressivo, senza salti bruschi o crisi significative: se la strofa è molto innovativa e anticipa gli sviluppi più rock del biennio '65-'66, il bridge è ancora saldamente ancorato in quella poetica yeh-yeh che aveva regalato ai Beatles quattro singoli al primo posto: I Feel Fine fu il quinto, il che sorprese positivamente lo stesso Lennon, che pensava di aver rischiato più del solito. Sua fu l'idea di cominciare il brano con un feedback, il 'fischio' di un amplificatore troppo vicino a un microfono, che oggi passa quasi inosservato ma ai tempi era una maleducazione inconcepibile in un prodotto inciso, al punto che George Martin dovette farlo passare per un errore. "Prima di Hendrix, prima degli Who, prima di chiunque. Il primo feedback su qualsiasi disco". È la prima incursione dei Beatles di studio nel mondo dei rumori, un'anticipazione delle follie di là da venire: ma è anche un ritorno alle radici grezze, al sound cacofonico del Cavern Club o di Amburgo; "Tutti giocavano col feedback nei concerti, e la roba alla Jimi Hendrix succedeva già da un pezzo. In effetti tutta quella roba punk di adesso è solamente quello che [ai nostri tempi] la gente faceva nei club". La novità più macroscopica resta il riff della strofa, suonato all'unisono dalle chitarre di George e di John (che non riusciva però a cantarci sopra). È un esercizio pentatonico ripetuto su tre accordi diversi: con ogni probabilità il riff più complesso che si poteva sentire in un pezzo rock alla radio nel 1964 – anche perché i rivali stavano piuttosto cercando di semplificare, il riff di You Really Got Me dei Kinks giocava su due note, quello di Satisfaction su tre o quattro, si era insomma aperta la caccia al riff più basilare e maestoso, da suonare magari roteando teatralmente il braccio destro come Pete Townshend. Invece a fine 1964 Lennon sembrava avere una fobia del vuoto: riempiva le battute di note proprio come la voce narrante riempiva la frase di intercalari (tutti quegli "you know", apparentemente inutili, ma che servono a ribadire la presenza di un testimone). In tutta quest'ansia di non lasciare spazio al silenzio, col senno del poi, possiamo leggere già quell'irrequietezza esistenziale che comincia ad affiorare nei solchi più interessanti di Beatles for Sale: ma dobbiamo proprio? Non possiamo semplicemente esser felici perché quei due stanno assieme e sono felici? Ne avremo, di tempo, per le canzoni tristi. I Feel Fine è la canzone più felice di John Lennon, ed è anche l'ultima sua che ascolteremo su un lato A di un 45 giri per più di due anni (se si eccettuano i 45 giri estratti dagli album). Non è una coincidenza.
44. Get Back (Lennon-McCartney, singolo, 1969; poi in Let It Be, 1970).
Retrospettivamente, Get Back non fu una grande idea. Non il brano in sé (che schizzò immediatamente al primo posto della top10 britannica e ci restò per sei settimane), ma proprio il titolo. I Beatles avevano sempre creduto nell'importanza di un buon titolo, Paul soprattutto ("se qualcuno ti chiede "Qual è la tua nuova canzone" e tu hai un titolo interessante, sei già a metà strada"). A Hard Day's Night era un titolo buffo e intrigante. Beatles For Sale era autoparodico. Help!, Rubber Soul, Revolver, Sgt Pepper's..., Magical Mystery Tour: tutti titoli che attirano l'attenzione, destano curiosità. Get Back spiegava quello che volevano fare i Quattro all'inizio del 1969, in modo semplice. Forse troppo semplice. Anche un po' brutale. "Torna indietro" non è mai un buon messaggio. Ti si ritorce contro.
Proprio nell'anno della contestazione, nell'ambiente rock tirava un'aria di ritorno all'ordine. Già nel 1968 i Rolling Stones dopo la sbornia psicadelica erano tornati al solido blues di Beggars Banquet. Bob Dylan già a fine 1967 aveva già sorpreso tutti con un breve disco enigmatico e spogliato all'osso, John Wesley Harding. Poi in estate era uscito il disco del gruppo che accompagnava Dylan, e che ora si faceva chiamare semplicemente Band, Music From the Big Pink, e aveva sorpreso pubblico e addetti ai lavori per quell'atmosfera di semplicità, di musica fatta in casa con amore e senza troppi fronzoli. Eric Clapton ascoltandolo aveva deciso di chiudere coi Cream. La "Big Pink" era la casa di Woodstock nella cui cantina Dylan e la Band si erano ritirati a suonare musica per il gusto di farlo. George Harrison era andato a trovarli a Woodstock e si era lasciato conquistare dall'atmosfera informale, dalla serenità che il gruppo sprigionava suonando per il gusto di suonare. Potevano i Beatles fare lo stesso? Ma senza smettere di essere i Beatles, cioè il gruppo da cui ci si aspettava un singolo di successo ogni quattro mesi, un album capolavoro entro l'estate? Ci potevano almeno provare.
 Quando in estate uscì il primo disco (abusivo) con le canzoni registrate da Dylan e dalla Band in cantina, tutti poterono misurare la somiglianza con Get Back, registrata in gennaio ma pubblicata in aprile: canzoni semplici, divertenti da suonare (in particolare si diverte Lennon con la chitarra solista), testi enigmatici ma spesso probabilmente inventati davanti al microfono. Get Back è un classico esempio di metacanzone: non dice soltanto "torna indietro" – anzi lo dice in modo abbastanza confuso – ma rappresenta un ritorno indietro, a un passato ormai mitico in cui i Quattro improvvisavano rock'n'roll su due accordi. Il brano piacque subito, anche perché paradossalmente proponeva un'idea di suono beatle già molto diversa da quella del Disco Bianco che era uscito pochi mesi prima: ancor più che la direzione, al pubblico interessava il movimento. Si sarebbe in seguito scoperto che "tornare indietro" per i Beatles era un'opzione ancora più faticosa di andare avanti. Per ottenere quel suono fatto in casa che suonasse naturale i Quattro dovettero riprovarla fino allo sfinimento di volte (oltre a farsi dare una mano da Billy Preston all'organo).
Quando in estate uscì il primo disco (abusivo) con le canzoni registrate da Dylan e dalla Band in cantina, tutti poterono misurare la somiglianza con Get Back, registrata in gennaio ma pubblicata in aprile: canzoni semplici, divertenti da suonare (in particolare si diverte Lennon con la chitarra solista), testi enigmatici ma spesso probabilmente inventati davanti al microfono. Get Back è un classico esempio di metacanzone: non dice soltanto "torna indietro" – anzi lo dice in modo abbastanza confuso – ma rappresenta un ritorno indietro, a un passato ormai mitico in cui i Quattro improvvisavano rock'n'roll su due accordi. Il brano piacque subito, anche perché paradossalmente proponeva un'idea di suono beatle già molto diversa da quella del Disco Bianco che era uscito pochi mesi prima: ancor più che la direzione, al pubblico interessava il movimento. Si sarebbe in seguito scoperto che "tornare indietro" per i Beatles era un'opzione ancora più faticosa di andare avanti. Per ottenere quel suono fatto in casa che suonasse naturale i Quattro dovettero riprovarla fino allo sfinimento di volte (oltre a farsi dare una mano da Billy Preston all'organo).
Persino improvvisare quattro versi al microfono era meno semplice del previsto. Ogni parola era un'insidia. In una delle prime versioni c'era un'intera strofa dedicata agli immigrati, in particolare ai "pakistani" perché Paul aveva letto della loro drammatica condizione negli slums britannici e soprattutto gli piaceva il suono della parola. A quel punto il ritornello sarebbe diventato una satira del nazionalismo britannico ("Tornatevene da dove siete venuti"). Molto progressista per un gruppo che aveva sempre dribblato il coinvolgimento politico – e anche molto rischioso: l'ironia è un procedimento retorico che richiede la complicità del pubblico. Per ottenere questa complicità serve almeno un segnale (un occhiolino, un emoticon) che le radio di tutto il mondo non avrebbero potuto trasmettere. Quel Get back rischiava di suonare indistinguibile dagli slogan di cui si prendeva gioco e così i Quattro decisero, saggiamente, di toglierlo e rifugiarsi nel nonsense, nelle libere associazioni dell'inconscio. Ma l'inconscio è una brutta bestia, ne abbiamo già parlato.
"Credo che ci fosse qualche allusione a Yoko, sai Tornatene al luogo a cui appartenevi. Ogni volta che cantava quel verso in studio, dava un'occhiata a Yoko. Probabilmente dirà che sono un paranoico". Beh in effetti, sì, signor Lennon, la paranoia va messa in conto, specie quando si fa uso di stupefacenti. E allo stesso tempo, davvero, come si fa a escludere che Paul abbia guardato anche una volta sola Yoko Ono, mentre intonava Get Back? Giusto il tempo di uno sguardo importuno: vi è mai capitato di fissare la persona che non avreste dovuto fissare, nel momento meno indicato in assoluto? Potrebbe essere successo anche a Paul. Yoko veniva da New York, e prima ancora veniva dal Giappone; la canzone è proprio un invito a tornarsene a casa; un messaggio pericoloso. Mentre canto il ritornello forse è meglio evitare di guardare la straniera in faccia, a proposito, dov'è? Ops, troppo tardi, l'ho guardata. Vabbe', facciamo finta di niente.
Il solito problema delle parole delle canzoni. Meno senso hanno, più senso possono trattenere.
Paul s'inventa un personaggio, "Jojo", doppio già nel nome (Jojo non suona come Yoyo, ma neanche troppo diverso), che pensa di essere solitario ma sa che non può durare (chi era fino a pochi mesi prima lo scapolo d'oro dei Beatles?) Jojo decide di lasciare la sua casa che, di tutti i posti al mondo, è proprio a Tucson, in Arizona: un luogo proverbiale per tutti gli spettatori di film western, ma anche la città in cui aveva vissuto la famiglia di Linda Eastman. Jojo è "metà uomo, metà donna, molto ambiguo" spiega Paul nella sua autobiografia, e forse è un lapsus interessante, perché fino a quel momento era lecito pensare che fosse l'altro personaggio, "sweet Loretta Martin", a "credere di essere una donna mentre era un altro uomo". Loretta Martin ha le stesse iniziali di Linda McCartney. L'accusa di essere una donna-uomo veniva mossa talvolta alle spalle di Yoko Ono, non solo perché la sua femminilità non si inquadrava negli schemi di allora, ma per spiegare il fatto che dopo averla incontrata Lennon si fosse parzialmente femminilizzato. Insomma, Get Back nella sua versione finale non parla di nulla: ma se parlasse, forse avrebbe qualcosa da dire sulle rispettive partner degli autori. Vengono da lontano e stanno per lacerare definitivamente il gruppo. Non potrebbero tornarsene indietro, al luogo in cui appartengono? Non è che Paul volesse dire questo, anzi: Paul voleva dire tutto tranne questo. Ma sono proprio quelli i momenti in cui ti tradisci.
Col senno del poi, quel titolo era tremendo. Se è vero che azzeccando un buon titolo sei a metà strada, se lo sbagli non recuperi più. È facilissimo offendere qualcuno cantando Get Back. Ci sarà sempre qualcuno che si sente fuori posto e che si sentirà offeso. E siccome ci sentiamo tutti un po' fuori posto, e stiamo aspettando tutti un'occasione per offenderci...
43. We Can Work It Out (Lennon-McCartney, singolo, 1965).
Try to see it in my way... Potrebbe essere la canzone centrale di tutta la storia dei Beatles: il perno, il fulcro, il momento in cui Paul sorpassa John, l'inizio della fine, la fine dell'inizio. A decidere fu il pubblico, comunque. Lennon non credeva in We Can Work It Out; pensava che la sua Day Tripper avrebbe funzionato meglio come singolo, e riuscì a ottenere un compromesso: il 45 giri uscì senza stabilire una gerarchia tra "lato A" e "lato B", le due canzoni avevano pari importanza. Insomma tra il rock-blues di Day Tripper e l'esperimento pop-valzer di We Can Work It Out avrebbe scelto il pubblico, in particolare quello radiofonico. Il pubblico scelse We Can Work It Out.
Non era così scontato. Paradossalmente quello che faceva la differenza nel brano di Paul era il pezzo scritto da John: l'inserto vagamente melodrammatico, "Life is very short", che culminava con un inedito passaggio in tre quarti (soluzione suggerita da George Harrison): qualcosa che in radio non si era mai sentito e che, chi l'avrebbe detto mai, gli ascoltatori inglesi avevano voglia di sentire.
In sostanza John si era sconfitto da solo: il John più rock'n'rolleggiante era stato eclissato dal John sperimentale, quello più interessato ad assecondare l'eclettismo di Paul (anche solo per sabotarlo dall'interno). Se Day Tripper avesse vinto lo scontro, la storia dei Beatles sarebbe stata sensibilmente diversa. Se il grande pubblico avesse mostrato nel '65 di preferire un sano rock'n'roll, i Beatles non avrebbero perso troppo tempo a procurarglielo, concedendo meno spazio alle sperimentazioni e alle esplorazioni che alla lunga alienarono soprattutto Paul dal resto del gruppo. Può anche darsi che i Beatles sarebbero durati di più (e i Rolling Stones avrebbero avuto meno spazio). Ma nel '65 la gente preferiva ascoltare We Can Work It Out, un brano sghembo, non molto ballabile, neanche così cantabile, ma che doveva suonare come la promessa di cose favolose di là da venire. Una canzone che senza farlo apposta contiene la formula dei Beatles dal 1966 alla fine: il 60% è di Paul, che canta tutta la strofa e cerca di salvare un rapporto complicato con un atteggiamento paternalistico che può indisporre; il 35% è di John che canta tutto il bridge e la butta sull'esistenziale; il 5% è di George che suggerisce il breve passo di valzer. Possiamo tenere i piedi in tutte le staffe, canta Paul (ma la vita è troppo corta, obietta John). Possiamo spiegarci tra di noi, possiamo andare avanti, possiamo farcela. Ma il valzer non è d'accordo, e ha l'ultima parola.
42. With a Little Help From My Friends (Lennon-McCartney, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band).
Hai bisogno di qualcuno? Potrebbe essere chiunque? Sgt Pepper è uno spettacolo così variopinto che ci metti un po' a notare gli elementi che mancano. Anche quelli un tempo fondamentali. Uno è il rock'n'roll, annunciato con grandi fanfare nel primo minuto del disco, ma poi eclissato proprio dalle fanfare. Un altro è l'amore. Ce n'è proprio poco, anche volendo considerare l'attrazione nei confronti di Lovely Rita qualcosa di più di un'infatuazione. Considerato che fino a due anni prima Lennon e McCartney scrivevano esclusivamente d'amore, è un dato impressionante che l'unica vera canzone di amore corrisposto sia Getting Better, non a caso quella che suona più "vecchi Beatles". Anche With a Little Help indugia in un suono che rappresenta un passo indietro persino rispetto a Revolver, ed è a suo modo una canzone in cui dell'amore si sente la necessità, anche se non c'è più e va ritrovato (con un piccolo aiuto degli amici). E forse arriva nell'ultimo verso, molto ambiguo. ("Cosa hai visto quando si è spenta la luce? Non posso dirtelo, ma so che è mio": una di quelle strizzatine d'occhio di Paul che lasciano perplessi).
Che With a Little Help avesse le qualità per diventare un classico, l'avrebbe dimostrato di lì a poco Joe Cocker. In Sgt Pepper invece è quasi mortificata da un arrangiamento non semplice, ma semplicista, che si sforza di far passare un solido brano r'n'b per una canzoncina che un artista amatoriale potrebbe cantare su un gazebo, in un umido parco di una non meglio precisata località dell'Inghilterra settentrionale. Si chiama Billy Shears, veste un buffo costume fucsia, ma ovviamente è Ringo – alla fine forse l'idea di fare un disco come Sgt Pepper, un alternarsi di numeri di varietà, non è che l'estensione di quella pratica per cui, dal 1964 in poi, i brani cantati da Ringo erano concepiti sempre più come dei siparietti. Di tutti e Quattro, Ringo era la presenza più teatrale, non solo nei film: più personaggio che musicista (il musicista fa in tempo a regalare un breve intermezzo di tom-tom che cinquant'anni dopo strappa ancora l'applauso). La necessità di imbastire un pezzo 'facile' per le sue limitate capacità vocali viene qui portata al grottesco, e i Beatles forse per la prima volta intonano una parodia di loro stessi. With a Little Help è l'idea dei Beatles che hanno molti che credono di detestarli: una canzoncina semplice tutta coretti e sentimenti stereotipati, con un ritmo martellante che ne ingessa le potenzialità soul. Di fianco a loro, sulla copertina di Sgt Pepper, i Quattro avevano voluto i quattro manichini di cera che li ritraevano nel museo di Madame Tussaud; With a Little Help è l'equivalente musicale di quel contrasto fotografico: dopo la variopinta fanfara che dà il titolo al disco, ecco un brano che ci riporta al passato recente, quando eravamo quattro manichini produttori di canzoni d'amore in serie.
41. Taxman (Harrison, Revolver, 1966).
And you're working for no one but me. Taxman è la prima canzone dei Beatles a giocare con un riferimento pop (se davvero, come sembra difficile negare, George avesse in mente la sigla del telefilm di Batman che però nel Regno Unito non era ancora arrivato). È la prima canzone a nominare due uomini politici – primo ministro e capo dell'opposizione, mica fessi questi Beatles – e a contenere una rivendicazione politica, più rancorosa che documentata, ma comunque anni luce più concreta di qualsiasi cosa avessero cantato fino a quel momento: ehi, l'uomo delle tasse ci prende il 95% degli utili, non è un iperbole, è proprio così.
È la prima canzone in cui i soldi non sono un elemento retorico, una cosa che serve a comprare tutto ma-non-l'amore, ma una realtà fisica, misurabile e volatile: troppo volatile, povero George. È la prima canzone di Revolver, il disco che cambia davvero tutto proprio quando tutto sembrava già molto cambiato. È la prima canzone in cui George Harrison fa davvero la differenza, mostrando uno stile suo a cui i colleghi per la prima volta scelgono di adattarsi, al punto che la chitarra solista di Paul se ne va di sua spontanea iniziativa alla ricerca di una specie di raga indiano.
Taxman insomma è la prima canzone in tanti elenchi... tutti piuttosto brevi. I Beatles non abbonderanno mai coi riferimenti pop; non nomineranno più uomini politici, non aderiranno a nessuna piattaforma politica e non avanzeranno più nessuna rivendicazione fiscale. Lo stesso George, dopo l'exploit di Revolver (tre brani su quattordici, record assoluto), continuerà a faticare molto per imporre le sue canzoni. Taxman insomma contiene molte più possibilità di quelle che i Beatles decisero di praticare davvero.
In effetti è un brano che corre il rischio di risultare antipatico – non ci sono molti altri episodi della storia del rock in cui un milionario scelga di denunciare non i problemi del mondo, ma i propri problemi col fisco. A sua discolpa, George era molto più giovane e ingenuo di quanto credeva di essere, e la fiscalità britannica molto iniqua con questi quattro ex proletari rei di avere scavalcato un'intera rampa della scala sociale. Il modo migliore di apprezzare Taxman credo sia quello di fingersi un ascoltatore del 1966, privo di pregiudizio, e rimanere completamente allibito: cosa sta succedendo? Sembrano colpi di tosse, il disco è difettoso? Perché insistono a suonare un solo accordo solo? Ma è George che canta, sul serio? E la chitarra, mio dio, ma che sta succedendo? Sono davvero i Beatles questi? Roba da matti, non c'è più religione.
PS: vi amo. No, in realtà volevo ricordare che la classifica non la faccio io: è una media di tutte le classifiche messe on line da critici specializzati. Sono loro che tifano John, io non c'entro...
50. If I Fell (Lennon-McCartney, A Hard Day's Night, 1964)
"Se mi innamorassi di te, mi prometteresti di essere fedele?" Certe canzoni parlano di sé stesse, al punto che potremmo chiamarle metacanzoni (ma forse è meglio di no). Per esempio If I Fell parla della necessità di fare le cose sul serio, ed è effettivamente la canzone più sofisticata che i Beatles avessero scritto fino a quel momento. Dunque, se da una parte c'è un'aspirante innamorata che deve capire che "l'amore è più che stringersi le mani", dall'altra ci siamo noi, che dobbiamo capire che John Lennon non è solo l'idolo delle teenager che ha appena sbancato le top10 di mezzo mondo con una canzoncina sullo stringersi le mani. John Lennon è un compositore coi controcazzi, altroché, senti che progressioni, senti che armonie. E sia noi sia la ragazzina in effetti restiamo impressionati da tanto sfoggio di argomenti, ma... non riusciamo a fidarci.
C'è qualcosa di troppo artefatto, costruito – sofisticato, appunto. Persino sul piano sintattico: già il verso introduttivo è un periodo ipotetico del secondo tipo, detto anche periodo della possibilità (ovvero sì, ci sono ancora effettive chance che io mi innamori di te). Da un punto di vista musicale, stiamo ascoltando una lunga introduzione lenta, uno stilema tipico degli standard confidenziali (ad esempio Night and Day). Così, sin dai primi istanti ("from the very start") sia la musica che la sintassi del testo ci hanno avvisato: questa non sarà la solita facile canzone d'amore in balera, qui le cose cominciano a farsi intricate. Se non proprio contorte. Eppure lo scambio proposto è lo stesso descritto basilarmente in Love Me Do: amore in cambio di fedeltà ("I'll always be true, so please love me do"). Ma ora è tutto ipotetico, come durante una contrattazione.
In inglese l'innamoramento si esprime con un verbo che implica una caduta: to fall in love (in italiano invece l'amore è qualcosa in cui si entra). Dunque innamorarsi in inglese è un lasciarsi cadere compromissorio. Lennon non può farlo senza precise garanzie. Non è proprio il modo più romantico di descrivere l'inizio di una relazione, ma Lennon aggiunge un ulteriore livello di sofisticazione: il motivo per cui non è così sicuro di lasciarsi cadere è che comunque ha già (avuto?) una partner, quindi si tratta di capire se un'eventuale seconda caduta possa comportare un'esperienza più appagante.
Ma più appagante in cosa? Non lo sapremo mai – anche e soprattutto in questo consiste l'ambiguità della canzone. Cosa significa "l'amore è più che stringersi le mani", cosa vogliono esattamente John e Paul quando chiedono di essere amati "di più": una più alta comunione delle anime? O una più lieta disposizione al sesso prematrimoniale? Non lo sapremo mai, ma su wikipedia qualcuno ha annotato che cantandola dal vivo avevano spesso difficoltà a trattenere le risate (anche la sequenza di A Hard Day's Night propone una lettura goliardica, con Ringo che diventa oggetto delle affettuose attenzioni di John). In cambio di questa non meglio precisata prova d'amore, la partner otterrà non solo le gioie dell'amore corrisposto, ma quelle più sofisticate che si ottengono soltanto quando si diventa oggetto d'invidia: "Spero che tu veda che mi piacerebbe amarti e che lei piangerà scoprendo che noi siamo in due, se m'innamorassi di te". Questa strofa finale merita uno schema, perché concentra in quattro versi una complessità sintattica che non credo di aver trovato in nessun'altra canzone pop: addirittura la frase "If I fell in love with you", quando torna alla fine (suggerendo l'idea della chiusura di un cerchio), è diventata una subordinata di quinto grado!
E va bene mr Lennon, abbiamo scoperto che lei non è solo uno scimunito che agita la frangetta sul palco in costume di scena. Lei è un musicista capace di comporre progressioni armoniche originalissime e un cantante in grado di seguire melodie complesse; inoltre è un seduttore/manipolatore, ben disposto a innamorarsi ma solo dietro precise garanzie, espresse con una retorica fin troppo forbita e intricata, che forse esprime anche un certo disagio, l'imbarazzo dei negoziatori. Beh, se le cose stanno così, forse è meglio che ti rimetti il costume, John, e che ricominci a raccontarci qualche amorazzo da balera...
49. All My Loving (Lennon-McCartney, With the Beatles, 1963).
Chiudi gli occhi e ti darò un bacio. A chi vi dice che John Lennon era un chitarrista scarso, chiedete di suonare la chitarra ritmica di All My Loving. Quattro terzine a battuta, si era mai sentita una cosa del genere? Si è mai sentita in seguito? Forse aveva in mente il banjo di sua madre, anche se alle nostre orecchie mediterranee può ricordare più facilmente un mandolino. Rimane il tratto distintivo di All My Loving, ulteriormente impreziosita dalla linea di walking bass di Paul e dai gorgheggi di quest'ultimo, armonizzati con parsimonia. All My Loving potrebbe essere il primo vero caso in cui i Quattro hanno cercato di dimostrare che sotto i caschetti c'erano dei musicisti, anche se la loro idea di virtuosismo era sensibilmente diversa dalla nostra (e non fu ripresa dai gruppi coevi): vedi l'assolo countryeggiante di George, che invece di essere il vertice tecnico del brano è quasi un momento di riposo tra due strofe che sono una tempesta di accordi e una mitraglia di note di basso.
Non era affatto semplice da suonare All My Loving, e ce ne possiamo accorgere ascoltandola nella versione live all'Hollywood Bowl, con Ringo che parte un po' troppo veloce e John e Paul che con tutta la più buona volontà non riescono a stargli dietro. E possiamo notare due cose: la prima è che non erano effettivamente i bravi musicisti che avrebbero voluto essere. Il che avrebbe potuto consigliare loro più prudenza in sede di studio, e invece no, tutto il contrario: continueranno a suonare cose più difficili di loro e al limite smetteranno di suonarle dal vivo. La loro musica non smetterà mai di essere una sfida alle loro capacità di strumentisti, un modo per sorpassare i propri limiti. La seconda cosa è che all'Hollywood Bowl malgrado gli errori a catena la canzone funziona lo stesso, come se tutta l'intelaiatura meticolosamente costruita in sala prove alla fine non fosse che un dettaglio: la vera energia della canzone pulsa più in profondità. Per quante volte abbiamo biasimato le ragazzine che ebbero il privilegio di ascoltare i Quattro dal vivo e l'hanno sprecato a urlare tutto il tempo sovrastando gli amplificatori, vale la pena di farsi venire il dubbio: forse era l'unico modo di vivere davvero l'evento, spogliando le canzoni dalla prestazione occasionale dei Quattro, coprendo i suoni imperfetti con un rumore bianco oltre il quale resiste poco più del ricordo della canzone che ci siamo già ascoltati centinaia di volte su giradischi di casa. Proprio come chiudere gli occhi e fingere di baciare quelle labbra (invece di quelle di chiunque altro).
48. Don't Let Me Down (Lennon-McCartney, lato B di Get Back!, 1969; inserita in Let It Be Naked).
Un giorno finalmente qualcuno chiese ad Arthur Janov, lo psicoterapeuta che ideò la terapia primaria: quanto c'è di vero nella scenetta tipica delle biografie di John Lennon? Cioè davvero lui si metteva in un angolo a urlare e lei lo stuzzicava a rovistare nel profondo dei suoi traumi infantili? Lui rispose: "Nonsense. Non facevamo nulla del genere". È che ai biografi piace romanzare, senz'altro, e il fatto che il bestseller di Janov si chiamasse L'urlo primordiale è una circostanza troppo ghiotta. Ma Lennon aveva già iniziato a emettere urla primordiali molto prima di conoscere Janov. Anzi è probabile che tra tanti terapeuti scelse Janov, malgrado non fosse proprio il più comodo (esercitava in un altro continente) proprio perché questa idea dell'urlo risuonava con quello che aveva già sperimentato cantando "yes I'm lonely, wanna die", o "I want you so bad it's driving me mad", e soprattutto "don't let me down", questo piccolo enorme verso intraducibile in italiano.
Non è che John stia semplicemente supplicando di non essere deluso: John vuole essere sorretto. Ne va della sua vita. Il primo "don't let me down" è una supplica, che lo sospende sull'orlo di un Fa#minore; il secondo è già una risposta, che lo riaccoglie nell'abbraccio di un confortevole Mi. Lennon era già in una fase di autoterapia: tutti e Quattro in un certo senso lo erano. Negli studi di Twickenham nel gennaio del 1969 stavano cercando di ritrovare un senso al loro stare insieme. Forse avevano aspettative troppo alte: suonare dal vivo, ma senza tradire gli standard che avevano raggiunto ad Abbey Road con le sovraincisioni. L'unico sistema era provare, provare e ancora provare. Si sarebbe rivelato ben presto un metodo troppo sfibrante per i Quattro, eppure i due brani che furono stampati in aprile su un 45 giri (Get Back! e Don't Let Me Down), sono di ottima fattura. Registrati a fine gennaio dopo che il gruppo era tornato agli studi della Apple, con l'apporto non secondario di Billy Preston, non assomigliano già più ai brani del Disco Bianco che era uscito da pochi mesi (a uccidere i Beatles fu anche questa terribile fretta). Sono brani apparentemente semplici, ma realizzati in un modo unico, da cinque musicisti che li hanno suonati e risuonati fino a dare uno stile personale a ogni nota. L'amore per gli arrangiamenti sovraincisi è stato sostituito da un gusto per la prestazione: anche se non c'è il pubblico ti sorprendi a pensare "speriamo che ce la facciano stavolta". In effetti qualche errorino verso la fine c'è, ma sono pur sempre i Beatles, e non era così facile suonare i Beatles, per i Beatles. Ho sempre trovato straordinario quel contrappunto scandito nel bridge centrale all'unicono dal basso di George e dalla chitarra di Paul, mentre John canta che è innamorato per la prima volta ("non capisci? Durerà! È un amore senza fine, un amore senza età"). Sembra di sentire una sezione di fiati. Non c'è, ma se ci fosse suonerebbe esattamente le note di George e Paul. Sembra una scelta talmente ovvia: un po' di Esercito della Salvezza a fare il verso a John che ha quasi trent'anni e insiste nel ruolo di orfano.
A Don't Let Me Down capita quello che succedeva ad altre canzoni dei primi Beatles dopo un po' che le suonavano: una specie di progressivo insorgere della parodia. Dovrebbe essere un grido d'amore assoluto, ma qua e là è lo stesso John a fomentare il sospetto che si stia facendo il verso da solo. Il vezzo melodrammatico di allungare di un quarto gratuito la prima battuta della strofa ("Nobody ever love me like she does", quell'"ever" è del tutto ridondante, come ogni avverbio) quando arriva alla strofa finale sembra autoparodico ("I guess nobody ever really done me"), addirittura due avverbi! Nel film sorridono tutti parecchio, tranne Ringo che è preoccupato di sbagliare le entrate. Paul accenna anche qualche posa in favore del cameraman; per lui più che un urlo primordiale è un ballabile lento.
Nessuno ha mai capito davvero perché Don't Let Me Down fu esclusa da Let It Be, il disco postumo che documentava quelle sessioni: tanto più che nel film omonimo la canzone viene eseguita sul tetto della Apple (in Let It Be Naked c'è una versione del concerto, ottenuta montando due take diverse). Non va presa necessariamente come una sconfessione del brano; magari aveva un senso commerciale. I Beatles avevano sempre evitato di far confluire tutto il materiale dei singoli negli album. E allo stesso tempo non si può ignorare come Don't Let Me Down sia una delle testimonianze più importanti e riuscite di quel particolare periodo della storia dei Beatles – uno dei pochi episodi che danno un senso a un'esperienza altrimenti fallimentare. Di lì a poco sarebbero tornati in uno studio coperto e si sarebbero rimessi a sovraincidere come se non ci fosse un domani (che in effetti non ci fu).
47. I Want You (She's So Heavy) (Lennon-McCartney, Abbey Road, 1969).
 |
| Was mache ich hier |
Se ammettiamo che I Want You (il blues) e She's So Heavy (Beethoven) siano due canzoni separate ma montate assieme, su Abbey Road di medley ce ne sarebbero due: quello lungo sul secondo lato che termina con La Fine, e quello breve lennoniano sul primo lato, che finisce con una lunga coda strumentale e un silenzio improvviso. Sappiamo che Lennon pensava ormai di divorziare dai tre colleghi. Sappiamo anche che avrebbe voluto invertire i lati del disco, ovvero farlo cominciare con Here Comes the Sun e chiuderlo nell'abrupto modo in cui finisce She's So Heavy, quello stacco netto che probabilmente portò qualche acquirente a riportare il disco in negozio come copia fallata. Alla fine vinse Paul, che aveva più voglia di preoccuparsi di dettagli come la scaletta del disco e il mix finale; ma soprattutto un'idea di finale molto più conciliante col pubblico: un bel carosello di chitarre, una bella frase proverbiale e cerimoniosa al punto giusto, magari ancora un ultimo scherzo per gli amici, e poi a casa: che non è mica finito il mondo, eh? Al limite saranno finiti i Beatles.
Invece per Lennon stava finendo proprio il mondo. Il confronto tra i finali dei due medley tradisce proprio questo enorme scarto esistenziale: è come se dai due lati del disco John dicesse a Paul: ma ancora ti preoccupi per i Beatles? Non capisci che sto morendo? Potrebbe essere domani come tra vent'anni, non lo sai che il tempo è un dettaglio, un'illusione? che tutto è già stato scritto, come un serpente di note che si mangia la coda, e inoltre sono passato all'eroina? E anche ammesso che sopravviva all'oppiaceo più forte sul mercato, cosa può esserci dopo di più potente, di più definitivo, di più pesante?
Il brano comincia, ironicamente, con un assaggio della coda finale, interrotto dopo dieci secondi dal riff di I Want You. Che sia un blues lo capiamo al primo ascolto, anche solo dal fatto che Lennon canti all'unisono con la chitarra, come aveva cominciato a fare durante le sessioni di Twickenham, e sembra non potersene stancare. Diventa ancora più chiaro dopo dieci battute, quando il riff viene ripetuto una quinta più in alto: è un blues lentissimo dunque, quasi fermo, ed è in minore: ma è un blues. Lennon desidera qualcosa, la desidera così forte che ne sta impazzendo, e questo è tutto. Non c'è neanche più spazio per il bestiario allegorico di Yer Blues, qui non ci sono più né immagini né metafore, la coscienza è ridotta a una voce che grida il suo desiderio nel deserto. Può essere il desiderio di una persona o di una sostanza, ma è un desiderio nudo, che non lascia scampo, al punto che non sembra più avere molta importanza se sarà alla fine soddisfatto o no: follia e morte seguiranno in ogni caso. Nei momenti in cui gli viene lasciato spazio il basso di Paul non sta fermo un attimo, un canarino in una gabbia pentatonica; alla fine di ogni strofa Billy Preston pesta l'organo come uno strumento a percussione: finché sulla soglia dei due minuti tutto tace all'improvviso per un istante brevissimo – neanche il tempo di inalare, e John sta già intonando "She's So..." Ed entra il Destino.
 |
| Lei è così pesa. |
È abbastanza ironico che la parte beethoveniana della canzone sia più semplice della parte blues: e allo stesso tempo è giusto così, Lennon non ricorre a Beethoven per mitigare un complesso di inferiorità musicale: Lennon cerca nel romanticismo qualcosa di molto più semplice e mortale. Il serpente di note che si mangia la coda è formato da una breve scala ascendente di quattro semiminime che appena sembrano essersi assestate su un plateau, cascano subito in basso con una terzina (dal sapore vagamente blues); cominciano ad annaspare con un'altra terzina e finalmente ritrovano la via per risalire verso l'alto: ma a questo punto siamo di nuovo sullo stesso plateau, stiamo di nuovo per ricadere con la stessa terzina, stiamo di nuovo annaspando: è un loop, non se ne esce, non se ne può più uscire. Dopo qualche ciclo non ricordiamo neanche più qual era l'inizio e quale la fine: è tutto perfettamente circolare e autoconseguente e noi ne siamo prigionieri. Ci alziamo, prendiamo fiato, ricadiamo, annaspiamo, ci rialziamo. Sarà sempre così: desiderio, parziale appagamento, delusione, angoscia, desiderio. Possiamo cambiare donna e cambiare sostanza, ma non possiamo cambiare il nostro destino: siamo nati desiderando e il Desiderio ci farà girare finché non sarà stanco di noi: finché senza preavviso non ci saremo più e non avremo nemmeno il tempo per accorgercene, sarà uno stacco netto, ecco, John Lennon la sua morte la immaginava così. Sì, lo so, voi volevate soltanto riascoltare una vecchia canzone, mi dispiace. Non succederà più, prometto. Non si poteva più fare niente dopo I Want You. John lo aveva fatto presente, ma Paul non capiva e poi vabbe', chissenefrega, divertitevi pure coi vostri dischi di canzoncine, mentre io muoio.
46. Drive My Car (Lennon-McCartney, Rubber Soul, 1965)
Ho detto a questa ragazza che avevo buone prospettive, lei mi ha risposto, seh vabbe' lo sappiamo. È tutto ok quando lavori per due noccioline, ma io ti farò vedere cos'è il successo. Baby, puoi guidarmi la macchina, lo sai che io sarò una star. Se vi chiedessero di spiegare l'ottimismo della Swinging London con una canzone sola, avreste qualche dubbio? Beep Beep, Beep Beep, Yeah! Philip Norman racconta come Paul in quel periodo andasse in giro travestito, baffi finti e cose del genere, giusto per il gusto di stare in mezzo alla gente. Dopo averlo letto diventa impossibile non immaginare che Drive My Car parli proprio di questo: Paul che si diverte ad attaccar bottone con una ragazza che ha Grandi Aspettative: lei sarà una star del grande schermo, tu nel frattempo puoi farle da chaffeur. Non c'è neanche bisogno di decifrare il doppio senso – che comunque c'è, autorizzato dallo stesso Paul ("Drive my car era un vecchio eufemismo blues per il sesso"). La ragazza ce la può fare, in fondo è sfrontata il giusto, probabilmente ha anche già riconosciuto chi è quel tizio con i baffi finti che può davvero guidarla al successo.
 |
| Da I Beatles in infografiche |
Con Drive My Car Paul sta giocando a nascondino col suo personaggio pubblico. La protagonista sta confessando i suoi sogni di gloria all'unico ventenne a Londra che non ne ha più, li ha realizzati tutti – cos'altro poteva chiedere alla fortuna Paul McCartney, nel 1965? Magari giusto una ragazza ingenua e intraprendente da rimorchiare al parco, un pomeriggio da persona normale a fare sogni a occhi aperti. Anche da un punto di vista musicale, Drive My Car rappresenta i Beatles formato rock al massimo della forma: sembra tutto semplice ma non c'è niente di banale. Paul, che per una volta ha una storia coerente da raccontare (con tanto di battuta finale!), opta per la più classica alternanza di strofa e ritornello. Per la strofa rispolvera il suo timbro littlerichardiano: una scelta singolare visto che sta dando la parola a una ragazza: ma serve a ribadirne la sfrontatezza: e soprattutto a marcare il contrasto col momento in cui da sfrontata si fa ammiccante, e le seconde voci si dispongono un accordo di settima minore ("but you can do something in between"). Il riff di chitarra raddoppiato dal basso è un'idea di George, un prestito riconosciuto da Respect di Otis Redding.
Drive My Car è in effetti uno dei rari casi in tutto il catalogo Beatles in cui una donna parla. Il caso è ancora più eccezionale dal momento che parla per tutto il ritornello, ed è suo lo stesso titolo della canzone: non succederà più, mi pare, fino a Let It Be. Molti titoli dei primi Beatles erano richieste d'amore da declinare in modo più o meno fisico: Love Me Do, Please Please Me, Hold Me Tight, I Want to Hold Your Hand, eccetera. Ma il più provocatorio di tutti Paul lo mette in bocca a questa ragazza che forse è meno ingenua di quanto appare: puoi guidarmi la macchina, baby. E forse ti amerò. Chi sta guidando davvero, dei due?
45. I Feel Fine (Lennon-McCartney, singolo, 1964)
I'm so glad that she's my little girl. Non solo i Beatles dei primi due anni cantavano esclusivamente canzoni d'amore, ma con qualche eccezione (cover, per lo più) si tratta di amore corrisposto. Io la amo, lei ti ama, tu mi fai piacere, io ti faccio piacere, stringiamoci le mani, abbracciamoci forte, adesso seriamente non è fantastico? Mettiamo che possiate scegliere di assumere una droga in questo istante: preferireste un oppiaceo, un vasodilatatore, un allucinogeno, o una sorsata della dopamina di quando eravate adolescenti e lei vi amava e voi l'amavate e quel giorno tutti hanno scoperto che stavate assieme? Purtroppo non è in commercio, mi dispiace (ma potete sempre ascoltare i Beatles).
L'effetto dopante è amplificato da una condizione che Lennon e McCartney avevano scoperto verso la fine del 1962, e che ne ha decretato il successo: gli osservatori esterni. Essi ci guardano (If I Fell), a volte ci aiutano (She Loves You), sempre ci invidiano. Non ci fossero loro che ci spìano non ci sarebbe neanche tutto questo gusto ad appartarsi. Questo può spiegare come mai il ritornello di I Feel Fine reciti: "I'm in love with her", che sintatticamente non ha molto senso, perché viene dopo una strofa ("Baby says she's fine, you know, she tells me all the time, you know") che termina con un "she said so", "lei ha detto così". A questo punto ci aspettiamo che il cantante riporti ancora un discorso diretto della partner, e invece dopo quel "she said so" Lennon parla in prima persona: "I'm in love with her and I feel fine". Ok, da un punto di vista sintattico "I'm in love with him" avrebbe avuto più senso, ma si può comprendere la ritrosia di Lennon a cantare un ritornello del genere in un singolo del 1964 (solo Ringo aveva la flemma per gridare "I'm talking 'bout boys now"!)
Un'altra possibilità era passare al discorso indiretto e cantare "She's in love with me and I feel fine": che è poi quello che fa Lennon a fine canzone. Ma all'inizio no, perché? Perché ha bisogno di un interlocutore. "I'm in love with her" aggiunge questo alla canzone: la presenza di un confidente, muto, che non deve far altro che ascoltare l'estasiata testimonianza di John: oh, sono così felice, lei dice a tutto il mondo che le compro un sacco di cose, sai, le compro gli anelli di diamanti, lei dice proprio così. Che senso ha avere una ragazza felice di stare con te se non lo stai raccontando a qualcuno?
I Feel Fine viene in soccorso del musicologo che ci tiene a dimostrare come l'evoluzione di Lennon/McCartney proceda in modo progressivo, senza salti bruschi o crisi significative: se la strofa è molto innovativa e anticipa gli sviluppi più rock del biennio '65-'66, il bridge è ancora saldamente ancorato in quella poetica yeh-yeh che aveva regalato ai Beatles quattro singoli al primo posto: I Feel Fine fu il quinto, il che sorprese positivamente lo stesso Lennon, che pensava di aver rischiato più del solito. Sua fu l'idea di cominciare il brano con un feedback, il 'fischio' di un amplificatore troppo vicino a un microfono, che oggi passa quasi inosservato ma ai tempi era una maleducazione inconcepibile in un prodotto inciso, al punto che George Martin dovette farlo passare per un errore. "Prima di Hendrix, prima degli Who, prima di chiunque. Il primo feedback su qualsiasi disco". È la prima incursione dei Beatles di studio nel mondo dei rumori, un'anticipazione delle follie di là da venire: ma è anche un ritorno alle radici grezze, al sound cacofonico del Cavern Club o di Amburgo; "Tutti giocavano col feedback nei concerti, e la roba alla Jimi Hendrix succedeva già da un pezzo. In effetti tutta quella roba punk di adesso è solamente quello che [ai nostri tempi] la gente faceva nei club". La novità più macroscopica resta il riff della strofa, suonato all'unisono dalle chitarre di George e di John (che non riusciva però a cantarci sopra). È un esercizio pentatonico ripetuto su tre accordi diversi: con ogni probabilità il riff più complesso che si poteva sentire in un pezzo rock alla radio nel 1964 – anche perché i rivali stavano piuttosto cercando di semplificare, il riff di You Really Got Me dei Kinks giocava su due note, quello di Satisfaction su tre o quattro, si era insomma aperta la caccia al riff più basilare e maestoso, da suonare magari roteando teatralmente il braccio destro come Pete Townshend. Invece a fine 1964 Lennon sembrava avere una fobia del vuoto: riempiva le battute di note proprio come la voce narrante riempiva la frase di intercalari (tutti quegli "you know", apparentemente inutili, ma che servono a ribadire la presenza di un testimone). In tutta quest'ansia di non lasciare spazio al silenzio, col senno del poi, possiamo leggere già quell'irrequietezza esistenziale che comincia ad affiorare nei solchi più interessanti di Beatles for Sale: ma dobbiamo proprio? Non possiamo semplicemente esser felici perché quei due stanno assieme e sono felici? Ne avremo, di tempo, per le canzoni tristi. I Feel Fine è la canzone più felice di John Lennon, ed è anche l'ultima sua che ascolteremo su un lato A di un 45 giri per più di due anni (se si eccettuano i 45 giri estratti dagli album). Non è una coincidenza.
44. Get Back (Lennon-McCartney, singolo, 1969; poi in Let It Be, 1970).
Retrospettivamente, Get Back non fu una grande idea. Non il brano in sé (che schizzò immediatamente al primo posto della top10 britannica e ci restò per sei settimane), ma proprio il titolo. I Beatles avevano sempre creduto nell'importanza di un buon titolo, Paul soprattutto ("se qualcuno ti chiede "Qual è la tua nuova canzone" e tu hai un titolo interessante, sei già a metà strada"). A Hard Day's Night era un titolo buffo e intrigante. Beatles For Sale era autoparodico. Help!, Rubber Soul, Revolver, Sgt Pepper's..., Magical Mystery Tour: tutti titoli che attirano l'attenzione, destano curiosità. Get Back spiegava quello che volevano fare i Quattro all'inizio del 1969, in modo semplice. Forse troppo semplice. Anche un po' brutale. "Torna indietro" non è mai un buon messaggio. Ti si ritorce contro.
Proprio nell'anno della contestazione, nell'ambiente rock tirava un'aria di ritorno all'ordine. Già nel 1968 i Rolling Stones dopo la sbornia psicadelica erano tornati al solido blues di Beggars Banquet. Bob Dylan già a fine 1967 aveva già sorpreso tutti con un breve disco enigmatico e spogliato all'osso, John Wesley Harding. Poi in estate era uscito il disco del gruppo che accompagnava Dylan, e che ora si faceva chiamare semplicemente Band, Music From the Big Pink, e aveva sorpreso pubblico e addetti ai lavori per quell'atmosfera di semplicità, di musica fatta in casa con amore e senza troppi fronzoli. Eric Clapton ascoltandolo aveva deciso di chiudere coi Cream. La "Big Pink" era la casa di Woodstock nella cui cantina Dylan e la Band si erano ritirati a suonare musica per il gusto di farlo. George Harrison era andato a trovarli a Woodstock e si era lasciato conquistare dall'atmosfera informale, dalla serenità che il gruppo sprigionava suonando per il gusto di suonare. Potevano i Beatles fare lo stesso? Ma senza smettere di essere i Beatles, cioè il gruppo da cui ci si aspettava un singolo di successo ogni quattro mesi, un album capolavoro entro l'estate? Ci potevano almeno provare.
 Quando in estate uscì il primo disco (abusivo) con le canzoni registrate da Dylan e dalla Band in cantina, tutti poterono misurare la somiglianza con Get Back, registrata in gennaio ma pubblicata in aprile: canzoni semplici, divertenti da suonare (in particolare si diverte Lennon con la chitarra solista), testi enigmatici ma spesso probabilmente inventati davanti al microfono. Get Back è un classico esempio di metacanzone: non dice soltanto "torna indietro" – anzi lo dice in modo abbastanza confuso – ma rappresenta un ritorno indietro, a un passato ormai mitico in cui i Quattro improvvisavano rock'n'roll su due accordi. Il brano piacque subito, anche perché paradossalmente proponeva un'idea di suono beatle già molto diversa da quella del Disco Bianco che era uscito pochi mesi prima: ancor più che la direzione, al pubblico interessava il movimento. Si sarebbe in seguito scoperto che "tornare indietro" per i Beatles era un'opzione ancora più faticosa di andare avanti. Per ottenere quel suono fatto in casa che suonasse naturale i Quattro dovettero riprovarla fino allo sfinimento di volte (oltre a farsi dare una mano da Billy Preston all'organo).
Quando in estate uscì il primo disco (abusivo) con le canzoni registrate da Dylan e dalla Band in cantina, tutti poterono misurare la somiglianza con Get Back, registrata in gennaio ma pubblicata in aprile: canzoni semplici, divertenti da suonare (in particolare si diverte Lennon con la chitarra solista), testi enigmatici ma spesso probabilmente inventati davanti al microfono. Get Back è un classico esempio di metacanzone: non dice soltanto "torna indietro" – anzi lo dice in modo abbastanza confuso – ma rappresenta un ritorno indietro, a un passato ormai mitico in cui i Quattro improvvisavano rock'n'roll su due accordi. Il brano piacque subito, anche perché paradossalmente proponeva un'idea di suono beatle già molto diversa da quella del Disco Bianco che era uscito pochi mesi prima: ancor più che la direzione, al pubblico interessava il movimento. Si sarebbe in seguito scoperto che "tornare indietro" per i Beatles era un'opzione ancora più faticosa di andare avanti. Per ottenere quel suono fatto in casa che suonasse naturale i Quattro dovettero riprovarla fino allo sfinimento di volte (oltre a farsi dare una mano da Billy Preston all'organo).Persino improvvisare quattro versi al microfono era meno semplice del previsto. Ogni parola era un'insidia. In una delle prime versioni c'era un'intera strofa dedicata agli immigrati, in particolare ai "pakistani" perché Paul aveva letto della loro drammatica condizione negli slums britannici e soprattutto gli piaceva il suono della parola. A quel punto il ritornello sarebbe diventato una satira del nazionalismo britannico ("Tornatevene da dove siete venuti"). Molto progressista per un gruppo che aveva sempre dribblato il coinvolgimento politico – e anche molto rischioso: l'ironia è un procedimento retorico che richiede la complicità del pubblico. Per ottenere questa complicità serve almeno un segnale (un occhiolino, un emoticon) che le radio di tutto il mondo non avrebbero potuto trasmettere. Quel Get back rischiava di suonare indistinguibile dagli slogan di cui si prendeva gioco e così i Quattro decisero, saggiamente, di toglierlo e rifugiarsi nel nonsense, nelle libere associazioni dell'inconscio. Ma l'inconscio è una brutta bestia, ne abbiamo già parlato.
"Credo che ci fosse qualche allusione a Yoko, sai Tornatene al luogo a cui appartenevi. Ogni volta che cantava quel verso in studio, dava un'occhiata a Yoko. Probabilmente dirà che sono un paranoico". Beh in effetti, sì, signor Lennon, la paranoia va messa in conto, specie quando si fa uso di stupefacenti. E allo stesso tempo, davvero, come si fa a escludere che Paul abbia guardato anche una volta sola Yoko Ono, mentre intonava Get Back? Giusto il tempo di uno sguardo importuno: vi è mai capitato di fissare la persona che non avreste dovuto fissare, nel momento meno indicato in assoluto? Potrebbe essere successo anche a Paul. Yoko veniva da New York, e prima ancora veniva dal Giappone; la canzone è proprio un invito a tornarsene a casa; un messaggio pericoloso. Mentre canto il ritornello forse è meglio evitare di guardare la straniera in faccia, a proposito, dov'è? Ops, troppo tardi, l'ho guardata. Vabbe', facciamo finta di niente.
Il solito problema delle parole delle canzoni. Meno senso hanno, più senso possono trattenere.
Paul s'inventa un personaggio, "Jojo", doppio già nel nome (Jojo non suona come Yoyo, ma neanche troppo diverso), che pensa di essere solitario ma sa che non può durare (chi era fino a pochi mesi prima lo scapolo d'oro dei Beatles?) Jojo decide di lasciare la sua casa che, di tutti i posti al mondo, è proprio a Tucson, in Arizona: un luogo proverbiale per tutti gli spettatori di film western, ma anche la città in cui aveva vissuto la famiglia di Linda Eastman. Jojo è "metà uomo, metà donna, molto ambiguo" spiega Paul nella sua autobiografia, e forse è un lapsus interessante, perché fino a quel momento era lecito pensare che fosse l'altro personaggio, "sweet Loretta Martin", a "credere di essere una donna mentre era un altro uomo". Loretta Martin ha le stesse iniziali di Linda McCartney. L'accusa di essere una donna-uomo veniva mossa talvolta alle spalle di Yoko Ono, non solo perché la sua femminilità non si inquadrava negli schemi di allora, ma per spiegare il fatto che dopo averla incontrata Lennon si fosse parzialmente femminilizzato. Insomma, Get Back nella sua versione finale non parla di nulla: ma se parlasse, forse avrebbe qualcosa da dire sulle rispettive partner degli autori. Vengono da lontano e stanno per lacerare definitivamente il gruppo. Non potrebbero tornarsene indietro, al luogo in cui appartengono? Non è che Paul volesse dire questo, anzi: Paul voleva dire tutto tranne questo. Ma sono proprio quelli i momenti in cui ti tradisci.
Col senno del poi, quel titolo era tremendo. Se è vero che azzeccando un buon titolo sei a metà strada, se lo sbagli non recuperi più. È facilissimo offendere qualcuno cantando Get Back. Ci sarà sempre qualcuno che si sente fuori posto e che si sentirà offeso. E siccome ci sentiamo tutti un po' fuori posto, e stiamo aspettando tutti un'occasione per offenderci...
43. We Can Work It Out (Lennon-McCartney, singolo, 1965).
Try to see it in my way... Potrebbe essere la canzone centrale di tutta la storia dei Beatles: il perno, il fulcro, il momento in cui Paul sorpassa John, l'inizio della fine, la fine dell'inizio. A decidere fu il pubblico, comunque. Lennon non credeva in We Can Work It Out; pensava che la sua Day Tripper avrebbe funzionato meglio come singolo, e riuscì a ottenere un compromesso: il 45 giri uscì senza stabilire una gerarchia tra "lato A" e "lato B", le due canzoni avevano pari importanza. Insomma tra il rock-blues di Day Tripper e l'esperimento pop-valzer di We Can Work It Out avrebbe scelto il pubblico, in particolare quello radiofonico. Il pubblico scelse We Can Work It Out.
Non era così scontato. Paradossalmente quello che faceva la differenza nel brano di Paul era il pezzo scritto da John: l'inserto vagamente melodrammatico, "Life is very short", che culminava con un inedito passaggio in tre quarti (soluzione suggerita da George Harrison): qualcosa che in radio non si era mai sentito e che, chi l'avrebbe detto mai, gli ascoltatori inglesi avevano voglia di sentire.
In sostanza John si era sconfitto da solo: il John più rock'n'rolleggiante era stato eclissato dal John sperimentale, quello più interessato ad assecondare l'eclettismo di Paul (anche solo per sabotarlo dall'interno). Se Day Tripper avesse vinto lo scontro, la storia dei Beatles sarebbe stata sensibilmente diversa. Se il grande pubblico avesse mostrato nel '65 di preferire un sano rock'n'roll, i Beatles non avrebbero perso troppo tempo a procurarglielo, concedendo meno spazio alle sperimentazioni e alle esplorazioni che alla lunga alienarono soprattutto Paul dal resto del gruppo. Può anche darsi che i Beatles sarebbero durati di più (e i Rolling Stones avrebbero avuto meno spazio). Ma nel '65 la gente preferiva ascoltare We Can Work It Out, un brano sghembo, non molto ballabile, neanche così cantabile, ma che doveva suonare come la promessa di cose favolose di là da venire. Una canzone che senza farlo apposta contiene la formula dei Beatles dal 1966 alla fine: il 60% è di Paul, che canta tutta la strofa e cerca di salvare un rapporto complicato con un atteggiamento paternalistico che può indisporre; il 35% è di John che canta tutto il bridge e la butta sull'esistenziale; il 5% è di George che suggerisce il breve passo di valzer. Possiamo tenere i piedi in tutte le staffe, canta Paul (ma la vita è troppo corta, obietta John). Possiamo spiegarci tra di noi, possiamo andare avanti, possiamo farcela. Ma il valzer non è d'accordo, e ha l'ultima parola.
42. With a Little Help From My Friends (Lennon-McCartney, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band).
Hai bisogno di qualcuno? Potrebbe essere chiunque? Sgt Pepper è uno spettacolo così variopinto che ci metti un po' a notare gli elementi che mancano. Anche quelli un tempo fondamentali. Uno è il rock'n'roll, annunciato con grandi fanfare nel primo minuto del disco, ma poi eclissato proprio dalle fanfare. Un altro è l'amore. Ce n'è proprio poco, anche volendo considerare l'attrazione nei confronti di Lovely Rita qualcosa di più di un'infatuazione. Considerato che fino a due anni prima Lennon e McCartney scrivevano esclusivamente d'amore, è un dato impressionante che l'unica vera canzone di amore corrisposto sia Getting Better, non a caso quella che suona più "vecchi Beatles". Anche With a Little Help indugia in un suono che rappresenta un passo indietro persino rispetto a Revolver, ed è a suo modo una canzone in cui dell'amore si sente la necessità, anche se non c'è più e va ritrovato (con un piccolo aiuto degli amici). E forse arriva nell'ultimo verso, molto ambiguo. ("Cosa hai visto quando si è spenta la luce? Non posso dirtelo, ma so che è mio": una di quelle strizzatine d'occhio di Paul che lasciano perplessi).
Che With a Little Help avesse le qualità per diventare un classico, l'avrebbe dimostrato di lì a poco Joe Cocker. In Sgt Pepper invece è quasi mortificata da un arrangiamento non semplice, ma semplicista, che si sforza di far passare un solido brano r'n'b per una canzoncina che un artista amatoriale potrebbe cantare su un gazebo, in un umido parco di una non meglio precisata località dell'Inghilterra settentrionale. Si chiama Billy Shears, veste un buffo costume fucsia, ma ovviamente è Ringo – alla fine forse l'idea di fare un disco come Sgt Pepper, un alternarsi di numeri di varietà, non è che l'estensione di quella pratica per cui, dal 1964 in poi, i brani cantati da Ringo erano concepiti sempre più come dei siparietti. Di tutti e Quattro, Ringo era la presenza più teatrale, non solo nei film: più personaggio che musicista (il musicista fa in tempo a regalare un breve intermezzo di tom-tom che cinquant'anni dopo strappa ancora l'applauso). La necessità di imbastire un pezzo 'facile' per le sue limitate capacità vocali viene qui portata al grottesco, e i Beatles forse per la prima volta intonano una parodia di loro stessi. With a Little Help è l'idea dei Beatles che hanno molti che credono di detestarli: una canzoncina semplice tutta coretti e sentimenti stereotipati, con un ritmo martellante che ne ingessa le potenzialità soul. Di fianco a loro, sulla copertina di Sgt Pepper, i Quattro avevano voluto i quattro manichini di cera che li ritraevano nel museo di Madame Tussaud; With a Little Help è l'equivalente musicale di quel contrasto fotografico: dopo la variopinta fanfara che dà il titolo al disco, ecco un brano che ci riporta al passato recente, quando eravamo quattro manichini produttori di canzoni d'amore in serie.
41. Taxman (Harrison, Revolver, 1966).
And you're working for no one but me. Taxman è la prima canzone dei Beatles a giocare con un riferimento pop (se davvero, come sembra difficile negare, George avesse in mente la sigla del telefilm di Batman che però nel Regno Unito non era ancora arrivato). È la prima canzone a nominare due uomini politici – primo ministro e capo dell'opposizione, mica fessi questi Beatles – e a contenere una rivendicazione politica, più rancorosa che documentata, ma comunque anni luce più concreta di qualsiasi cosa avessero cantato fino a quel momento: ehi, l'uomo delle tasse ci prende il 95% degli utili, non è un iperbole, è proprio così.
È la prima canzone in cui i soldi non sono un elemento retorico, una cosa che serve a comprare tutto ma-non-l'amore, ma una realtà fisica, misurabile e volatile: troppo volatile, povero George. È la prima canzone di Revolver, il disco che cambia davvero tutto proprio quando tutto sembrava già molto cambiato. È la prima canzone in cui George Harrison fa davvero la differenza, mostrando uno stile suo a cui i colleghi per la prima volta scelgono di adattarsi, al punto che la chitarra solista di Paul se ne va di sua spontanea iniziativa alla ricerca di una specie di raga indiano.
Taxman insomma è la prima canzone in tanti elenchi... tutti piuttosto brevi. I Beatles non abbonderanno mai coi riferimenti pop; non nomineranno più uomini politici, non aderiranno a nessuna piattaforma politica e non avanzeranno più nessuna rivendicazione fiscale. Lo stesso George, dopo l'exploit di Revolver (tre brani su quattordici, record assoluto), continuerà a faticare molto per imporre le sue canzoni. Taxman insomma contiene molte più possibilità di quelle che i Beatles decisero di praticare davvero.
In effetti è un brano che corre il rischio di risultare antipatico – non ci sono molti altri episodi della storia del rock in cui un milionario scelga di denunciare non i problemi del mondo, ma i propri problemi col fisco. A sua discolpa, George era molto più giovane e ingenuo di quanto credeva di essere, e la fiscalità britannica molto iniqua con questi quattro ex proletari rei di avere scavalcato un'intera rampa della scala sociale. Il modo migliore di apprezzare Taxman credo sia quello di fingersi un ascoltatore del 1966, privo di pregiudizio, e rimanere completamente allibito: cosa sta succedendo? Sembrano colpi di tosse, il disco è difettoso? Perché insistono a suonare un solo accordo solo? Ma è George che canta, sul serio? E la chitarra, mio dio, ma che sta succedendo? Sono davvero i Beatles questi? Roba da matti, non c'è più religione.
Comments (4)
Esdra e l'invenzione d'Israele
13-07-2020, 01:25Bibbia, ebraismo, Israele-Palestina, razzismi, repliche, StoriaPermalink13 luglio - Esdra (V secolo a.C.), sacerdote.
[2014]. I mormoni che nel 1846 fuggirono dall'Illinois per fondare una nuova patria sulle rive del Grande Lago Salato. I giamaicani che a partire dagli anni Sessanta si trasferiscono a Shashamane (Etiopia) per stare più vicini a Ras Tafari, l'imperatore Hailé Selassié. Gli adepti del reverendo Jim Jones, pronti a seguire il loro Messia fino in Guyana, e poi all'altro mondo. Tutta questa gente che lascia la propria terra per arrivare in un'altra, dove quasi mai scorrono il latte e il miele promessi - tutta questa gente non sta improvvisando, il canovaccio è vecchio di migliaia di anni, ma chi l'ha scritto? È abbastanza impossibile saperlo, ma probabilmente è meno antico di quanto crediamo. Mosè dovrebbe essere vissuto più o meno verso la metà del secondo millennio avanti Cristo, ma gli storici ormai propendono per considerarlo un personaggio fantastico. Lo scontro col faraone, primo esempio storico di vertenza sindacale (finita malissimo), sarebbe un'invenzione molto posteriore, che riecheggerebbe un altro esodo, questo sì realmente accaduto: la deportazione babilonese. Proprio a Babilonia verso il sesto secolo prenderebbero forma le Scritture ebraiche, rielaborate intorno a nuclei più antichi. Come se gli Ebrei nascessero già in diaspora: con la consapevolezza di essere sparsi per il mondo, disuniti e perennemente minacciati nella loro stessa esistenza.
A Babilonia, nel VI secolo, gli Ebrei cominciano a raccontarsi storie sul loro passato; storie che valgano la pena di provvedere a un futuro. Decidono di essere stati, prima delle invasioni assire e babilonesi, una grande nazione, guidata da grandi re: David e Salomone. Alla promiscuità di quest'ultimo viene imputata la decadenza successiva; ai peccati e alla disobbedienza di popolo e regnanti la divisione in due regni e le ripetute sconfitte, culminate con la deportazione. Ma se la diaspora è la punizione che Dio ha inflitto a un popolo disobbediente, il premio per un popolo obbediente non può essere che l'inverso: una Terra Promessa.
Ciro, lo Scià di Persia, che in una fase di recessione economica globale ha rilevato i resti dell'impero Babilonese, sembra sensibile all'argomento: la Palestina è un avamposto remoto, ma importante: un passaggio obbligato per le carovane dirette verso l'Egitto. Quando una lobby che rappresenta un gruppo di fedeli di un Dio di quella regione, un certo YHWH, gli propone di tornare là e cominciare a fortificare la zona, imponendo la pace imperiale alle burrascose tribù autoctone, Ciro sottoscrive l'editto, chissà se ci avrà pensato più di tanto. Era il Re dei Re, in quella mattinata gli capitò di suggellare tante altre tavolette o papiri che credeva assai più importanti, decisioni che avrebbero dimostrato ai posteri la sua illuminata potenza. Altro che le beghe di una piccola regione periferica, di cui nessuno probabilmente si sarebbe ricordato da lì a trent'anni...
L'Esdra biblico è un personaggio appena abbozzato; compare in un paio di scene, e non se ne sa più nulla. Il suo libro è tra i più frammentari e rimaneggiati del canone biblico. Una specie di backdoor ben occultata; se riusciamo a trovarla possiamo guardare le Scritture dal lato di chi le ha scritte. La storia si capovolge; Mosè diventa una proiezione di Esdra; l'esodo dall'Egitto è il ritorno a Gerusalemme; i popoli sterminati da Giosuè alludono ai popoli con cui il nuovo Israele non doveva mescolarsi; il Primo Tempio è un sogno concepito intorno al Secondo; il Faraone che insegue i suoi manovali è l'immagine specchiata dello Scià Ciro che lascia partire volentieri una tribù stanca di vivere mescolata alle altre.
Il sacerdote Esdra non è tra i primi ebrei che tornano a casa. Non assiste ai primi tentativi di costruire il tempio; non c'è quando i nemici cominciano a tramare e a mandare messaggi allarmisti alla corte del nuovo Scià, Dario. Esdra arriva anche venti anni più tardi, verso il 500. Porta con sé i rotoli della Legge, di cui darà solenne lettura davanti a tutto il popolo: la storia di un Mosè che aveva guidato i suoi fedeli fuori dall'empio Egitto, e di un Giosuè che li aveva ricondotti nella Terra Promessa, sterminando dietro richiesta divina i suoi indegni abitanti.
Esdra rimane seduto e costernato diverse ore, fino al sacrificio serale. Poi cade in ginocchio e prorompe: "Mio Dio, sono confuso, ho vergogna di alzare, Dio mio, la faccia verso di te, poiché le nostre colpe si sono moltiplicate fin sopra la nostra testa; la nostra colpevolezza è aumentata fino al cielo" e bla bla bla, insomma stava andando tutto bene, e che mi fanno? Cominciano a sposarsi con le donne del luogo. Ora non dico che vadano sterminate – come c'è pur scritto che avremmo fatto un millennio fa in quel rotolo che abbiamo messo assieme a Babilonia – ma sposarle, farci i figli... l'assimilazione culturale... e nel giro di due o tre secoli finisce che mangiamo maiale pure noi, e poi come faranno gli archeologi del Duemila a capire se in tale insediamento ci stavano i canaaniti o gli israeliti? [sul serio, l'unica differenza spesso sta nei resti di ossa di maiale].
Lo Utah dei mormoni, l'Etiopia dei rastafariani, la Guyana di Jim Jones. Tutte queste terre promesse, senza Esdra, ci sarebbero state? Probabilmente sì; è difficile immaginare che un oscuro sacerdote ebraico-babilonese a cavallo tra sesto e quinti secolo a.C. sia la causa di tutto. Più probabilmente è solo il primo sintomo di qualcosa che ci portiamo dentro: il retaggio di millenni di nomadismo, una propensione ancestrale ad andarcene da qualche parte dove finalmente saremo soli, saremo puri, saremo noi. Poi ci arriviamo e c'è sempre qualcun altro.
[2014]. I mormoni che nel 1846 fuggirono dall'Illinois per fondare una nuova patria sulle rive del Grande Lago Salato. I giamaicani che a partire dagli anni Sessanta si trasferiscono a Shashamane (Etiopia) per stare più vicini a Ras Tafari, l'imperatore Hailé Selassié. Gli adepti del reverendo Jim Jones, pronti a seguire il loro Messia fino in Guyana, e poi all'altro mondo. Tutta questa gente che lascia la propria terra per arrivare in un'altra, dove quasi mai scorrono il latte e il miele promessi - tutta questa gente non sta improvvisando, il canovaccio è vecchio di migliaia di anni, ma chi l'ha scritto? È abbastanza impossibile saperlo, ma probabilmente è meno antico di quanto crediamo. Mosè dovrebbe essere vissuto più o meno verso la metà del secondo millennio avanti Cristo, ma gli storici ormai propendono per considerarlo un personaggio fantastico. Lo scontro col faraone, primo esempio storico di vertenza sindacale (finita malissimo), sarebbe un'invenzione molto posteriore, che riecheggerebbe un altro esodo, questo sì realmente accaduto: la deportazione babilonese. Proprio a Babilonia verso il sesto secolo prenderebbero forma le Scritture ebraiche, rielaborate intorno a nuclei più antichi. Come se gli Ebrei nascessero già in diaspora: con la consapevolezza di essere sparsi per il mondo, disuniti e perennemente minacciati nella loro stessa esistenza.
 |
| Trent'anni di lobbying per ottenere una provincia autonoma, e appena arrivate qui vi accoppiate con le indigene. È sconfortante. |
A Babilonia, nel VI secolo, gli Ebrei cominciano a raccontarsi storie sul loro passato; storie che valgano la pena di provvedere a un futuro. Decidono di essere stati, prima delle invasioni assire e babilonesi, una grande nazione, guidata da grandi re: David e Salomone. Alla promiscuità di quest'ultimo viene imputata la decadenza successiva; ai peccati e alla disobbedienza di popolo e regnanti la divisione in due regni e le ripetute sconfitte, culminate con la deportazione. Ma se la diaspora è la punizione che Dio ha inflitto a un popolo disobbediente, il premio per un popolo obbediente non può essere che l'inverso: una Terra Promessa.
Ciro, lo Scià di Persia, che in una fase di recessione economica globale ha rilevato i resti dell'impero Babilonese, sembra sensibile all'argomento: la Palestina è un avamposto remoto, ma importante: un passaggio obbligato per le carovane dirette verso l'Egitto. Quando una lobby che rappresenta un gruppo di fedeli di un Dio di quella regione, un certo YHWH, gli propone di tornare là e cominciare a fortificare la zona, imponendo la pace imperiale alle burrascose tribù autoctone, Ciro sottoscrive l'editto, chissà se ci avrà pensato più di tanto. Era il Re dei Re, in quella mattinata gli capitò di suggellare tante altre tavolette o papiri che credeva assai più importanti, decisioni che avrebbero dimostrato ai posteri la sua illuminata potenza. Altro che le beghe di una piccola regione periferica, di cui nessuno probabilmente si sarebbe ricordato da lì a trent'anni...
L'Esdra biblico è un personaggio appena abbozzato; compare in un paio di scene, e non se ne sa più nulla. Il suo libro è tra i più frammentari e rimaneggiati del canone biblico. Una specie di backdoor ben occultata; se riusciamo a trovarla possiamo guardare le Scritture dal lato di chi le ha scritte. La storia si capovolge; Mosè diventa una proiezione di Esdra; l'esodo dall'Egitto è il ritorno a Gerusalemme; i popoli sterminati da Giosuè alludono ai popoli con cui il nuovo Israele non doveva mescolarsi; il Primo Tempio è un sogno concepito intorno al Secondo; il Faraone che insegue i suoi manovali è l'immagine specchiata dello Scià Ciro che lascia partire volentieri una tribù stanca di vivere mescolata alle altre.
Il sacerdote Esdra non è tra i primi ebrei che tornano a casa. Non assiste ai primi tentativi di costruire il tempio; non c'è quando i nemici cominciano a tramare e a mandare messaggi allarmisti alla corte del nuovo Scià, Dario. Esdra arriva anche venti anni più tardi, verso il 500. Porta con sé i rotoli della Legge, di cui darà solenne lettura davanti a tutto il popolo: la storia di un Mosè che aveva guidato i suoi fedeli fuori dall'empio Egitto, e di un Giosuè che li aveva ricondotti nella Terra Promessa, sterminando dietro richiesta divina i suoi indegni abitanti.
Alcuni gruppi concepirono anzi ed impostarono il nuovo esodo come un'impresa basata su una sorta di organizzazione para-militare e con forte conflittualità verso i gruppi residenti. La visualizzazione del popolo in marcia attraverso il deserto deve qualcosa a questa impostazione para-militare; ma deve anche qualcosa (e forse molto) all'esperienza delle deportazioni imperiali. Già la promessa divina del tipo "io vi farò abitare in un paese in cui scorre il latte e miele" è significativamente consonante con l'assicurazione del rab-saqe assiro di dare a chi si sottomette la possibilità di andare ad abitare in un paese fertile e produttivo. Altrettanto indicativo è il timore serpeggiante nel popolo in marcia, di non trovare nella terra di destinazione condizioni di vita adeguate alle promesse e alle speranze - timore che riflette lo stato d'animo di chi nella diaspora doveva decidere se affrontare o meno i rischi del rientro. E soprattutto gli elenchi o censimenti (Num. 2; 26) del popolo diviso per gruppi familiari e per clan risentono di un tipo di registrazione amministrativa che veniva applicata ai gruppi di deportati, al fine di controllarne il numero (nonché le inevitabili perdite in corso di trasferimento) e le mete finali (Mario Liverani, Oltre La Bibbia, Laterza, 2003).Esdra porta con sé un'ulteriore ideuzza destinata ad avere, anch'essa, una lunga fortuna: la purezza etnica. La prima cosa che fa quando arriva è stracciarsi le vesti in segno di protesta: i capifamiglia gli hanno appena accennato il problema dei matrimoni misti.
Udito ciò, ho lacerato il mio vestito e il mio mantello, mi sono strappato i capelli e i peli della barba e mi sono seduto costernato. Quanti tremavano per i giudizi del Dio d'Israele su questa infedeltà dei rimpatriati, si radunarono presso di me.
 |
| È tuttora una questione spinosa. |
Esdra rimane seduto e costernato diverse ore, fino al sacrificio serale. Poi cade in ginocchio e prorompe: "Mio Dio, sono confuso, ho vergogna di alzare, Dio mio, la faccia verso di te, poiché le nostre colpe si sono moltiplicate fin sopra la nostra testa; la nostra colpevolezza è aumentata fino al cielo" e bla bla bla, insomma stava andando tutto bene, e che mi fanno? Cominciano a sposarsi con le donne del luogo. Ora non dico che vadano sterminate – come c'è pur scritto che avremmo fatto un millennio fa in quel rotolo che abbiamo messo assieme a Babilonia – ma sposarle, farci i figli... l'assimilazione culturale... e nel giro di due o tre secoli finisce che mangiamo maiale pure noi, e poi come faranno gli archeologi del Duemila a capire se in tale insediamento ci stavano i canaaniti o gli israeliti? [sul serio, l'unica differenza spesso sta nei resti di ossa di maiale].
Ma ora, che dire, Dio nostro, dopo questo? Poiché abbiamo abbandonato i tuoi comandi che tu avevi dato per mezzo dei tuoi servi, i profeti, dicendo: Il paese di cui voi andate a prendere il possesso è un paese immondo, per l'immondezza dei popoli indigeni, per le nefandezze di cui l'hanno colmato da un capo all'altro con le loro impurità. Per questo non dovete dare le vostre figlie ai loro figli, né prendere le loro figlie per i vostri figli; non dovrete mai contribuire alla loro prosperità e al loro benessere, così diventerete forti voi e potrete mangiare i beni del paese e lasciare un'eredità ai vostri figli per sempre...Va avanti così per molti altri versetti, ma insomma il senso è chiaro. Mentre piange e si dispera, intorno a lui si forma un crocchio di fedeli che cerca di consolarlo. Alla fine uno di loro (Secania, figlio di Iechiel) prende la parola: dai Esdra, possiamo ancora salvarci. Che ne dici se divorziamo tutti quanti in una volta, e rimandiamo le nostre mogli infedeli ai loro genitori? E i figli? Anche i figli naturalmente. Al che Esdra, snif, si calma un po': dite che è possibile? Massì, Esdra, che ci vuole. Un bel divorzio collettivo, magari per ogni moglie offriamo anche un ariete in sacrificio. E va bene, mi avete convinto. Ma d'ora in poi guai a chi sgarra."Con Ezra", spiega ancora Liverani, "si conclude l'elaborazione della Legge, si chiude anche l'elaborazione storiografica, cessano di agire i profeti, il sacerdozio di Gerusalemme ha pieni poteri".
Lo Utah dei mormoni, l'Etiopia dei rastafariani, la Guyana di Jim Jones. Tutte queste terre promesse, senza Esdra, ci sarebbero state? Probabilmente sì; è difficile immaginare che un oscuro sacerdote ebraico-babilonese a cavallo tra sesto e quinti secolo a.C. sia la causa di tutto. Più probabilmente è solo il primo sintomo di qualcosa che ci portiamo dentro: il retaggio di millenni di nomadismo, una propensione ancestrale ad andarcene da qualche parte dove finalmente saremo soli, saremo puri, saremo noi. Poi ci arriviamo e c'è sempre qualcun altro.
Comments (1)
Le canzoni dei Beatles (#60-51)
07-07-2020, 09:54beatles, musicaPermalinkPuntate precedenti: (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#200-181), (#180-166), (#165-156), (#155-146), (#145-136), (#135-121), (#120-111), (#110-96), (#95-86), (#85-76), (#75-66)
La playlist su Spotify.
50 anni fa... lo sapete benissimo cos'è successo. Invece 80 anni fa nasceva in un sobborgo difficile di Liverpool Richard Starkey, uno dei batteristi più importanti di sempre e un membro dei Beatles per otto anni. Insomma, Ringo è stato un Beatle per un decimo della sua vita; dopodiché ha avuto un altro mezzo secolo per gestire la cosa e non è sempre stato semplice. Comunque ce l'ha fatta, viva Ringo, viva i Beatles. Noi a che punto siamo? Ormai dovrebbero uscire solo canzoni famosissime, tranne...
60. She's Leaving Home (Lennon-McCartney, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967).
Paul McCartney non poteva ricordarselo, ma aveva già stretto la mano a Melanie Coe qualche anno prima di ispirarsi a lei per She's Leaving Home. A 14 anni Melanie aveva partecipato a una gara di imitazioni sul set televisivo di Ready Steady Go: Paul era il giudice e aveva indicato Melanie senza esitazione. Appena tre anni più tardi, la ragazza col massimo dei voti e una pelliccia nell'armadio della cameretta era scappata di casa senza neanche prendere la macchina che i genitori le avevano regalato. Del resto era il 1966, queste cose succedevano dappertutto. In California ormai gli scappati di casa erano legione, di lì a poco qualcuno avrebbe provato a organizzarli in qualcosa di più rivoluzionario, ad es. Charles Manson. She's Leaving Home arrivava insomma esattamente nel momento giusto: quello in cui le preadolescenti della Beatlemania cominciavano a lasciare i genitori. E allo stesso tempo She's Leaving è una mossa disorientante, perché invece di venire incontro a queste quasi-maggiorenni con un prodotto nuovo che assecondi la loro voglia di libertà, pretende di intrattenerli con musica da camera e un approccio deliberatamente crepuscolare. Se il personaggio sembra una Eleanor Rigby che può ancora salvarsi dal suo destino di solitudine e follia, la musica lascia meno spiragli. A tratti sembra che la canzone prenda le parti dei genitori, più che della figlia: ed è proprio in vece dei genitori che parla John Lennon, quel caporal Lennon spiazzante in occhialini e baffi e accenti paterni (o materni): "Le abbiamo dato tutto quello che i soldi potevano comprare!"
Se Sgt Pepper fosse davvero quel che all'inizio prometteva di essere – una riflessione sulla vita di provincia, She's Leaving Home ne rappresenterebbe il momento più inquietante: quello in cui il piccolo mondo della nostalgia comincia a chiudersi intorno alle sue vittime come una sfera di vetro. Povera Melanie, dove credi di andare? Ovunque andrai, arpe e violoncelli saranno lì ad aspettarti, non c'è scampo.I Beatles hanno sempre cercato di proporre cose nuove, e a tratti Sgt. Pepper sembra il momento in cui questa incessante sperimentazione prende loro la mano. Negli ultimi anni hanno sorvolato per gioco continenti nuovi, e adesso vorrebbero esplorarli con più attenzione di quanta l'ascoltatore possa concedere a un gruppo pop in un disco di mezz'ora. L'espediente di trasformare il disco in un carosello di numeri in costume è una mossa geniale ma quasi obbligata, visto l'eterogeneità del materiale. In due o tre casi si ha veramente la sensazione che alcuni universi musicali stiano risucchiando i loro fortuiti scopritori: è il caso di George Harrison, ormai travolto dalla musica indiana in Within You Without You – ma ancora più eclatante è la situazione di Paul con la musica da camera.
Neanche due anni prima George Martin aveva faticato non poco a convincerlo che fosse la soluzione migliore per Yesterday; poi nel giro di pochi mesi Paul aveva composto Eleanor Rigby e ora ormai considerava Martin il suo arrangiatore personale, l'intermediario tra la melodie che aveva in testa e lo spartito. Invece George Martin restava il produttore della Parlophone, con la sua agenda di impegni professionali, e il giorno in cui Paul telefonò perché aveva in testa la musica di She's Leaving Home, Martin aveva un disco più urgente da chiudere (una cosa di Cilla Black a quanto pare). Paul quindi si rivolse a un altro arrangiatore, Mike Leander, cosa di cui poi è stato da tutti rimproverato e in effetti nessuno osa preferire pubblicamente She's Leaving a Eleanor Rigby. A sua difesa, stiamo parlando di un compositore capace di macinare milioni di sterline con le idee che ha in testa, purché qualcuno si sbrigasse a fissarle su carta, visto che lui non ne era capace: She's Leaving poteva essere la nuova Yesterday, ma poteva anche dissolversi da un momento all'altro, la nostra testa ci fa questi scherzi. Anche quella di Paul.

I grandi poeti e i cattivi poeti hanno una caratteristica in comune, che rende difficile distinguerli al primo colpo: l'amore per l'ambiguità. I grandi poeti hanno troppo a cuore la loro poesia per sopportare che si prenda carico di un solo messaggio: deve rimanere aperta, ambigua, ispirare più interpretazioni. Anche i cattivi poeti sono ambigui, semplicemente perché non hanno nessun vero messaggio o comunque non capiscono bene come funziona questa cosa di veicolarlo. Tra i grandi poeti e i cattivi poeti ci sono poi quelli decenti, o se preferite mediocri: quelli che hanno un messaggio e ci tengono a farlo passare. Che tipo di poeta è Paul McCartney? Non saprei, ma sicuramente non è tra i mediocri. Prendi She's Leaving Home: da che parte sta Paul? È giusto scappare di casa, abbandonare chi ha sacrificato tutta la sua vita per te, dedicarsi alla ricerca della felicità, anzi del Divertimento? In teoria sì, basta svegliarsi alle cinque del mattino di un mercoledì e fare quel passo oltre in cancello di casa: la swinging London è là fuori. In teoria. In pratica tre giorni dopo Lei si sta già mettendo nei guai con un venditore di automobili ("man from the Motor Trade). Il riferimento, abbastanza ambiguo da far sospettare che Paul alludesse a un medico abortista, è semplicemente uno di quegli inserti realistici che Paul monta nei suoi versi senza darsi troppo la pena di spiegarli – come ritagli di giornali – e che col tempo si sovraccaricano di senso, perché davvero, tutto riusciamo a immaginarci tranne che le cose finiranno bene con quel "man from the Motor Trade". In seguito nella sua autobiografia Paul avrebbe confermato di aver voluto spargere dello squallore ("sleaziness") sulla coda della canzone: "era solo il tipico personaggio squallido, che avrebbe potuto rimorchiare una ragazzina dicendo: "vuoi un passaggio nella mia macchina, tesoro? Un bell'abitacolo vellutato, ecco come acchiappi le ragazze. Così, era solo un bel tocco di squallore" ("it was just a nice little bit of sleaze").
Questo spiega anche l'altro mistero che tormenta i commentatori di The Beatles Bible: perché Paul canta che l'unica cosa che il denaro non può comprare è il "Divertimento"? È così ineffabile il divertimento? Non era l'Amore la sostanza non misurabile in sterline? Sì, ma Paul l'amore non vuole proprio metterlo stavolta: lo ha sparso in centinaia di canzoni, su Desmond e su Molly, ma alla protagonista di She's Leaving Home il massimo che capita è di "divertirsi". È quasi un avvertimento a tutti i provinciali: potete abbandonare una casa, ma non la provincia. La provincia è dentro di voi: vi seguirà ovunque sarete. Nel mondo vero, Melanie Coe tornò a casa dopo una decina di giorni. Era scappata con il croupier di un casinò locale.
59. Hello Goodbye (Lennon-McCartney, singolo del 1967, poi nella versione USA di Magical Mystery Tour).
 Tu dici di sì, io dico di no. Ogni canzone ha la sua leggenda, questo ormai è chiaro ed è anche il motivo per cui ne stiamo discutendo qui. Ma quand'è che comincia a essere chiaro anche ai Beatles? Un termine importante è l'uscita di Sgt. Pepper, e la ridda di interpretazioni che scatenò. Nel frattempo i Quattro avevano ammesso l'uso di sostanze stupefacenti, e questo aveva scatenato un'ulteriore ondata di esegeti alla ricerca di riferimenti alle droghe. Dopo l'estate del 1967, Lennon e McCartney non potevano più non ignorare che ogni parola delle loro canzoni sarebbe stata sviscerata e interpretata in ogni modo possibile. Qualcun altro si sarebbe bloccato: loro pubblicarono il singolo Hello Goodbye / I Am the Walrus, in cui li osserviamo reagire al medesimo stimolo nei modi più diversi possibile. Per Lennon la deriva intepretativa si risolve con la parodia: Walrus è uno sberleffo a chiunque tenti di interpretarlo. La risposta di McCartney apparentemente è meno ardita: se qualsiasi parola può essere usata contro di me, allora userò le parole più semplici possibile: Hello, Goodbye, se riuscite a trovare droga satanismo e comunismo in Hello Goodbye il problema evidentemente è vostro. Ma questo è solo il livello più superficiale. Ce n'è un altro: in una situazione in cui ogni canzone ormai diventava uno o più racconti (pensate a Lucy in the Sky with Diamonds, che a seconda degli interpreti poteva essere sia l'acrostico di LSD sia il titolo di un disegno infantile), Hello Goodbye è la prima canzone intorno alla quale Paul cerca di costruire un mito d'autore: l'arcinoto episodio secondo il quale Hello Goodbye sarebbe nata all'armonium di casa, da una breve lezione di improvvisazione creativa impartita da McCartney ad Alistair Taylor – già assistente di Brian Epstein e più tardi general manager della Apple.
Tu dici di sì, io dico di no. Ogni canzone ha la sua leggenda, questo ormai è chiaro ed è anche il motivo per cui ne stiamo discutendo qui. Ma quand'è che comincia a essere chiaro anche ai Beatles? Un termine importante è l'uscita di Sgt. Pepper, e la ridda di interpretazioni che scatenò. Nel frattempo i Quattro avevano ammesso l'uso di sostanze stupefacenti, e questo aveva scatenato un'ulteriore ondata di esegeti alla ricerca di riferimenti alle droghe. Dopo l'estate del 1967, Lennon e McCartney non potevano più non ignorare che ogni parola delle loro canzoni sarebbe stata sviscerata e interpretata in ogni modo possibile. Qualcun altro si sarebbe bloccato: loro pubblicarono il singolo Hello Goodbye / I Am the Walrus, in cui li osserviamo reagire al medesimo stimolo nei modi più diversi possibile. Per Lennon la deriva intepretativa si risolve con la parodia: Walrus è uno sberleffo a chiunque tenti di interpretarlo. La risposta di McCartney apparentemente è meno ardita: se qualsiasi parola può essere usata contro di me, allora userò le parole più semplici possibile: Hello, Goodbye, se riuscite a trovare droga satanismo e comunismo in Hello Goodbye il problema evidentemente è vostro. Ma questo è solo il livello più superficiale. Ce n'è un altro: in una situazione in cui ogni canzone ormai diventava uno o più racconti (pensate a Lucy in the Sky with Diamonds, che a seconda degli interpreti poteva essere sia l'acrostico di LSD sia il titolo di un disegno infantile), Hello Goodbye è la prima canzone intorno alla quale Paul cerca di costruire un mito d'autore: l'arcinoto episodio secondo il quale Hello Goodbye sarebbe nata all'armonium di casa, da una breve lezione di improvvisazione creativa impartita da McCartney ad Alistair Taylor – già assistente di Brian Epstein e più tardi general manager della Apple.
Paul lo avrebbe invitato a sedersi di fianco a lui davanti all'organo che teneva nel suo salotto in Cavendish Avenue – confessando inconsciamente la sua necessità di un partner, se non proprio di una specie di gemello cattivo: "Suona una nota e io ne suonerò un altra. E quando io canterò una parola, tu canterai il contrario e ci farò una melodia". Lo stesso Taylor non è mai riuscito del tutto a credere che Paul non avesse già pronta la canzone in testa. McCartney in effetti potrebbe anche aver scoperto la melodia e gli accordi di Hello in quel preciso momento, ma non è questo il punto. Il punto è che sentiva ormai la necessità di raccontarlo: se ogni canzone ha una sua leggenda, significa che prima di incontrare la sua leggenda la canzone è incompiuta: e a Paul non piaceva lasciare le canzoni incompiute. A partire da Hello Goodbye gli capiterà molto spesso di fornire a giornalisti e addetti stampa la corretta interpretazione delle sue canzoni, aggiungendo dettagli che in effetti senza di lui non avremmo mai scoperto: Helter Skelter era una sfida agli Who, Blackbird un omaggio alla lotta della comunità afroamericana per i diritti civili (ma sarà vero?), Let It Be un sogno della madre, eccetera eccetera.
Il fatto che Paul racconti storie non significa che dobbiamo credergli, o non battere altre piste. Per esempio: quattro mesi prima finalmente Lennon era riuscito a imporre una sua canzone sul lato A di un singolo, dopo tre anni di dominio quasi incontrastato di Paul. Si trattava però di un pezzo sui generis, scritto in fretta per la prima trasmissione in mondovisione, All You Need Is Love. Il brano proposto da Paul per la serata era Your Mother Should Know ed effettivamente non avrebbe funzionato altrettanto bene. Il brano di John era perfetto per la circostanza: ecumenico, universale, anche abbastanza facile da capire per i non anglofoni. Magari è solo una circostanza, ma il singolo successivo di Paul è un brano dal testo ancora più semplice, dal contenuto ancora più evanescente ma, a suo modo, altrettanto universale di All You Need.
Anche dal punto di vista musicale, Hello Goodbye mantiene un rapporto speculare con il suo lato B (più apprezzato dai critici, ma senz'altro meno radiofonico). Lennon con Walrus gioca con gli accordi: si ingegna a infilare tutte e sette le note; Paul con Hello mantiene una gabbia di accordi molto più semplice, ma poi si diverte a infiorettarla di soluzioni impreviste. Non tanto sullo spartito (dove comunque proprio dove ti aspetti un banalissimo I (I don't know why) – IV (You say goodbye) – V (I say hello) Paul ti coglie alle spalle sostituendo al IV una... III bemolle, un modo curioso di dirsi addio. Il vero campo di gioco di Hello Goodbye è la sala di registrazione, dove Paul si diverte a pasticciare con qualsiasi trucco, compreso l'eco sulla voce. "L'abbiamo PhilSpectorata!", avrebbe dichiarato in seguito. In seguito avremo tempo per stigmatizzare questa mania di trasformare le canzoni in un patchwork di effetti musicali: ma ascoltare Hello Goodbye è come vedere un bambino felice di aver capito come si usa un giocattolo, che gli vuoi dire a Paul? Che la vita è molto più complessa e drammatica? Se ne accorgerà da solo. Hello è forse l'ultimo momento veramente spensierato della storia dei Beatles, prima che qualcosa cominci a steccare: a partire dal flop televisivo del Magical Mystery Tour.
58. Eight Days a Week (Lennon-McCartney, Beatles For Sale, 1964).
 Uh, ho bisogno del tuo amore, baby... immagino che tu sappia che è vero. La sentite la stanchezza? È nei dettagli, quei pezzi di frase che si inseriscono meccanicamente per completare una canzone, ma non vogliono veramente dire nulla: lunghe zeppe come "guess you know it's true". Spero che tu abbia bisogno del mio amore, baby, proprio come io ho bisogno di te. Non ce la fanno più. Sempre le solite quattro sciocchezze da incidere su due album e quattro singoli all'anno, una trentina di pezzi possibilmente originali e devono tutti dire le stesse cose: Stringimi, amami, non ho altro che amore, baby... "otto giorni alla settimana".
Uh, ho bisogno del tuo amore, baby... immagino che tu sappia che è vero. La sentite la stanchezza? È nei dettagli, quei pezzi di frase che si inseriscono meccanicamente per completare una canzone, ma non vogliono veramente dire nulla: lunghe zeppe come "guess you know it's true". Spero che tu abbia bisogno del mio amore, baby, proprio come io ho bisogno di te. Non ce la fanno più. Sempre le solite quattro sciocchezze da incidere su due album e quattro singoli all'anno, una trentina di pezzi possibilmente originali e devono tutti dire le stesse cose: Stringimi, amami, non ho altro che amore, baby... "otto giorni alla settimana".
Non avesse fatto la rockstar avrebbe avuto qualche potenzialità come pubblicitario, Paul McCartney: per sua ammissione, il titolo era già meta della canzone. "Eight Days a Week" la sentì dire da un tassista. Era perfetto: meno originale di "It's been a hard day's night", ma più diretta. L'idea era la stessa: catturare l'entusiasmo della beatlemania, la frenesia di chi sta cominciando ad arricchirsi e non ha più tempo per riposarsi. Ma ogni entusiasmo deve finire prima o poi, e verso la fine del 1964 i Quattro non ne potevano più. Non provavano nemmeno a fingere il contrario: persino la foto sull'album li mostra un po' provati, persino quel titolo (Beatles For Sale) lascia intendere che stiano speculando su sé stessi e ormai siano agli sgoccioli. Eight Days a Week è una canzone che non hanno mai amato. L'hanno scritta perché avevano bisogno di un pezzo radiofonico per lanciare il disco di Natale in Inghilterra (il quarto album in venti mesi), e un singolo per il mercato americano: ci hanno messo quasi tutte le cose che i fan si aspettavano da loro, i battimani e gli "hold me, love me" e tutto il frasario scemo basato sul concetto "uh ti amo e anche tu mi ami evviva". Ci hanno lavorato con coscienza, perché erano professionisti, e non hanno dimenticato di aggiungere almeno una novità: l'introduzione in fade in, la versione speculare del finale in dissolvenza: la canzone cresce dal silenzio. Insomma hanno fatto tutto quello che dovevano per rendere Eight Days a Week il successo che immancabilmente fu. Ma con la testa erano già altrove. Lo si sente già nel bridge, in quel gorgheggio inatteso (I lo-o-o-o-ove you), ancora abbastanza semplice ma che anticipa le soluzioni barocche che affioreranno nei mesi successivi.
(Ce l'abbiamo fatta, con Eight Days a Week abbiamo completamente coperto Beatles For Sale. È il primo disco che esce dalla gara: un album così sotto lo standard che non contiene nessuna canzone tra le prime cinquanta. Eppure in media è lievemente superiore a With the Beatles, che del resto ha in ballo ancora una sola canzone).
57 Hey Bulldog (Lennon-McCartney, Yellow Submarine, 1968).
C'è un certo tipo di solitudine la cui unità di misura sei tu. Questo, che è uno dei versi più folli e brillanti di tutto il sodalizio Lennon-McCartney, è il risultato di un equivoco: John aveva scritto "in news", non "in you", ma Paul non riusciva a leggere la calligrafia. È questo il vantaggio segreto del lavoro di squadra, quando c'è: la possibilità che abbiamo tutti di fraintenderci e così facendo scoprire qualcosa a cui nessuno dei singoli individui aveva pensato. Hey Bulldog la conoscono soltanto i veri beatlemani, molti dei quali a questo punto sono già sdegnati perché la vorrebbero almeno nella top20. In effetti è una canzone che conserva una freschezza impressionante, ed è lecito domandarsi quanto dipenda dal fatto che per molto tempo è rimasta nel limbo delle rarità – si fa per dire, Yellow Submarine non era certo un disco raro, ma è quel tipo di episodio su cui ti soffermi soltanto se ne hai veramente voglia. Hey Bulldog è invecchiata molto bene, come certi vini ben nascosti in cantina: oppure è stata l'idea di rimettere su Youtube il video in cui i Quattro la incidono. Per molti è stato come ascoltare, finalmente, un nuovo pezzo dei vecchi Beatles.
A differenza di tutti i video farlocchi che potete trovare su Youtube, fabbricati mettendo assieme immagini prese qua e là senza troppo senso, quello di Hey Bulldog è un atto doveroso di filologia audiovisiva, perché è ottenuto rimontando spezzoni del video di Lady Madonna. Quel giorno però John Lennon in particolare non aveva nessuna voglia di fingere di suonare Lady Madonna, che era già stata incisa qualche giorno prima, e quindi propose ai colleghi di lavorare a un'altra canzone, di cui aveva giusto il riff e qualche frase da bofonchiare al microfono. Può anche darsi che non immaginasse una canzone così allegra, ma l'allegria era necessaria, dal momento che mentre provavano Hey Bulldog, i Beatles stavano recitando di suonare Lady Madonna. Doveva chiamarsi Hey Bullfrog: poi Paul si mise ad abbaiare come ai vecchi tempi del Cavern e John non ebbe difficoltà a cambiare al volo in "bulldog". John nel video ha una conformazione pilifera unica, con due basette sul punto di diventare favoriti, e si diverte così tanto a suonare da metterci in confusione: di che anno è questo video? Sembra preso da una linea temporale alternativa dove i Beatles si pettinavano in un modo un po' diverso ma soprattutto hanno continuato a divertirsi a suonare assieme; senza sentire la pressione a cui era sottoposta la più grande band del mondo, senza prendersi per compositori; hanno continuato a pigliare riff semplici e frasi a caso e a confezionarci il pop-rock più divertente mai sentito al mondo, una lezione di leggerezza per tutto il multiverso.
Nel nostro mondo invece i Beatles stavano per partire per l'India, e fa abbastanza impressione pensare che quando sarebbero tornati ognuno si sarebbe messo a lavorare in uno studio separato: qui invece sembra che si divertano a suonare il riff all'unisono, col pianoforte e il basso e due chitarre (se Ringo potesse, suonerebbe lo stesso riff anche lui). Verso la fine si divertono a... divertirsi: al posto di un assolo strumentale, non c'è semplicemente Paul che abbaia e John che lo incita, ma tutta la scenetta di Paul e John che cercano un modo originale di chiudere la canzone e alla fine sono convinti di averlo trovato e sghignazzano dalla soddisfazione. Come quando alla fine di un film ti mostrano il backstage. Il ritornello inverte uno di quelli che stava ormai diventando un loro stilema riconoscibile (la scala cromatica discendente), e riprende da un altro loro esperimento semisconosciuto (You Know My Name) l'idea di ripetere la stessa frase-slogan accelerandola e rallentandola: un espediente che tradisce la strana concezione del tempo di Lennon e riecheggia la buffa metrica della strofa, dove a una frase di due sillabe lunghe ("Sheep/dog") ne segue una di cinque brevi che occupano lo stesso tempo ("stand/ing/ in/ the/ rain"). Un trucco abbastanza originale perfino per i Beatles, che contribuisce a questa sensazione di universo parallelo. Un posto dove, sembra di intuire, è andato tutto un po' meglio che nel nostro. You think you know me, but you haven't got a clue.

56. Back in the U.S.S.R. (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968).
Fammi sentire come fai squillare quella balalaika! Back in the USSR è un allegro pandemonio, anche se le premesse non erano poi così incoraggianti: Ringo a un certo punto non aveva più retto i 'consigli' di Paul su come suonarla e se n'era andato al mare; Paul era passato alla batteria e John al basso ma per ottenere un risultato accettabile si sovraincisero a vicenda così tante volte che nel risultato finale si dovrebbe sentire il contributo di tutti e tre sia al basso, sia alle percussioni, sia alla chitarra. Nel frattempo i carri armati sovietici raggiungevano Praga, ma i Tre erano probabilmente troppo occupati per accorgersene.
Scrivere sui Beatles è complicato: bisogna dribblare tutto quello che è già stato scritto: raccogliere uno spunto qua, interpretarne un altro là e sperare che non salti fuori qualcosa che qualcun altro ha già detto meglio. Scrivere sui Beatles è emozionante: hai la sensazione di partecipare a un grande dibattito che durerà ancora tantissimo tempo, perché se dopo cinquant'anni siamo ancora tutti abbastanza convinti che siano stati la band più importante del secolo, a questo punto ci sono buone speranze che tra un secolo i posteri ne stiano ancora parlando (come noi parliamo di Beethoven, di Dante), e insomma fa un certo effetto pensare che siamo in linea con loro: magari non leggeranno quello che scrivo io, ma continueranno a farsi le stesse domande, come ad esempio: che cos'è l'Unione Sovietica per i Beatles? Un mistero? Una parodia degli USA? Ma è possibile che i Beatles abbiano davvero vissuto al tempo della Guerra Fredda, possibile che lo spettro della mutua distruzione assicurata non abbia lasciato nei loro testi niente più che qualche vago richiamo all'Amore universale?
In effetti, considerato che la Beatlemania scoppia nell'anno del Dottor Stranamore, è impossibile non sospettare una rimozione. Senza scomodare Dylan, che cominciò a scrivere canzoni sui rifugi antiatomici – perfino Mick Jagger ha un catalogo più facile da associare a eventi storici (perlomeno se ascolti Sympathy for the Devil sai che sono morti già due Kennedy). I Beatles queste cose non le facevano: in un primo momento erano soltanto artigiani di canzoni d'amore; in un secondo momento forse perché era bastato concedersi una battuta su Gesù perché in America qualcuno decidesse di mettere al rogo i loro dischi, quindi meglio darsi al surrealismo o a un vago Amore che si potesse intendere nel modo più ecumenico possibile. L'unica canzone di tutto il catalogo in cui si menziona la seconda superpotenza mondiale è un esempio quasi plateale di rimozione: l'Unione Sovietica è solo uno specchio degli States, se solo potessimo andarci ci troveremmo come Alice dall'altra parte dello specchio. Anche loro avranno il rock and roll, da qualche parte ci sarà un posto dove Beach Boys surfano sulle rive del Baltico, le ragazze di Mosca saranno uno sballo come quelle di Amburgo, e c'è sempre una Georgia che mi resta in mente. Nulla di politico, insomma: solo un modo per cominciare il Disco Bianco nel modo più fracassone possibile: che si capisca sin dall'inizio che è una festa (e cosa c'è di più festaiolo dei cori alla fratelli Wilson) e che si indulgerà ancor più del solito nella figura della parodia.
I Beatles non lo sapevano, ma Back in the USSR alla fine sarebbe diventata la più politica delle loro canzoni, proprio in virtù di quel messaggio semplice e inoppugnabile: siamo tutti uguali. Non importano le ideologie e le lingue: siamo uguali nella voglia di tornare a casa che ci assale sull'aeroplano, nella nostalgia delle ragazze di casa e nella voglia di far casino fino all'alba. Forse è vera l'ipotesi di She's Leaving Home: i Beatles sono stati i profeti non già dell'amore, ma del "fun": la contagiosa allegria dei babyboomers occidentali spacciata come un dato naturale, un diritto fondamentale dell'uomo. Mentre la cultura pop continuava a descrivere i compagni come automi indottrinati, Paul semplicemente non riusciva a credere che non fossero dei simpatici compagnoni di bevute. Forse John esagerava a pensare che sarebbe rimasto famoso per più tempo di Cristo, ma in compenso Back in the USSR è durata più dell'Unione Sovietica vera; ci ha messo un po', ma alla fine è riuscito a suonarla nella Piazza Rossa (non è neanche stato il primo).
55. Girl (Lennon-McCartney, Rubber Soul, 1965)
Tetta, tetta, tetta. Dicevamo che con Michelle i Beatles stavano cercando consapevolmente di conquistare il mercato continentale europeo. In effetti la canzone uscì in singolo soltanto in alcuni Paesi europei (tra cui l'Italia): il lato B era Girl, con cui spesso viene paragonata, nel classico derby McCartney/Lennon. E anche in questo caso, se il favore del pubblico va al Lato A di Paul, i critici preferiscono nettamente il numero di John. Sembra più sofferto, sincero, meno stereotipato, ecc. ecc. Senonché, proprio nel momento più drammatico del brano, mentre il bridge sta per convergere sul ritornello, ti accorgi che in sottofondo qualcuno sta cantando in falsetto: "tetta, tetta, tetta". Così, per scherzo. "Era un modo per rilassarci un po' nel bel mezzo di questa grande carriera che stavamo forgiando" (è Paul, nella sua autobiografia). "Quando potevamo metterci qualcosa che fosse un po' sovversivo, lo facevamo. George Martin avrebbe potuto dire; "ma stavate cantando dit dit o tit tit?" "Oh, senz'altro dit dit, George, ma suona un po' come "tetta tetta", vero?" E poi entravamo in macchina e scoppiavamo a ridere". C'è questa componente autoironica, in tutta la storia dei Beatles, che può essere disorientante.
Eppure Lennon con Girl sembrava voler fare sul serio. Il desiderio di comporre un brano "all'europea" è tradito dalla progressione degli accordi nella strofa, più semplice del solito ma ricalcata su un'idea quasi archetipica di ballata cantautorale: la minore, re minore, mi maggiore. È l'unica strofa dei Beatles che avrebbe potuto aver scritto anche un Brassens, anche un De Andrè: quest'ultimo in particolare avrebbe potuto scriverla anche dieci anni dopo. Nel ritornello (un giro di Do neanche troppo camuffato) Lennon ha l'idea di introdurre un nuovo strumento musicale: il sospiro affannoso, anzi, l'aspirazione affannosa (c'è chi ci legge un chiaro riferimento al consumo di cannabis) (c'è chi vede la cannabis dappertutto, e in molti casi è soprattutto negli occhi rossi di chi guarda) (però nel caso dei Beatles del 1965 non è un'ipotesi così azzardata).
L'ultimo tocco europeo, a dire il vero un po' incongruo ma suggestivo, è lo strano effetto 'sirtaki' ottenuto dal raddoppiamento delle chitarre acustiche verso la fine. Anche questa un'idea di Paul, ispirata da una recente vacanza in Grecia. Alla fine anche il John di Girl è un turista dell'esistenzialismo: senz'altro meno sfacciato di Paul, non usa un frasario da turista per provarci con le ragazze locali, ma si apparta in un angolo a contrariarsi per un amore difficile per una donna impossibile che dovrebbe averlo ridotto a uno straccio – un amore che ai biografi non risulta ma vabbe', dettagli. In seguito avrebbe raccontato nelle interviste che "la ragazza che più la vuoi più te ne fa pentire, eppure non rimpiangi un solo giorno" era una prefigurazione di Yoko. E se da una parte fa un po' sorridere questa tendenza a dedicare a tua moglie anche le canzoni che hai scritto prima di conoscerla, l'idea che la Ragazza sia davvero Yoko rende la terza enigmatica strofa un ascolto da brividi. Le fu mai detto, quando era giovane, che il dolore l'avrebbe condotta al piacere? Ha capito cosa intendeva colui che disse che l'uomo deve spezzarsi la schiena per meritarsi un giorno di riposo? Ci crederà ancora, quando lui sarà morto?
54. The End (Lennon-McCartney, ma si sarebbe dovuta attribuire a tutti e Quattro; Abbey Road, 1969).
Oh Yeah! All right! Prima di diventare la Fine dei Beatles, The End era semplicemente il finale del Medley di Abbey Road, e a quanto pare ne è anche il brano più apprezzato dai critici. Curioso, perché è il momento del Medley che assomiglia meno a una canzone e più a un movimento di un brano musicale più complesso. Si tratta di un pezzetto di musica notevole soprattutto per quello che non è: non è un lungo addio, non è una melanconica suite strumentale, non è un pezzo di bravura. The End è molto meno, e questo ce la fa amare molto di più. Questa idea di andarsene alla svelta senza troppe smancerie.
Oh you gonna be my dream tonight. Se davvero The End fosse una jam session – ne ha tutta l'aria, ma diffidiamo – sarebbe probabilmente la jam più breve mai incisa : due minuti (un minuto e mezzo se togliamo la coda). Per fare un confronto con quel che andava per la maggiore in quel periodo si può accostarla ad Apple Jam, il terribile disco che Harrison allegò in omaggio con All Things Must Pass: più di mezz'ora di improvvisazioni strumentali senza capo né coda. Oppure con i brani live sempre più interminabili dei Cream. Già, i Cream.
The End all'inizio si chiamava Ending. Non era necessariamente la Fine dei Beatles, ma avrebbe potuto esserlo. Un momento però: cosa voleva dire "la Fine dei Beatles"?
Oggi abbiamo tutti una certa familiarità col concetto di 'fine di un gruppo'. Può trattarsi di un litigio, meno spesso di una separazione consensuale – sappiamo anche di non doverci fidare troppo, ci sono gruppi che si sono già sciolti tre o quattro volte. Ma nel 1969 tutta questa liturgia non esisteva. Le band erano una relativa novità: nascevano continuamente, spesso cambiavano elementi da un disco all'altro, e altrettanto spesso sparivano dalla circolazione: un disco sbagliato, un contratto finito, e dopo un po' nessuno si chiedeva più se i Them esistessero ancora o no. Al tempo insomma era più un fallimento che un divorzio. Le cose però stavano cambiando, e anche in questo i Beatles avrebbero potuto essere all'avanguardia: la prima band a sciogliersi ufficialmente. Se non che prima di loro c'era già stata una band molto famosa che non solo aveva già concepito il suo scioglimento come un divorzio, ma lo aveva anche messo letteralmente in scena, con tanto di disco e concerto d'addio: i Cream.
Un vero fulmine per la scena rock: persino i Beatles, durati appena otto anni, fecero in tempo a vederli nascere, esplodere come fenomeno commerciale e artistico, e uscire di scena col botto. Come dice il demiurgo in quel film: la luce che arde col doppio di splendore brucia per metà tempo. I Cream si erano dissolti per aver preso una strada che prima dei Beatles non era nemmeno tracciata: il titanismo strumentale. Si erano letteralmente liquefatti in un brodo di jam, risucchiati dai rispettivi ego che portavano Jack Bruce ad alzare sempre più il volume del basso e Ginger Baker a pestare sempre più forte per farsi sentire: una sera Clapton smise semplicemente di suonare, e i due colleghi nemmeno se ne accorsero. Tutto questo in quella manciata di anni in cui questo genere musicale – il blues inglese suonato nell'accezione più virtuosistica – era considerato dai critici un genere commerciale, un cedimento al gusto del pubblico, che evidentemente è molto cambiato: oggi vuole sentire dei finti gangster chiacchierare al microfono, ieri si deliziava di lunghissimi assoli di chitarra, basso e batteria. I Beatles avevano potuto assistere a tutto il fenomeno da una posizione privilegiata, e ora toccava a loro lasciare la scena. I Cream sul lato A di Goodbye avevano salutato il loro pubblico con quindici minuti di improvvisazioni: i Beatles si concessero novanta secondi. The End non è una caricatura degli eccessi del blues rock inglese (come si poteva intendere Yer Blues): anzi tutto il contrario. Se le caricature accentuano proprio gli aspetti eccessivi, The End fa l'esatto opposto, obbligando i quattro strumentisti a dare il meglio di sé in una brevissima unità di tempo, che forse è il più importante stilema dei Beatles: la concisione.
Dopo il rapido assolo di Ringo (il titubante Ringo che sin dall'inizio dell'avventura aveva messo ben chiaro che gli assoli non lo interessavano), i tre chitarristi non solo hanno pochi secondi a disposizione, ma devono cedersi il posto ogni due battute: più che una jam è una coreografia. Alla fine è probabilmente l'unica jam che qualche ascoltatore conosce a memoria, dai primi tom tom di Ringo all'accordo di pianoforte che emerge sul finale. Prima suona Paul, poi George, poi John; di nuovo Paul, di nuovo George, di nuovo John. E per una terza e ultima volta: Paul, George, John. Ognuno cerca per quel che può di descrivere sé stesso con la chitarra. Nessuno ha tempo o spazio per fare cose incredibili: John compensa al suo deficit tecnico con la creatività che contraddistingue i suoi migliori momenti di chitarrista tecnico. "Nessuno di noi", sembrano intendere, "avrebbe molto da dire da solo". Eppure si stanno salutando.
E alla fine l'amore che prendi è uguale all'amore che fai. Il che è molto poetico, apparentemente, ma se ci rifletti non è che significhi granché, è un mccartneysmo da incarto di cioccolatino. A meno che non voglia dire una cosa molto triste: l'amore è un gioco a somma zero, tu porti il tuo, l'Altro porta il suo, e alla fine ve ne tornate con la stessa quantità d'amore con cui eravate partiti. Al che rispettosamente dissento, sir Paul McCartney: l'amore che vi siete fatti è sempre stato di molto superiore alla somma delle parti, e vi ha lasciato senz'altro più ricchi, anche se forse non era facile accorgersene nel 1969. Ma si sa, avevate tutti avuto un anno difficile.
53. Got to Get You Into My Life (Lennon-McCartney, Revolver, 1966)
Ma te l'ho detto che ho bisogno di te ogni singolo giorno della mia vita? A un certo punto sembrava che tutte le canzoni d'amore in realtà parlassero di droga – no, non è stato un certo punto, sono stati tipo trent'anni, da Lucy in the Sky a La mia signorina di Neffa, tutto un estenuante darsi di gomito, uno strizzare l'occhiolino. (In seguito non è che le canzoni abbiano smesso di parlarne, ma almeno sono usciti dalla gabbie dei doppi sensi). È una cosa che ho sempre trovato poco sopportabile, forse perché non mi drogo. In realtà assumo sostanze anche più nocive, ma consentite dalla legge, per cui non c'è gusto a farci i doppi sensi.
Parlare di sostanze stupefacenti in una canzone era coraggioso, diciamo fino al 1968: poi è diventata una soluzione perfino banale, una specie di gioco a protrarre l'adolescenza come se là fuori ci fossero ancora i vostri genitori che si preoccupano se a vent'anni vi fate le canne (nel frattempo i genitori sono scappati a Cuba con la badante sexy e i soldi della vostra università). Per una o due canzoni in cui la dipendenza è descritta in modo mirabile, ce ne sono centinaia che si limitano a vendere un po' di trasgressione ai ragazzini. E più che gli artisti a volte sono proprio i fan che si intestardiscono a cercare riferimenti al fumo e all'acido e all'oppiaceo in qualsiasi brano, come se parlare di stupefacenti fosse intrinsecamente più cool che parlare d'amore o di pace universale o di tasse – quando invece è la cosa più banale e più semplice, si può fare da soli: persino per l'amore bisogna essere almeno in due. E però proprio quando cominciavamo ad abbracciare un sano processo di revisione, proprio quando iniziavamo ad accettare che Lucy in the Sky fosse stata ispirata a un disegno infantile e Cold Turkey raccontasse il decorso di un'intossicazione alimentare, se ne esce bel bello Paul McCartney e avverte il mondo che Got to Get You Into My Life, una delle sue canzoni d'amore più entusiastiche e trascinanti... era dedicata alla cannabis. Alla cannabis. Una droga che forse è stata cool in un semestre del 1965.
Ora. In effetti, se sposti l'attenzione dalla musica al testo, non c'è dubbio che Paul stia parlando di un rapporto ossessivo ("What can I do, what can I say, when I'm with you I want to stay there...") Sulla sincerità di Paul al riguardo non c'è modo di dubitare, visti anche solo i precedenti penali: Paul McCartney è riuscito a farsi sequestrare la marijuana in valigia quasi ovunque, dalla Svezia alle Barbados: una volta l'hanno beccato pure nella sua fattoria scozzese, coi semi sbagliati. L'episodio più famoso è la carcerazione in Giappone nel 1980: dieci giorni e tutte le date saltate. Però è un po' come immaginare che Strangers in the Night parli di un tizio che finalmente scopre le sigarette. Davvero, tutto qui? Paul ha bisogno di cannabinoidi tutti i giorni della sua vita? Se glieli date sarà felice e canterà meravigliose canzoni? C'è qualcuno che considera la canzone migliore, ora che l'abbiamo calata nel contesto indicato dall'autore?
Io no. Anzi ho bisogno di non crederci. Secondo me Got to Get You Into My Life si merita una storia migliore. Ho deciso di credere che parli (come Here, There and Everywhere) di una persona fantastica che Paul incontra proprio perché ha bisogno di cambiare prospettiva: e che decide di amare ogni giorno della sua vita. In effetti sembra proprio Linda Eastman, salvo che... Paul non l'aveva ancora conosciuta. Da cui forse la necessità di una rimozione: dopo aver incontrato Linda, Paul potrebbe avere avuto pudore di una canzone come Got to Get You. Obietterete che è Paul McCartney, e di canzoni in cui giurava eterno amore ne aveva già scritte a quintalate, a partire da Love Me Do (sì, c'è una promessa di eterno amore persino in Love Me Do). Giustissimo, ma Got to Get You è più intima. Forse proprio perché stavolta Paul non promette più niente, stavolta Paul implora. È finito il tempo in cui componeva brevi frasi retoriche per gli innamorati timidi, ora per Paul l'amore non è più un contratto: è un'impellenza fisica, una necessità quotidiana. Una droga? Sì, forse una droga. Ma non necessariamente.
A parte questo, Got to Get You è una straordinaria canzone soul. Come fai a capire quando hai scritto una straordinaria canzone soul? Se te la riprende quasi pari Ella Fitzgerald, ci sono buone possibilità. Se poi te la rileggono gli Earth, Wind and Fire, direi che ci siamo. Una cosa interessante è che Got to Get You non nasce così immediatamente soul: ha un periodo di incubazione in cui mostrava più tracce evidenti di quel gusto vagamente ipnotico-orientale che Paul aveva seminato qua e là in Revolver (l'assolo di Taxman, il melisma di I Want to Tell You). Soprattutto i cori di John, che si sentono in una outtake di Anthology e avrebbero portato la canzone in una direzione sensibilmente diversa (e più vicina ad altri brani revolveriani di John e George). Paul però, lo abbiamo visto, è in grado non solo di inventarsi notevoli soluzioni di arrangiamento, ma anche e soprattutto di scartare quelli che non funzionano abbastanza. Chiunque altro si sarebbe tenuto quei cori, ma Paul voleva qualcosa di più, e così li toglie (proprio come in Can't Buy Me Love, altro brano ripreso dalla Fitzgerald) e sceglie di inserire una trionfale sezione di fiati che diventano il tratto distintivo della canzone.
52. Julia (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968)
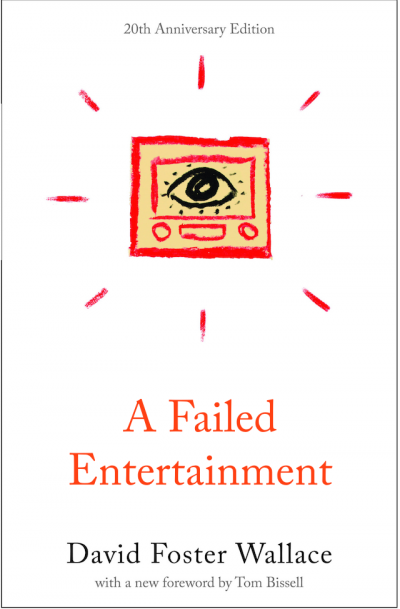 Metà di quel che ho detto non ha senso, ma l'ho detto solo per raggiungerti – questa che sulle pagine di Kahlil Gibran sembra in effetti una mezza scemenza, cantata da Lennon diventa una verità profonda. La trama di Infinite Jest, il mastodontico romanzo di David Foster Wallace, ruota intorno all'Intrattenimento, un breve film che rende chi lo guarda incapace di altro desiderio che non sia continuare a guardarlo. Un simbolo potente della dipendenza, ma cosa c'è davvero in quell'Intrattenimento? Cosa lo rende così irresistibile? Per almeno un migliaio di pagine il lettore non lo sa e non ha neanche molte speranze di impararlo, perché si sa come funziona con questi capolavori postmoderni. Poi quando meno te l'aspetti un personaggio secondario che ha assistito alle riprese lo racconta: [SPOILER] dunque in questo breve film una ragazza bellissima, ma dal volto coperto, spiega allo spettatore che la donna che lo uccide in questa vita è la stessa donna che gli darà vita nella seguente. Le ottiche del film sono realizzate in modo da dare allo spettatore il punto di vista di un bambino: forse di un bambino che sta nascendo. Ecco l'intrattenimento irresistibile: poter nascere/morire senza paura, passando dalla stessa porta, dalla stessa madre [/SPOILER].
Metà di quel che ho detto non ha senso, ma l'ho detto solo per raggiungerti – questa che sulle pagine di Kahlil Gibran sembra in effetti una mezza scemenza, cantata da Lennon diventa una verità profonda. La trama di Infinite Jest, il mastodontico romanzo di David Foster Wallace, ruota intorno all'Intrattenimento, un breve film che rende chi lo guarda incapace di altro desiderio che non sia continuare a guardarlo. Un simbolo potente della dipendenza, ma cosa c'è davvero in quell'Intrattenimento? Cosa lo rende così irresistibile? Per almeno un migliaio di pagine il lettore non lo sa e non ha neanche molte speranze di impararlo, perché si sa come funziona con questi capolavori postmoderni. Poi quando meno te l'aspetti un personaggio secondario che ha assistito alle riprese lo racconta: [SPOILER] dunque in questo breve film una ragazza bellissima, ma dal volto coperto, spiega allo spettatore che la donna che lo uccide in questa vita è la stessa donna che gli darà vita nella seguente. Le ottiche del film sono realizzate in modo da dare allo spettatore il punto di vista di un bambino: forse di un bambino che sta nascendo. Ecco l'intrattenimento irresistibile: poter nascere/morire senza paura, passando dalla stessa porta, dalla stessa madre [/SPOILER].
Julia funziona in un modo simile. Mi piace pensare che Lennon abbia iniziato a scriverla addirittura pensando al figlio Julian – per poi virare immediatamente verso il ricordo della madre – che sfuma immediatamente in quello dell'amante: "Ocean Child", Yoko Ono. Tre persone intorno al cuore, tre generazioni che sono la stessa persona che nasce, muore, rinasce. Il tutto salmodiato sopra quell'arpeggio ipnotico che è il vero tesoro che Lennon ottenne in India: non dal maestro di meditazione Maharishi, ma dal maestro di fingerpicking Donovan. È lo stesso arpeggio infinito che sentiamo in Dear Prudence; lo stesso sul quale un anno dopo Lennon sta ancora cantando Everybody Had a Hard Year. Julia è l'unico brano di tutto il canone beatle che Lennon suona da solo – scartando anche qualche potenzialità armonica scoperta durante le prove: la versione finale è ancora più scarna dei demo. È un brano che può mettere in imbarazzo – quale altro artista, prima o dopo il 1968, avrebbe confessato con altrettanto candore a un pubblico così vasto che per lui madre e amante erano una cosa sola? E doveva ancora cominciare l'analisi.
I posteri si domanderanno se John Lennon abbia veramente posato i piedi sulla nostra stessa terra. Dopotutto Edipo è un mito; Buddha e Gesù Cristo sono più miti che personaggi storici; ma un figlio di un marinaio nato sotto i bombardamenti, squartato emotivamente da un padre che lo vuole in Nuova Zelanda e una madre che lo affida alla sorella; cresciuto da donne, poi orfano; ragazzo terribile in pantaloni attillati; giovane padre, chitarrista cantante e compositore pop, idolo delle teenager e del suo manager omosessuale; tossicomane, poi artista concettuale, leader pacifista sotto inchiesta federale; poeta maledetto, avvistatore di UFO, rockstar in congedo permanente, morto per mano di un fan. Nessun mitografo o evangelista o romanziere postmoderno sarebbe riuscito a inventarsi un personaggio così. Eppure alla fine era solo un ragazzo che diceva quel che provava, come noi evitiamo di fare il più delle volte perché proviamo cose orribili o anche solo imbarazzanti. Julia, figlia dell'oceano, chiamami.
51. And Your Bird Can Sing (Lennon-McCartney, Revolver, 1966).
Quando il tuo uccellino si sarà rotto, lo porterai indietro? Wikipedia ci informa che il twee pop è un sottogenere dell'indiepop caratterizzato da "semplicità e innocenza percepita", "armonie tra voci maschili e femminili", "melodie accattivanti e testi d'amore". Che tra tanti stili i Beatles abbiano anticipato anche il twee appare perfino scontato – in un certo senso il twee è un tentativo di rimanere vicini a quel nucleo di innocenza che durante l'esplosione del rock sembrava essersi nebulizzata nello spazio profondo. Lo stesso Lennon, quando compone il suo brano più apparentemente twee, si sta già guardando indietro: se è mai stato innocente, quel periodo è passato da un pezzo. Addirittura la finta ingenuità del testo riprende uno stilema dylaniano: c'è molto della Queen Jane ritratta sul secondo lato di Highway 61 in questa ragazza ricca di risorse e gadget che prima o poi tornerà da un innamorato che non si fa impressionare. And Your Bird Can Sing manca la top50 di striscio ed è un peccato, ma è in fondo il suo destino di brano-sottovalutato-di-Revolver: un pezzo in cui Lennon non sembrava credere troppo, caratterizzato da un riff sovrabbondante suonato da due chitarre armonizzate (a suonarle nella versione definitiva pare siano Paul e George), che tra tante possibili dimensioni del rock ne esplora una che nel 1966 non era forse ancora immaginabile. Quando la ripescheranno più quindici anni dopo, i Jam sembreranno aver trovato una gemma nascosta. Un altro piccolo tesoro è la "laughing track" di Anthology, in cui Paul e John vengono colti quasi subito da ridarola e non riescono a smettere: stupisce sempre la loro capacità di prendersi in giro da soli, facendo il verso alle proprie canzoni ancora prima di completarle. (Tutti i tentativi di trovare nel testo riferimenti a celebrità supponenti non superano il livello del gossip. La più demenziale evoca addirittura Frank Sinatra e la sua abitudine italianeggiante a riferirsi al sesso maschile col termine "bird". Ma no, nessuno ha mai sentito John o Paul davvero cantare "and your bird can swing").
La playlist su Spotify.
50 anni fa... lo sapete benissimo cos'è successo. Invece 80 anni fa nasceva in un sobborgo difficile di Liverpool Richard Starkey, uno dei batteristi più importanti di sempre e un membro dei Beatles per otto anni. Insomma, Ringo è stato un Beatle per un decimo della sua vita; dopodiché ha avuto un altro mezzo secolo per gestire la cosa e non è sempre stato semplice. Comunque ce l'ha fatta, viva Ringo, viva i Beatles. Noi a che punto siamo? Ormai dovrebbero uscire solo canzoni famosissime, tranne...
60. She's Leaving Home (Lennon-McCartney, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967).
Quando nel Doktor Faustus di Thomas Mann il protagonista (un compositore) incontra il diavolo, una delle prime cose che gli dice è: ma che ci fai in Italia, scusa? A Kaisersachern ti avrei tollerato, ma qui? (Kaisersachern è la tipica piccola città tedesca intrisa di passato in cui il compositore è nato). Il diavolo scuote la testa: se solo tu avessi il coraggio di dire a te stesso: "Dove io sono, lì è Kaisersaschern"...
Paul McCartney non poteva ricordarselo, ma aveva già stretto la mano a Melanie Coe qualche anno prima di ispirarsi a lei per She's Leaving Home. A 14 anni Melanie aveva partecipato a una gara di imitazioni sul set televisivo di Ready Steady Go: Paul era il giudice e aveva indicato Melanie senza esitazione. Appena tre anni più tardi, la ragazza col massimo dei voti e una pelliccia nell'armadio della cameretta era scappata di casa senza neanche prendere la macchina che i genitori le avevano regalato. Del resto era il 1966, queste cose succedevano dappertutto. In California ormai gli scappati di casa erano legione, di lì a poco qualcuno avrebbe provato a organizzarli in qualcosa di più rivoluzionario, ad es. Charles Manson. She's Leaving Home arrivava insomma esattamente nel momento giusto: quello in cui le preadolescenti della Beatlemania cominciavano a lasciare i genitori. E allo stesso tempo She's Leaving è una mossa disorientante, perché invece di venire incontro a queste quasi-maggiorenni con un prodotto nuovo che assecondi la loro voglia di libertà, pretende di intrattenerli con musica da camera e un approccio deliberatamente crepuscolare. Se il personaggio sembra una Eleanor Rigby che può ancora salvarsi dal suo destino di solitudine e follia, la musica lascia meno spiragli. A tratti sembra che la canzone prenda le parti dei genitori, più che della figlia: ed è proprio in vece dei genitori che parla John Lennon, quel caporal Lennon spiazzante in occhialini e baffi e accenti paterni (o materni): "Le abbiamo dato tutto quello che i soldi potevano comprare!"
Se Sgt Pepper fosse davvero quel che all'inizio prometteva di essere – una riflessione sulla vita di provincia, She's Leaving Home ne rappresenterebbe il momento più inquietante: quello in cui il piccolo mondo della nostalgia comincia a chiudersi intorno alle sue vittime come una sfera di vetro. Povera Melanie, dove credi di andare? Ovunque andrai, arpe e violoncelli saranno lì ad aspettarti, non c'è scampo.I Beatles hanno sempre cercato di proporre cose nuove, e a tratti Sgt. Pepper sembra il momento in cui questa incessante sperimentazione prende loro la mano. Negli ultimi anni hanno sorvolato per gioco continenti nuovi, e adesso vorrebbero esplorarli con più attenzione di quanta l'ascoltatore possa concedere a un gruppo pop in un disco di mezz'ora. L'espediente di trasformare il disco in un carosello di numeri in costume è una mossa geniale ma quasi obbligata, visto l'eterogeneità del materiale. In due o tre casi si ha veramente la sensazione che alcuni universi musicali stiano risucchiando i loro fortuiti scopritori: è il caso di George Harrison, ormai travolto dalla musica indiana in Within You Without You – ma ancora più eclatante è la situazione di Paul con la musica da camera.
Neanche due anni prima George Martin aveva faticato non poco a convincerlo che fosse la soluzione migliore per Yesterday; poi nel giro di pochi mesi Paul aveva composto Eleanor Rigby e ora ormai considerava Martin il suo arrangiatore personale, l'intermediario tra la melodie che aveva in testa e lo spartito. Invece George Martin restava il produttore della Parlophone, con la sua agenda di impegni professionali, e il giorno in cui Paul telefonò perché aveva in testa la musica di She's Leaving Home, Martin aveva un disco più urgente da chiudere (una cosa di Cilla Black a quanto pare). Paul quindi si rivolse a un altro arrangiatore, Mike Leander, cosa di cui poi è stato da tutti rimproverato e in effetti nessuno osa preferire pubblicamente She's Leaving a Eleanor Rigby. A sua difesa, stiamo parlando di un compositore capace di macinare milioni di sterline con le idee che ha in testa, purché qualcuno si sbrigasse a fissarle su carta, visto che lui non ne era capace: She's Leaving poteva essere la nuova Yesterday, ma poteva anche dissolversi da un momento all'altro, la nostra testa ci fa questi scherzi. Anche quella di Paul.

I grandi poeti e i cattivi poeti hanno una caratteristica in comune, che rende difficile distinguerli al primo colpo: l'amore per l'ambiguità. I grandi poeti hanno troppo a cuore la loro poesia per sopportare che si prenda carico di un solo messaggio: deve rimanere aperta, ambigua, ispirare più interpretazioni. Anche i cattivi poeti sono ambigui, semplicemente perché non hanno nessun vero messaggio o comunque non capiscono bene come funziona questa cosa di veicolarlo. Tra i grandi poeti e i cattivi poeti ci sono poi quelli decenti, o se preferite mediocri: quelli che hanno un messaggio e ci tengono a farlo passare. Che tipo di poeta è Paul McCartney? Non saprei, ma sicuramente non è tra i mediocri. Prendi She's Leaving Home: da che parte sta Paul? È giusto scappare di casa, abbandonare chi ha sacrificato tutta la sua vita per te, dedicarsi alla ricerca della felicità, anzi del Divertimento? In teoria sì, basta svegliarsi alle cinque del mattino di un mercoledì e fare quel passo oltre in cancello di casa: la swinging London è là fuori. In teoria. In pratica tre giorni dopo Lei si sta già mettendo nei guai con un venditore di automobili ("man from the Motor Trade). Il riferimento, abbastanza ambiguo da far sospettare che Paul alludesse a un medico abortista, è semplicemente uno di quegli inserti realistici che Paul monta nei suoi versi senza darsi troppo la pena di spiegarli – come ritagli di giornali – e che col tempo si sovraccaricano di senso, perché davvero, tutto riusciamo a immaginarci tranne che le cose finiranno bene con quel "man from the Motor Trade". In seguito nella sua autobiografia Paul avrebbe confermato di aver voluto spargere dello squallore ("sleaziness") sulla coda della canzone: "era solo il tipico personaggio squallido, che avrebbe potuto rimorchiare una ragazzina dicendo: "vuoi un passaggio nella mia macchina, tesoro? Un bell'abitacolo vellutato, ecco come acchiappi le ragazze. Così, era solo un bel tocco di squallore" ("it was just a nice little bit of sleaze").
Questo spiega anche l'altro mistero che tormenta i commentatori di The Beatles Bible: perché Paul canta che l'unica cosa che il denaro non può comprare è il "Divertimento"? È così ineffabile il divertimento? Non era l'Amore la sostanza non misurabile in sterline? Sì, ma Paul l'amore non vuole proprio metterlo stavolta: lo ha sparso in centinaia di canzoni, su Desmond e su Molly, ma alla protagonista di She's Leaving Home il massimo che capita è di "divertirsi". È quasi un avvertimento a tutti i provinciali: potete abbandonare una casa, ma non la provincia. La provincia è dentro di voi: vi seguirà ovunque sarete. Nel mondo vero, Melanie Coe tornò a casa dopo una decina di giorni. Era scappata con il croupier di un casinò locale.
59. Hello Goodbye (Lennon-McCartney, singolo del 1967, poi nella versione USA di Magical Mystery Tour).
 Tu dici di sì, io dico di no. Ogni canzone ha la sua leggenda, questo ormai è chiaro ed è anche il motivo per cui ne stiamo discutendo qui. Ma quand'è che comincia a essere chiaro anche ai Beatles? Un termine importante è l'uscita di Sgt. Pepper, e la ridda di interpretazioni che scatenò. Nel frattempo i Quattro avevano ammesso l'uso di sostanze stupefacenti, e questo aveva scatenato un'ulteriore ondata di esegeti alla ricerca di riferimenti alle droghe. Dopo l'estate del 1967, Lennon e McCartney non potevano più non ignorare che ogni parola delle loro canzoni sarebbe stata sviscerata e interpretata in ogni modo possibile. Qualcun altro si sarebbe bloccato: loro pubblicarono il singolo Hello Goodbye / I Am the Walrus, in cui li osserviamo reagire al medesimo stimolo nei modi più diversi possibile. Per Lennon la deriva intepretativa si risolve con la parodia: Walrus è uno sberleffo a chiunque tenti di interpretarlo. La risposta di McCartney apparentemente è meno ardita: se qualsiasi parola può essere usata contro di me, allora userò le parole più semplici possibile: Hello, Goodbye, se riuscite a trovare droga satanismo e comunismo in Hello Goodbye il problema evidentemente è vostro. Ma questo è solo il livello più superficiale. Ce n'è un altro: in una situazione in cui ogni canzone ormai diventava uno o più racconti (pensate a Lucy in the Sky with Diamonds, che a seconda degli interpreti poteva essere sia l'acrostico di LSD sia il titolo di un disegno infantile), Hello Goodbye è la prima canzone intorno alla quale Paul cerca di costruire un mito d'autore: l'arcinoto episodio secondo il quale Hello Goodbye sarebbe nata all'armonium di casa, da una breve lezione di improvvisazione creativa impartita da McCartney ad Alistair Taylor – già assistente di Brian Epstein e più tardi general manager della Apple.
Tu dici di sì, io dico di no. Ogni canzone ha la sua leggenda, questo ormai è chiaro ed è anche il motivo per cui ne stiamo discutendo qui. Ma quand'è che comincia a essere chiaro anche ai Beatles? Un termine importante è l'uscita di Sgt. Pepper, e la ridda di interpretazioni che scatenò. Nel frattempo i Quattro avevano ammesso l'uso di sostanze stupefacenti, e questo aveva scatenato un'ulteriore ondata di esegeti alla ricerca di riferimenti alle droghe. Dopo l'estate del 1967, Lennon e McCartney non potevano più non ignorare che ogni parola delle loro canzoni sarebbe stata sviscerata e interpretata in ogni modo possibile. Qualcun altro si sarebbe bloccato: loro pubblicarono il singolo Hello Goodbye / I Am the Walrus, in cui li osserviamo reagire al medesimo stimolo nei modi più diversi possibile. Per Lennon la deriva intepretativa si risolve con la parodia: Walrus è uno sberleffo a chiunque tenti di interpretarlo. La risposta di McCartney apparentemente è meno ardita: se qualsiasi parola può essere usata contro di me, allora userò le parole più semplici possibile: Hello, Goodbye, se riuscite a trovare droga satanismo e comunismo in Hello Goodbye il problema evidentemente è vostro. Ma questo è solo il livello più superficiale. Ce n'è un altro: in una situazione in cui ogni canzone ormai diventava uno o più racconti (pensate a Lucy in the Sky with Diamonds, che a seconda degli interpreti poteva essere sia l'acrostico di LSD sia il titolo di un disegno infantile), Hello Goodbye è la prima canzone intorno alla quale Paul cerca di costruire un mito d'autore: l'arcinoto episodio secondo il quale Hello Goodbye sarebbe nata all'armonium di casa, da una breve lezione di improvvisazione creativa impartita da McCartney ad Alistair Taylor – già assistente di Brian Epstein e più tardi general manager della Apple.Paul lo avrebbe invitato a sedersi di fianco a lui davanti all'organo che teneva nel suo salotto in Cavendish Avenue – confessando inconsciamente la sua necessità di un partner, se non proprio di una specie di gemello cattivo: "Suona una nota e io ne suonerò un altra. E quando io canterò una parola, tu canterai il contrario e ci farò una melodia". Lo stesso Taylor non è mai riuscito del tutto a credere che Paul non avesse già pronta la canzone in testa. McCartney in effetti potrebbe anche aver scoperto la melodia e gli accordi di Hello in quel preciso momento, ma non è questo il punto. Il punto è che sentiva ormai la necessità di raccontarlo: se ogni canzone ha una sua leggenda, significa che prima di incontrare la sua leggenda la canzone è incompiuta: e a Paul non piaceva lasciare le canzoni incompiute. A partire da Hello Goodbye gli capiterà molto spesso di fornire a giornalisti e addetti stampa la corretta interpretazione delle sue canzoni, aggiungendo dettagli che in effetti senza di lui non avremmo mai scoperto: Helter Skelter era una sfida agli Who, Blackbird un omaggio alla lotta della comunità afroamericana per i diritti civili (ma sarà vero?), Let It Be un sogno della madre, eccetera eccetera.
Il fatto che Paul racconti storie non significa che dobbiamo credergli, o non battere altre piste. Per esempio: quattro mesi prima finalmente Lennon era riuscito a imporre una sua canzone sul lato A di un singolo, dopo tre anni di dominio quasi incontrastato di Paul. Si trattava però di un pezzo sui generis, scritto in fretta per la prima trasmissione in mondovisione, All You Need Is Love. Il brano proposto da Paul per la serata era Your Mother Should Know ed effettivamente non avrebbe funzionato altrettanto bene. Il brano di John era perfetto per la circostanza: ecumenico, universale, anche abbastanza facile da capire per i non anglofoni. Magari è solo una circostanza, ma il singolo successivo di Paul è un brano dal testo ancora più semplice, dal contenuto ancora più evanescente ma, a suo modo, altrettanto universale di All You Need.
Anche dal punto di vista musicale, Hello Goodbye mantiene un rapporto speculare con il suo lato B (più apprezzato dai critici, ma senz'altro meno radiofonico). Lennon con Walrus gioca con gli accordi: si ingegna a infilare tutte e sette le note; Paul con Hello mantiene una gabbia di accordi molto più semplice, ma poi si diverte a infiorettarla di soluzioni impreviste. Non tanto sullo spartito (dove comunque proprio dove ti aspetti un banalissimo I (I don't know why) – IV (You say goodbye) – V (I say hello) Paul ti coglie alle spalle sostituendo al IV una... III bemolle, un modo curioso di dirsi addio. Il vero campo di gioco di Hello Goodbye è la sala di registrazione, dove Paul si diverte a pasticciare con qualsiasi trucco, compreso l'eco sulla voce. "L'abbiamo PhilSpectorata!", avrebbe dichiarato in seguito. In seguito avremo tempo per stigmatizzare questa mania di trasformare le canzoni in un patchwork di effetti musicali: ma ascoltare Hello Goodbye è come vedere un bambino felice di aver capito come si usa un giocattolo, che gli vuoi dire a Paul? Che la vita è molto più complessa e drammatica? Se ne accorgerà da solo. Hello è forse l'ultimo momento veramente spensierato della storia dei Beatles, prima che qualcosa cominci a steccare: a partire dal flop televisivo del Magical Mystery Tour.
58. Eight Days a Week (Lennon-McCartney, Beatles For Sale, 1964).
 Uh, ho bisogno del tuo amore, baby... immagino che tu sappia che è vero. La sentite la stanchezza? È nei dettagli, quei pezzi di frase che si inseriscono meccanicamente per completare una canzone, ma non vogliono veramente dire nulla: lunghe zeppe come "guess you know it's true". Spero che tu abbia bisogno del mio amore, baby, proprio come io ho bisogno di te. Non ce la fanno più. Sempre le solite quattro sciocchezze da incidere su due album e quattro singoli all'anno, una trentina di pezzi possibilmente originali e devono tutti dire le stesse cose: Stringimi, amami, non ho altro che amore, baby... "otto giorni alla settimana".
Uh, ho bisogno del tuo amore, baby... immagino che tu sappia che è vero. La sentite la stanchezza? È nei dettagli, quei pezzi di frase che si inseriscono meccanicamente per completare una canzone, ma non vogliono veramente dire nulla: lunghe zeppe come "guess you know it's true". Spero che tu abbia bisogno del mio amore, baby, proprio come io ho bisogno di te. Non ce la fanno più. Sempre le solite quattro sciocchezze da incidere su due album e quattro singoli all'anno, una trentina di pezzi possibilmente originali e devono tutti dire le stesse cose: Stringimi, amami, non ho altro che amore, baby... "otto giorni alla settimana".Non avesse fatto la rockstar avrebbe avuto qualche potenzialità come pubblicitario, Paul McCartney: per sua ammissione, il titolo era già meta della canzone. "Eight Days a Week" la sentì dire da un tassista. Era perfetto: meno originale di "It's been a hard day's night", ma più diretta. L'idea era la stessa: catturare l'entusiasmo della beatlemania, la frenesia di chi sta cominciando ad arricchirsi e non ha più tempo per riposarsi. Ma ogni entusiasmo deve finire prima o poi, e verso la fine del 1964 i Quattro non ne potevano più. Non provavano nemmeno a fingere il contrario: persino la foto sull'album li mostra un po' provati, persino quel titolo (Beatles For Sale) lascia intendere che stiano speculando su sé stessi e ormai siano agli sgoccioli. Eight Days a Week è una canzone che non hanno mai amato. L'hanno scritta perché avevano bisogno di un pezzo radiofonico per lanciare il disco di Natale in Inghilterra (il quarto album in venti mesi), e un singolo per il mercato americano: ci hanno messo quasi tutte le cose che i fan si aspettavano da loro, i battimani e gli "hold me, love me" e tutto il frasario scemo basato sul concetto "uh ti amo e anche tu mi ami evviva". Ci hanno lavorato con coscienza, perché erano professionisti, e non hanno dimenticato di aggiungere almeno una novità: l'introduzione in fade in, la versione speculare del finale in dissolvenza: la canzone cresce dal silenzio. Insomma hanno fatto tutto quello che dovevano per rendere Eight Days a Week il successo che immancabilmente fu. Ma con la testa erano già altrove. Lo si sente già nel bridge, in quel gorgheggio inatteso (I lo-o-o-o-ove you), ancora abbastanza semplice ma che anticipa le soluzioni barocche che affioreranno nei mesi successivi.
(Ce l'abbiamo fatta, con Eight Days a Week abbiamo completamente coperto Beatles For Sale. È il primo disco che esce dalla gara: un album così sotto lo standard che non contiene nessuna canzone tra le prime cinquanta. Eppure in media è lievemente superiore a With the Beatles, che del resto ha in ballo ancora una sola canzone).
57 Hey Bulldog (Lennon-McCartney, Yellow Submarine, 1968).
C'è un certo tipo di solitudine la cui unità di misura sei tu. Questo, che è uno dei versi più folli e brillanti di tutto il sodalizio Lennon-McCartney, è il risultato di un equivoco: John aveva scritto "in news", non "in you", ma Paul non riusciva a leggere la calligrafia. È questo il vantaggio segreto del lavoro di squadra, quando c'è: la possibilità che abbiamo tutti di fraintenderci e così facendo scoprire qualcosa a cui nessuno dei singoli individui aveva pensato. Hey Bulldog la conoscono soltanto i veri beatlemani, molti dei quali a questo punto sono già sdegnati perché la vorrebbero almeno nella top20. In effetti è una canzone che conserva una freschezza impressionante, ed è lecito domandarsi quanto dipenda dal fatto che per molto tempo è rimasta nel limbo delle rarità – si fa per dire, Yellow Submarine non era certo un disco raro, ma è quel tipo di episodio su cui ti soffermi soltanto se ne hai veramente voglia. Hey Bulldog è invecchiata molto bene, come certi vini ben nascosti in cantina: oppure è stata l'idea di rimettere su Youtube il video in cui i Quattro la incidono. Per molti è stato come ascoltare, finalmente, un nuovo pezzo dei vecchi Beatles.
A differenza di tutti i video farlocchi che potete trovare su Youtube, fabbricati mettendo assieme immagini prese qua e là senza troppo senso, quello di Hey Bulldog è un atto doveroso di filologia audiovisiva, perché è ottenuto rimontando spezzoni del video di Lady Madonna. Quel giorno però John Lennon in particolare non aveva nessuna voglia di fingere di suonare Lady Madonna, che era già stata incisa qualche giorno prima, e quindi propose ai colleghi di lavorare a un'altra canzone, di cui aveva giusto il riff e qualche frase da bofonchiare al microfono. Può anche darsi che non immaginasse una canzone così allegra, ma l'allegria era necessaria, dal momento che mentre provavano Hey Bulldog, i Beatles stavano recitando di suonare Lady Madonna. Doveva chiamarsi Hey Bullfrog: poi Paul si mise ad abbaiare come ai vecchi tempi del Cavern e John non ebbe difficoltà a cambiare al volo in "bulldog". John nel video ha una conformazione pilifera unica, con due basette sul punto di diventare favoriti, e si diverte così tanto a suonare da metterci in confusione: di che anno è questo video? Sembra preso da una linea temporale alternativa dove i Beatles si pettinavano in un modo un po' diverso ma soprattutto hanno continuato a divertirsi a suonare assieme; senza sentire la pressione a cui era sottoposta la più grande band del mondo, senza prendersi per compositori; hanno continuato a pigliare riff semplici e frasi a caso e a confezionarci il pop-rock più divertente mai sentito al mondo, una lezione di leggerezza per tutto il multiverso.
Nel nostro mondo invece i Beatles stavano per partire per l'India, e fa abbastanza impressione pensare che quando sarebbero tornati ognuno si sarebbe messo a lavorare in uno studio separato: qui invece sembra che si divertano a suonare il riff all'unisono, col pianoforte e il basso e due chitarre (se Ringo potesse, suonerebbe lo stesso riff anche lui). Verso la fine si divertono a... divertirsi: al posto di un assolo strumentale, non c'è semplicemente Paul che abbaia e John che lo incita, ma tutta la scenetta di Paul e John che cercano un modo originale di chiudere la canzone e alla fine sono convinti di averlo trovato e sghignazzano dalla soddisfazione. Come quando alla fine di un film ti mostrano il backstage. Il ritornello inverte uno di quelli che stava ormai diventando un loro stilema riconoscibile (la scala cromatica discendente), e riprende da un altro loro esperimento semisconosciuto (You Know My Name) l'idea di ripetere la stessa frase-slogan accelerandola e rallentandola: un espediente che tradisce la strana concezione del tempo di Lennon e riecheggia la buffa metrica della strofa, dove a una frase di due sillabe lunghe ("Sheep/dog") ne segue una di cinque brevi che occupano lo stesso tempo ("stand/ing/ in/ the/ rain"). Un trucco abbastanza originale perfino per i Beatles, che contribuisce a questa sensazione di universo parallelo. Un posto dove, sembra di intuire, è andato tutto un po' meglio che nel nostro. You think you know me, but you haven't got a clue.

56. Back in the U.S.S.R. (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968).
Fammi sentire come fai squillare quella balalaika! Back in the USSR è un allegro pandemonio, anche se le premesse non erano poi così incoraggianti: Ringo a un certo punto non aveva più retto i 'consigli' di Paul su come suonarla e se n'era andato al mare; Paul era passato alla batteria e John al basso ma per ottenere un risultato accettabile si sovraincisero a vicenda così tante volte che nel risultato finale si dovrebbe sentire il contributo di tutti e tre sia al basso, sia alle percussioni, sia alla chitarra. Nel frattempo i carri armati sovietici raggiungevano Praga, ma i Tre erano probabilmente troppo occupati per accorgersene.
Scrivere sui Beatles è complicato: bisogna dribblare tutto quello che è già stato scritto: raccogliere uno spunto qua, interpretarne un altro là e sperare che non salti fuori qualcosa che qualcun altro ha già detto meglio. Scrivere sui Beatles è emozionante: hai la sensazione di partecipare a un grande dibattito che durerà ancora tantissimo tempo, perché se dopo cinquant'anni siamo ancora tutti abbastanza convinti che siano stati la band più importante del secolo, a questo punto ci sono buone speranze che tra un secolo i posteri ne stiano ancora parlando (come noi parliamo di Beethoven, di Dante), e insomma fa un certo effetto pensare che siamo in linea con loro: magari non leggeranno quello che scrivo io, ma continueranno a farsi le stesse domande, come ad esempio: che cos'è l'Unione Sovietica per i Beatles? Un mistero? Una parodia degli USA? Ma è possibile che i Beatles abbiano davvero vissuto al tempo della Guerra Fredda, possibile che lo spettro della mutua distruzione assicurata non abbia lasciato nei loro testi niente più che qualche vago richiamo all'Amore universale?
In effetti, considerato che la Beatlemania scoppia nell'anno del Dottor Stranamore, è impossibile non sospettare una rimozione. Senza scomodare Dylan, che cominciò a scrivere canzoni sui rifugi antiatomici – perfino Mick Jagger ha un catalogo più facile da associare a eventi storici (perlomeno se ascolti Sympathy for the Devil sai che sono morti già due Kennedy). I Beatles queste cose non le facevano: in un primo momento erano soltanto artigiani di canzoni d'amore; in un secondo momento forse perché era bastato concedersi una battuta su Gesù perché in America qualcuno decidesse di mettere al rogo i loro dischi, quindi meglio darsi al surrealismo o a un vago Amore che si potesse intendere nel modo più ecumenico possibile. L'unica canzone di tutto il catalogo in cui si menziona la seconda superpotenza mondiale è un esempio quasi plateale di rimozione: l'Unione Sovietica è solo uno specchio degli States, se solo potessimo andarci ci troveremmo come Alice dall'altra parte dello specchio. Anche loro avranno il rock and roll, da qualche parte ci sarà un posto dove Beach Boys surfano sulle rive del Baltico, le ragazze di Mosca saranno uno sballo come quelle di Amburgo, e c'è sempre una Georgia che mi resta in mente. Nulla di politico, insomma: solo un modo per cominciare il Disco Bianco nel modo più fracassone possibile: che si capisca sin dall'inizio che è una festa (e cosa c'è di più festaiolo dei cori alla fratelli Wilson) e che si indulgerà ancor più del solito nella figura della parodia.
I Beatles non lo sapevano, ma Back in the USSR alla fine sarebbe diventata la più politica delle loro canzoni, proprio in virtù di quel messaggio semplice e inoppugnabile: siamo tutti uguali. Non importano le ideologie e le lingue: siamo uguali nella voglia di tornare a casa che ci assale sull'aeroplano, nella nostalgia delle ragazze di casa e nella voglia di far casino fino all'alba. Forse è vera l'ipotesi di She's Leaving Home: i Beatles sono stati i profeti non già dell'amore, ma del "fun": la contagiosa allegria dei babyboomers occidentali spacciata come un dato naturale, un diritto fondamentale dell'uomo. Mentre la cultura pop continuava a descrivere i compagni come automi indottrinati, Paul semplicemente non riusciva a credere che non fossero dei simpatici compagnoni di bevute. Forse John esagerava a pensare che sarebbe rimasto famoso per più tempo di Cristo, ma in compenso Back in the USSR è durata più dell'Unione Sovietica vera; ci ha messo un po', ma alla fine è riuscito a suonarla nella Piazza Rossa (non è neanche stato il primo).
55. Girl (Lennon-McCartney, Rubber Soul, 1965)
Tetta, tetta, tetta. Dicevamo che con Michelle i Beatles stavano cercando consapevolmente di conquistare il mercato continentale europeo. In effetti la canzone uscì in singolo soltanto in alcuni Paesi europei (tra cui l'Italia): il lato B era Girl, con cui spesso viene paragonata, nel classico derby McCartney/Lennon. E anche in questo caso, se il favore del pubblico va al Lato A di Paul, i critici preferiscono nettamente il numero di John. Sembra più sofferto, sincero, meno stereotipato, ecc. ecc. Senonché, proprio nel momento più drammatico del brano, mentre il bridge sta per convergere sul ritornello, ti accorgi che in sottofondo qualcuno sta cantando in falsetto: "tetta, tetta, tetta". Così, per scherzo. "Era un modo per rilassarci un po' nel bel mezzo di questa grande carriera che stavamo forgiando" (è Paul, nella sua autobiografia). "Quando potevamo metterci qualcosa che fosse un po' sovversivo, lo facevamo. George Martin avrebbe potuto dire; "ma stavate cantando dit dit o tit tit?" "Oh, senz'altro dit dit, George, ma suona un po' come "tetta tetta", vero?" E poi entravamo in macchina e scoppiavamo a ridere". C'è questa componente autoironica, in tutta la storia dei Beatles, che può essere disorientante.
Eppure Lennon con Girl sembrava voler fare sul serio. Il desiderio di comporre un brano "all'europea" è tradito dalla progressione degli accordi nella strofa, più semplice del solito ma ricalcata su un'idea quasi archetipica di ballata cantautorale: la minore, re minore, mi maggiore. È l'unica strofa dei Beatles che avrebbe potuto aver scritto anche un Brassens, anche un De Andrè: quest'ultimo in particolare avrebbe potuto scriverla anche dieci anni dopo. Nel ritornello (un giro di Do neanche troppo camuffato) Lennon ha l'idea di introdurre un nuovo strumento musicale: il sospiro affannoso, anzi, l'aspirazione affannosa (c'è chi ci legge un chiaro riferimento al consumo di cannabis) (c'è chi vede la cannabis dappertutto, e in molti casi è soprattutto negli occhi rossi di chi guarda) (però nel caso dei Beatles del 1965 non è un'ipotesi così azzardata).
L'ultimo tocco europeo, a dire il vero un po' incongruo ma suggestivo, è lo strano effetto 'sirtaki' ottenuto dal raddoppiamento delle chitarre acustiche verso la fine. Anche questa un'idea di Paul, ispirata da una recente vacanza in Grecia. Alla fine anche il John di Girl è un turista dell'esistenzialismo: senz'altro meno sfacciato di Paul, non usa un frasario da turista per provarci con le ragazze locali, ma si apparta in un angolo a contrariarsi per un amore difficile per una donna impossibile che dovrebbe averlo ridotto a uno straccio – un amore che ai biografi non risulta ma vabbe', dettagli. In seguito avrebbe raccontato nelle interviste che "la ragazza che più la vuoi più te ne fa pentire, eppure non rimpiangi un solo giorno" era una prefigurazione di Yoko. E se da una parte fa un po' sorridere questa tendenza a dedicare a tua moglie anche le canzoni che hai scritto prima di conoscerla, l'idea che la Ragazza sia davvero Yoko rende la terza enigmatica strofa un ascolto da brividi. Le fu mai detto, quando era giovane, che il dolore l'avrebbe condotta al piacere? Ha capito cosa intendeva colui che disse che l'uomo deve spezzarsi la schiena per meritarsi un giorno di riposo? Ci crederà ancora, quando lui sarà morto?
54. The End (Lennon-McCartney, ma si sarebbe dovuta attribuire a tutti e Quattro; Abbey Road, 1969).
Oh Yeah! All right! Prima di diventare la Fine dei Beatles, The End era semplicemente il finale del Medley di Abbey Road, e a quanto pare ne è anche il brano più apprezzato dai critici. Curioso, perché è il momento del Medley che assomiglia meno a una canzone e più a un movimento di un brano musicale più complesso. Si tratta di un pezzetto di musica notevole soprattutto per quello che non è: non è un lungo addio, non è una melanconica suite strumentale, non è un pezzo di bravura. The End è molto meno, e questo ce la fa amare molto di più. Questa idea di andarsene alla svelta senza troppe smancerie.
Oh you gonna be my dream tonight. Se davvero The End fosse una jam session – ne ha tutta l'aria, ma diffidiamo – sarebbe probabilmente la jam più breve mai incisa : due minuti (un minuto e mezzo se togliamo la coda). Per fare un confronto con quel che andava per la maggiore in quel periodo si può accostarla ad Apple Jam, il terribile disco che Harrison allegò in omaggio con All Things Must Pass: più di mezz'ora di improvvisazioni strumentali senza capo né coda. Oppure con i brani live sempre più interminabili dei Cream. Già, i Cream.
The End all'inizio si chiamava Ending. Non era necessariamente la Fine dei Beatles, ma avrebbe potuto esserlo. Un momento però: cosa voleva dire "la Fine dei Beatles"?
Oggi abbiamo tutti una certa familiarità col concetto di 'fine di un gruppo'. Può trattarsi di un litigio, meno spesso di una separazione consensuale – sappiamo anche di non doverci fidare troppo, ci sono gruppi che si sono già sciolti tre o quattro volte. Ma nel 1969 tutta questa liturgia non esisteva. Le band erano una relativa novità: nascevano continuamente, spesso cambiavano elementi da un disco all'altro, e altrettanto spesso sparivano dalla circolazione: un disco sbagliato, un contratto finito, e dopo un po' nessuno si chiedeva più se i Them esistessero ancora o no. Al tempo insomma era più un fallimento che un divorzio. Le cose però stavano cambiando, e anche in questo i Beatles avrebbero potuto essere all'avanguardia: la prima band a sciogliersi ufficialmente. Se non che prima di loro c'era già stata una band molto famosa che non solo aveva già concepito il suo scioglimento come un divorzio, ma lo aveva anche messo letteralmente in scena, con tanto di disco e concerto d'addio: i Cream.
Un vero fulmine per la scena rock: persino i Beatles, durati appena otto anni, fecero in tempo a vederli nascere, esplodere come fenomeno commerciale e artistico, e uscire di scena col botto. Come dice il demiurgo in quel film: la luce che arde col doppio di splendore brucia per metà tempo. I Cream si erano dissolti per aver preso una strada che prima dei Beatles non era nemmeno tracciata: il titanismo strumentale. Si erano letteralmente liquefatti in un brodo di jam, risucchiati dai rispettivi ego che portavano Jack Bruce ad alzare sempre più il volume del basso e Ginger Baker a pestare sempre più forte per farsi sentire: una sera Clapton smise semplicemente di suonare, e i due colleghi nemmeno se ne accorsero. Tutto questo in quella manciata di anni in cui questo genere musicale – il blues inglese suonato nell'accezione più virtuosistica – era considerato dai critici un genere commerciale, un cedimento al gusto del pubblico, che evidentemente è molto cambiato: oggi vuole sentire dei finti gangster chiacchierare al microfono, ieri si deliziava di lunghissimi assoli di chitarra, basso e batteria. I Beatles avevano potuto assistere a tutto il fenomeno da una posizione privilegiata, e ora toccava a loro lasciare la scena. I Cream sul lato A di Goodbye avevano salutato il loro pubblico con quindici minuti di improvvisazioni: i Beatles si concessero novanta secondi. The End non è una caricatura degli eccessi del blues rock inglese (come si poteva intendere Yer Blues): anzi tutto il contrario. Se le caricature accentuano proprio gli aspetti eccessivi, The End fa l'esatto opposto, obbligando i quattro strumentisti a dare il meglio di sé in una brevissima unità di tempo, che forse è il più importante stilema dei Beatles: la concisione.
Dopo il rapido assolo di Ringo (il titubante Ringo che sin dall'inizio dell'avventura aveva messo ben chiaro che gli assoli non lo interessavano), i tre chitarristi non solo hanno pochi secondi a disposizione, ma devono cedersi il posto ogni due battute: più che una jam è una coreografia. Alla fine è probabilmente l'unica jam che qualche ascoltatore conosce a memoria, dai primi tom tom di Ringo all'accordo di pianoforte che emerge sul finale. Prima suona Paul, poi George, poi John; di nuovo Paul, di nuovo George, di nuovo John. E per una terza e ultima volta: Paul, George, John. Ognuno cerca per quel che può di descrivere sé stesso con la chitarra. Nessuno ha tempo o spazio per fare cose incredibili: John compensa al suo deficit tecnico con la creatività che contraddistingue i suoi migliori momenti di chitarrista tecnico. "Nessuno di noi", sembrano intendere, "avrebbe molto da dire da solo". Eppure si stanno salutando.
E alla fine l'amore che prendi è uguale all'amore che fai. Il che è molto poetico, apparentemente, ma se ci rifletti non è che significhi granché, è un mccartneysmo da incarto di cioccolatino. A meno che non voglia dire una cosa molto triste: l'amore è un gioco a somma zero, tu porti il tuo, l'Altro porta il suo, e alla fine ve ne tornate con la stessa quantità d'amore con cui eravate partiti. Al che rispettosamente dissento, sir Paul McCartney: l'amore che vi siete fatti è sempre stato di molto superiore alla somma delle parti, e vi ha lasciato senz'altro più ricchi, anche se forse non era facile accorgersene nel 1969. Ma si sa, avevate tutti avuto un anno difficile.
53. Got to Get You Into My Life (Lennon-McCartney, Revolver, 1966)
Ma te l'ho detto che ho bisogno di te ogni singolo giorno della mia vita? A un certo punto sembrava che tutte le canzoni d'amore in realtà parlassero di droga – no, non è stato un certo punto, sono stati tipo trent'anni, da Lucy in the Sky a La mia signorina di Neffa, tutto un estenuante darsi di gomito, uno strizzare l'occhiolino. (In seguito non è che le canzoni abbiano smesso di parlarne, ma almeno sono usciti dalla gabbie dei doppi sensi). È una cosa che ho sempre trovato poco sopportabile, forse perché non mi drogo. In realtà assumo sostanze anche più nocive, ma consentite dalla legge, per cui non c'è gusto a farci i doppi sensi.
Parlare di sostanze stupefacenti in una canzone era coraggioso, diciamo fino al 1968: poi è diventata una soluzione perfino banale, una specie di gioco a protrarre l'adolescenza come se là fuori ci fossero ancora i vostri genitori che si preoccupano se a vent'anni vi fate le canne (nel frattempo i genitori sono scappati a Cuba con la badante sexy e i soldi della vostra università). Per una o due canzoni in cui la dipendenza è descritta in modo mirabile, ce ne sono centinaia che si limitano a vendere un po' di trasgressione ai ragazzini. E più che gli artisti a volte sono proprio i fan che si intestardiscono a cercare riferimenti al fumo e all'acido e all'oppiaceo in qualsiasi brano, come se parlare di stupefacenti fosse intrinsecamente più cool che parlare d'amore o di pace universale o di tasse – quando invece è la cosa più banale e più semplice, si può fare da soli: persino per l'amore bisogna essere almeno in due. E però proprio quando cominciavamo ad abbracciare un sano processo di revisione, proprio quando iniziavamo ad accettare che Lucy in the Sky fosse stata ispirata a un disegno infantile e Cold Turkey raccontasse il decorso di un'intossicazione alimentare, se ne esce bel bello Paul McCartney e avverte il mondo che Got to Get You Into My Life, una delle sue canzoni d'amore più entusiastiche e trascinanti... era dedicata alla cannabis. Alla cannabis. Una droga che forse è stata cool in un semestre del 1965.
Ora. In effetti, se sposti l'attenzione dalla musica al testo, non c'è dubbio che Paul stia parlando di un rapporto ossessivo ("What can I do, what can I say, when I'm with you I want to stay there...") Sulla sincerità di Paul al riguardo non c'è modo di dubitare, visti anche solo i precedenti penali: Paul McCartney è riuscito a farsi sequestrare la marijuana in valigia quasi ovunque, dalla Svezia alle Barbados: una volta l'hanno beccato pure nella sua fattoria scozzese, coi semi sbagliati. L'episodio più famoso è la carcerazione in Giappone nel 1980: dieci giorni e tutte le date saltate. Però è un po' come immaginare che Strangers in the Night parli di un tizio che finalmente scopre le sigarette. Davvero, tutto qui? Paul ha bisogno di cannabinoidi tutti i giorni della sua vita? Se glieli date sarà felice e canterà meravigliose canzoni? C'è qualcuno che considera la canzone migliore, ora che l'abbiamo calata nel contesto indicato dall'autore?
Io no. Anzi ho bisogno di non crederci. Secondo me Got to Get You Into My Life si merita una storia migliore. Ho deciso di credere che parli (come Here, There and Everywhere) di una persona fantastica che Paul incontra proprio perché ha bisogno di cambiare prospettiva: e che decide di amare ogni giorno della sua vita. In effetti sembra proprio Linda Eastman, salvo che... Paul non l'aveva ancora conosciuta. Da cui forse la necessità di una rimozione: dopo aver incontrato Linda, Paul potrebbe avere avuto pudore di una canzone come Got to Get You. Obietterete che è Paul McCartney, e di canzoni in cui giurava eterno amore ne aveva già scritte a quintalate, a partire da Love Me Do (sì, c'è una promessa di eterno amore persino in Love Me Do). Giustissimo, ma Got to Get You è più intima. Forse proprio perché stavolta Paul non promette più niente, stavolta Paul implora. È finito il tempo in cui componeva brevi frasi retoriche per gli innamorati timidi, ora per Paul l'amore non è più un contratto: è un'impellenza fisica, una necessità quotidiana. Una droga? Sì, forse una droga. Ma non necessariamente.
A parte questo, Got to Get You è una straordinaria canzone soul. Come fai a capire quando hai scritto una straordinaria canzone soul? Se te la riprende quasi pari Ella Fitzgerald, ci sono buone possibilità. Se poi te la rileggono gli Earth, Wind and Fire, direi che ci siamo. Una cosa interessante è che Got to Get You non nasce così immediatamente soul: ha un periodo di incubazione in cui mostrava più tracce evidenti di quel gusto vagamente ipnotico-orientale che Paul aveva seminato qua e là in Revolver (l'assolo di Taxman, il melisma di I Want to Tell You). Soprattutto i cori di John, che si sentono in una outtake di Anthology e avrebbero portato la canzone in una direzione sensibilmente diversa (e più vicina ad altri brani revolveriani di John e George). Paul però, lo abbiamo visto, è in grado non solo di inventarsi notevoli soluzioni di arrangiamento, ma anche e soprattutto di scartare quelli che non funzionano abbastanza. Chiunque altro si sarebbe tenuto quei cori, ma Paul voleva qualcosa di più, e così li toglie (proprio come in Can't Buy Me Love, altro brano ripreso dalla Fitzgerald) e sceglie di inserire una trionfale sezione di fiati che diventano il tratto distintivo della canzone.
52. Julia (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968)
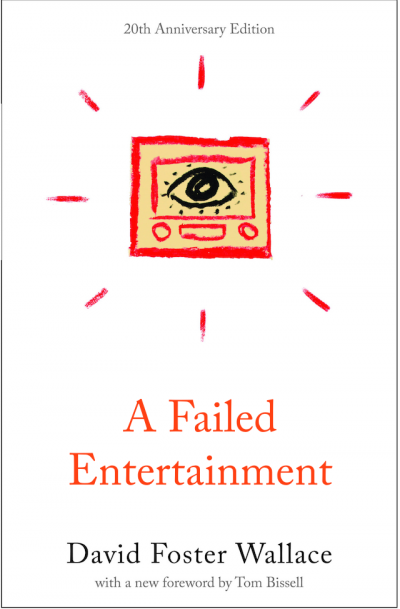 Metà di quel che ho detto non ha senso, ma l'ho detto solo per raggiungerti – questa che sulle pagine di Kahlil Gibran sembra in effetti una mezza scemenza, cantata da Lennon diventa una verità profonda. La trama di Infinite Jest, il mastodontico romanzo di David Foster Wallace, ruota intorno all'Intrattenimento, un breve film che rende chi lo guarda incapace di altro desiderio che non sia continuare a guardarlo. Un simbolo potente della dipendenza, ma cosa c'è davvero in quell'Intrattenimento? Cosa lo rende così irresistibile? Per almeno un migliaio di pagine il lettore non lo sa e non ha neanche molte speranze di impararlo, perché si sa come funziona con questi capolavori postmoderni. Poi quando meno te l'aspetti un personaggio secondario che ha assistito alle riprese lo racconta: [SPOILER] dunque in questo breve film una ragazza bellissima, ma dal volto coperto, spiega allo spettatore che la donna che lo uccide in questa vita è la stessa donna che gli darà vita nella seguente. Le ottiche del film sono realizzate in modo da dare allo spettatore il punto di vista di un bambino: forse di un bambino che sta nascendo. Ecco l'intrattenimento irresistibile: poter nascere/morire senza paura, passando dalla stessa porta, dalla stessa madre [/SPOILER].
Metà di quel che ho detto non ha senso, ma l'ho detto solo per raggiungerti – questa che sulle pagine di Kahlil Gibran sembra in effetti una mezza scemenza, cantata da Lennon diventa una verità profonda. La trama di Infinite Jest, il mastodontico romanzo di David Foster Wallace, ruota intorno all'Intrattenimento, un breve film che rende chi lo guarda incapace di altro desiderio che non sia continuare a guardarlo. Un simbolo potente della dipendenza, ma cosa c'è davvero in quell'Intrattenimento? Cosa lo rende così irresistibile? Per almeno un migliaio di pagine il lettore non lo sa e non ha neanche molte speranze di impararlo, perché si sa come funziona con questi capolavori postmoderni. Poi quando meno te l'aspetti un personaggio secondario che ha assistito alle riprese lo racconta: [SPOILER] dunque in questo breve film una ragazza bellissima, ma dal volto coperto, spiega allo spettatore che la donna che lo uccide in questa vita è la stessa donna che gli darà vita nella seguente. Le ottiche del film sono realizzate in modo da dare allo spettatore il punto di vista di un bambino: forse di un bambino che sta nascendo. Ecco l'intrattenimento irresistibile: poter nascere/morire senza paura, passando dalla stessa porta, dalla stessa madre [/SPOILER].Julia funziona in un modo simile. Mi piace pensare che Lennon abbia iniziato a scriverla addirittura pensando al figlio Julian – per poi virare immediatamente verso il ricordo della madre – che sfuma immediatamente in quello dell'amante: "Ocean Child", Yoko Ono. Tre persone intorno al cuore, tre generazioni che sono la stessa persona che nasce, muore, rinasce. Il tutto salmodiato sopra quell'arpeggio ipnotico che è il vero tesoro che Lennon ottenne in India: non dal maestro di meditazione Maharishi, ma dal maestro di fingerpicking Donovan. È lo stesso arpeggio infinito che sentiamo in Dear Prudence; lo stesso sul quale un anno dopo Lennon sta ancora cantando Everybody Had a Hard Year. Julia è l'unico brano di tutto il canone beatle che Lennon suona da solo – scartando anche qualche potenzialità armonica scoperta durante le prove: la versione finale è ancora più scarna dei demo. È un brano che può mettere in imbarazzo – quale altro artista, prima o dopo il 1968, avrebbe confessato con altrettanto candore a un pubblico così vasto che per lui madre e amante erano una cosa sola? E doveva ancora cominciare l'analisi.
I posteri si domanderanno se John Lennon abbia veramente posato i piedi sulla nostra stessa terra. Dopotutto Edipo è un mito; Buddha e Gesù Cristo sono più miti che personaggi storici; ma un figlio di un marinaio nato sotto i bombardamenti, squartato emotivamente da un padre che lo vuole in Nuova Zelanda e una madre che lo affida alla sorella; cresciuto da donne, poi orfano; ragazzo terribile in pantaloni attillati; giovane padre, chitarrista cantante e compositore pop, idolo delle teenager e del suo manager omosessuale; tossicomane, poi artista concettuale, leader pacifista sotto inchiesta federale; poeta maledetto, avvistatore di UFO, rockstar in congedo permanente, morto per mano di un fan. Nessun mitografo o evangelista o romanziere postmoderno sarebbe riuscito a inventarsi un personaggio così. Eppure alla fine era solo un ragazzo che diceva quel che provava, come noi evitiamo di fare il più delle volte perché proviamo cose orribili o anche solo imbarazzanti. Julia, figlia dell'oceano, chiamami.
51. And Your Bird Can Sing (Lennon-McCartney, Revolver, 1966).
Quando il tuo uccellino si sarà rotto, lo porterai indietro? Wikipedia ci informa che il twee pop è un sottogenere dell'indiepop caratterizzato da "semplicità e innocenza percepita", "armonie tra voci maschili e femminili", "melodie accattivanti e testi d'amore". Che tra tanti stili i Beatles abbiano anticipato anche il twee appare perfino scontato – in un certo senso il twee è un tentativo di rimanere vicini a quel nucleo di innocenza che durante l'esplosione del rock sembrava essersi nebulizzata nello spazio profondo. Lo stesso Lennon, quando compone il suo brano più apparentemente twee, si sta già guardando indietro: se è mai stato innocente, quel periodo è passato da un pezzo. Addirittura la finta ingenuità del testo riprende uno stilema dylaniano: c'è molto della Queen Jane ritratta sul secondo lato di Highway 61 in questa ragazza ricca di risorse e gadget che prima o poi tornerà da un innamorato che non si fa impressionare. And Your Bird Can Sing manca la top50 di striscio ed è un peccato, ma è in fondo il suo destino di brano-sottovalutato-di-Revolver: un pezzo in cui Lennon non sembrava credere troppo, caratterizzato da un riff sovrabbondante suonato da due chitarre armonizzate (a suonarle nella versione definitiva pare siano Paul e George), che tra tante possibili dimensioni del rock ne esplora una che nel 1966 non era forse ancora immaginabile. Quando la ripescheranno più quindici anni dopo, i Jam sembreranno aver trovato una gemma nascosta. Un altro piccolo tesoro è la "laughing track" di Anthology, in cui Paul e John vengono colti quasi subito da ridarola e non riescono a smettere: stupisce sempre la loro capacità di prendersi in giro da soli, facendo il verso alle proprie canzoni ancora prima di completarle. (Tutti i tentativi di trovare nel testo riferimenti a celebrità supponenti non superano il livello del gossip. La più demenziale evoca addirittura Frank Sinatra e la sua abitudine italianeggiante a riferirsi al sesso maschile col termine "bird". Ma no, nessuno ha mai sentito John o Paul davvero cantare "and your bird can swing").
Comments (2)
Scuola di ballo al sole
06-07-2020, 09:48cinema, coccodrilli, musica, PasoliniPermalinkCe ne sarebbe da dire, ma
Ennio Morricone (10/11/1928, 6/7/2020).
Ennio Morricone (10/11/1928, 6/7/2020).
Le canzoni dei Beatles (#70-61)
01-07-2020, 03:16beatles, musicaPermalinkCinquant'anni fa i Beatles erano ormai ufficialmente sciolti. Cinquant'anni dopo, Paul McCartney ha partecipato a una raccolta fondi suonando When the Saints Go Marchin' In con la tromba, lo strumento con cui ha iniziato a fare musica da bambino (e che deve ancora perfezionare, diciamo). E in effetti c'è qualcosa di trombettista, a volerlo sentire, in certe sue linee di basso: quel modo un po' bandistico in cui cerca di tenere insieme ritmo e melodia. Nel frattempo noi andiamo avanti con la classifica, ormai siamo agli sgoccioli, mancano soltanto... 70 canzoni.
Puntate precedenti: (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#200-181), (#180-166), (#165-156), (#155-146), (#145-136), (#135-121), (#120-111), (#110-96), (#95-86), (#85-76).
70. Twist and Shout (Bert Berns – Phil Medley; incisa dai Beatles in Please Please Me, 1963).
Torciti e urla. E se dopo aver inciso il primo disco avessero preso anche loro l'aereo sbagliato, quel tipo di aereo che nel 1959 avevano preso Buddy Holly e Ritchie Valens? Ci ricorderemmo ancora di quel simpatico quartetto protagonista di un breve revival inglese del rock'n'roll, i Beatles? Forse no: per rimanere nel Libro devi diventare grande in America, il che sarebbe successo solo qualche settimana dopo. O forse sì, perché per passare alla Storia a volte basta un pezzo solo: pensa ai Trashmen! (chi?) Ma come chi, quelli di Surfin' Bird. O i Kingsmen, (chi?) quelli che registrarono Louie Louie così male che la gente ci sentiva dentro qualsiasi cosaccia le dettasse l'immaginazione e la FBI aprì un'inchiesta, storia vera. O a Chubby Checker di cui nessuno saprebbe citare tre pezzi in fila, ma almeno due twist li conoscono tutti. O Ritchie Valens, che quell'aereo lo prese davvero (aveva solo 17 anni!), ma aveva fatto in tempo a incidere La Bamba, e tanto ci basta. Anche perché Twist and Shout altro non è che la Bamba formato twist, scritta da due autori (Bert Berns e Phil Medley) che volevano proprio mettere insieme le due cose, ma poi passata a Phil Spector che immancabilmente insieme alle due cose voleva infilarcene tantissime altre, sicché la Twist and Shout dei Top Notes, la prima in assoluto (1961), sembra già un cross-over, una parodia. Ma Berns non si diede per vinto e alla fine riuscì a farla incidere come l'aveva in mente a un terzetto di reduci del twist, gli Isley Brothers.
Dopodiché forse Twist and Shout esiste già in natura, in fin dei conti cosa c'è di più naturale della progressione I-IV-V, cosa suona più spontaneo all'orecchio umano di un passaggio dal primo accordo al quinto, magari con una breve sosta al quarto per creare un po' di tensione? E però prima che Valens portasse La Bamba alla radio, l'idea non era venuta a nessuno e anche dopo ci mise un po' ad attecchire: gli Isley Brothers con la loro Twist and Shout rividero la Top40, e tutto sarebbe finito lì se un anno dopo un John Lennon rauco e febbricitante non avesse deciso di terminare le 15 ore di session del suo primo album riprendendo Twist and Shout con la stessa violenza autolesionista con cui la sparava contro le basse volute di mattoni del Cavern Club. Se avesse inciso anche soltanto quel pezzo, John Lennon sarebbe... uno sconosciuto, dal nome oscuro quanto quello dei cantanti che coverizzarono Bird is the World o Louie Louie. Ma quella voce, la sua voce avrebbe fatto il giro del mondo, e lui forse sarebbe impazzito dall'imbarazzo perché c'è qualcosa di osceno in quella voce, e lui non scherzava quando affermava di odiarla.
Twist and Shout avrebbe reso qualsiasi gruppo di sconosciuti una one-hit-wonder e forse avrebbe avuto più senso così, in fondo è quel che resta di un brano tradizionale messicano infilato da un autore professionista in uno stampino commerciale già esausto (il twist), poi ripreso nel quartiere a luci rosse di Amburgo da un oscuro gruppo di rocker inglesi dalla tonsille devastate dalla nicotina, trasformato in uno sguaiato inno alla dissoluzione che porta finalmente il rock'n'roll in un nuovo decennio. Il felpato professionismo dei vocalist americani viene riletto da un mancato mozzo di Liverpool che canta ogni verso come fosse l'ultimo senza sapere se riuscirà ad arrivare alla nota più alta – in effetti non è che ci arrivi realmente, la sua blue note non è un ammiccamento, è uno sforzo disperato di un chitarrista che torce le corde vocali come fossero corde della sua chitarra. Quel mancato mozzo e i suoi colleghi sciamannati diventeranno poi la band più famosa del mondo, scrivendo e cantando brani diversissimi ma tutti più complicati di Twist and Shout: però alla fine anche solo Twist and Shout ci sarebbe bastata. Non voglio dire che sia il più grande brano del rock, ma l'ultima volta che ho controllato il più grande brano del rock aveva come ritornello una versione un po' più lenta e rantolante di Twist and Shout. Tutto grazie a Lennon. E a Bert Burns. E a Valens (ma non a Phil Spector).
69. Two of Us, Lennon-McCartney, Let It Be, 1970).
We're on our way home. We're going home. Potenza del contesto. Registrata da qualsiasi altro artista in qualsiasi altro disco, Two of Us probabilmente non mi avrebbe detto un granché. Inserita da Lennon e McCartney all'inizio del loro disco postumo, Two of Us mi commuove. Non importa aver letto dappertutto che i "due di noi" erano Paul e Linda in gita in campagna. Nella mia testa i due vagabondi in impermeabile che scrivono cartoline accostandole ai muri non possono che essere Paul e John. Hanno ricordi più intricati della strada che hanno percorso, stanno tornando a casa da qualcosa che dalla distanza sembra una guerra. Comunque è finita, il nemico è battuto, non c'è più bisogno di litigare. Stanno tornando a casa e sarebbe bello se ci tornassero assieme. Sappiamo che non è così ma per un attimo vogliamo crederci. La storia dei Beatles è la storia di un'amicizia: è questo che la rende struggente e ci fa tornare sempre sul luogo del misfatto, anche se sappiamo come va a finire. Si può assistere a Romeo e Giulietta per cento volte e maledire ugualmente quel frate che si attarda con un messaggio importantissimo nella bisaccia: si può ascoltare Two of Us cento volte e continuare a domandarsi: perché non avete fatto la pace quando eravate ancora in tempo?
Paul nel periodo di Let It Be è sospeso tra tentazioni quasi jazzistiche e un impulso a semplificare gli arrangiamenti – anche per ridurre al minimo le discussioni coi colleghi coinvolti in un delicatissimo divorzio a quattro. Two of Us cattura questa tensione: una canzoncina apparentemente facile, suonata alla buona, con un bridge che all'improvviso si impenna – un improvviso sussulto di orgoglio, che rientra subito nei ranghi. Ma alla fine è la cosa migliore del brano, ed è anche quella a cui John dedicò più impegno, perché armonizzare sulla "strada che si allunga là fuori" gli costava effettivamente fatica ma almeno era una sfida. Potenza del contesto: Two of Us cattura la dolcezza dell'incontrare un vecchio amico con cui hai litigato ma gli vuoi comunque bene ma ci hai pur sempre litigato. Ma se l'avesse incisa qualcun altro, in qualsiasi altro disco, non ci avrei mai fatto caso.
(Nella versione di Let It Be Naked, mi pare che McCartney si limiti a tagliare la presentazione sardonica di John: "I Dig a Pygmy', di Charles Hawtrey e the Deaf Aids ... Prima parte, in cui Doris si procura la carota". Un'ottima idea: la frase in questione non era riferita alla canzone, ma era una delle sciocchezze che Lennon lanciava al microfono nelle pause sigaretta; Phil Spector probabilmente voleva suggerire l'idea di una registrazione estemporanea, ma introdurre la prima canzone che parla sicuramente di Linda con il greve doppiosenso di "Doris gets her oats" era un bel colpo sotto la cintura).
68. Lady Madonna (Lennon-McCartney, singolo del febbraio 1968).
See how they run, come corrono, 'sti ragazzi. Che cosa ci si aspettava dai Beatles all'inizio dell'anno di grazia 1968? Che continuassero a essere la più grande band del mondo, apprezzata da grandi e piccini; però anche innovativi, come erano sempre stati e certo non potevano smettere di esserlo proprio ora. D'altro canto dopo alcune sbandate situazioniste e psichedeliche sarebbe stato apprezzato anche un certo ritorno all'ordine, al rock'n'roll; però sempre garbato, per le urla sguaiate c'erano già Stones e Who. In vista della rivoluzione un po' di realismo sociale non avrebbe guastato, sempre condito da quell'ottimismo che era indelebilmente associato alla loro immagine pubblica. Ci si aspettava tutto questo dai Beatles, all'inizio del 1968: e Paul McCartney, infallibilmente, lo consegnò entro la scadenza: giusto in tempo per accompagnare in India chi andava alla ricerca di sé stesso.
Sul serio: non c'è nessuna promessa che i Beatles avessero fatto fin qui che Lady Madonna non mantenga, e te lo fa pure sembrare facile. È un pezzo allegro, ma il testo a pensarci bene è triste (ed è anche uno dei più riusciti testi di Paul, il migliore dei suoi bozzetti liverpooliani). È un ritorno al sano e vecchio rock'n'roll, o almeno così fu considerato dai critici che non sapevano bene cosa pensarne; c'era in effetti nell'aria una certa sensazione di stanchezza per le follie del '67. Il disco psichedelico degli Stones aveva lasciato tutti perplessi, Bob Dylan aveva appena pubblicato un disco spogliato all'osso ed enigmatico come John Wesley Harding. Ma a dire il vero Lady Madonna non rappresenta nessuna inversione di rotta, anzi chiarisce sempre di più la vocazione di Paul e soci per il pastiche, il numero in costume: quindi sì, c'è un bel rock pianistico alla Fats Domino nella strofa, ma il bridge si sposta sui territori swing che Paul ha iniziato a esplorare con When I'm 64, per impennare sul finale ("See how they run") con un ricordo di quei cori barocchi che erano un marchio di fabbrica della casa dai tempi di Paperback Writer. Anche l'arrangiamento sembra voler tenere i piedi in due scarpe, professionismo e giocoleria: Paul convocherà una sezione di ottoni ma non offrirà loro nessuno spartito da suonare: non solo, ma lui e gli altri ragazzacci si metteranno a scimmiottare gli ottoni in sordina con le voci in falsetto. A un certo punto un sassofonista esasperato produrrà un assolo free che si accompagna perfettamente all'allegra concitazione raccontata dal testo. Non solo Lady Madonna è in perfetta continuità con le trovate di scena e il bozzettismo di Sgt Pepper, ma dimostra che rispetto a Sgt Pepper le idee sono persino più chiare, gli arrangiamenti più nitidi, Paul più ispirato. Tutto quello che ci si aspettava dai Beatles, Lady Madonna lo forniva in due minuti e mezzo: di fronte a questa strabiliante dimostrazione di superiorità offerta da un Paul McCartney che aveva appena incassato il fiasco televisivo del Magical Mystery Tour, come reagì il pubblico?
Tiepidamente.
Oddio, il disco lo comprarono – però non arrivò mai al primo posto nella classifica americana, un caso abbastanza raro per i Beatles. Non aiutava il Lato B – The Inner Light, la composizione indiana meno compromissoria di George Harrison. Fu in assoluto il singolo meno lennoniano della storia dei Beatles – insoddisfatto dalla resa di Across the Universe, John aveva fatto un grande passo indietro. Ma insomma il relativo insuccesso di Lady Madonna dimostrava quello che i Beatles già prima di partire per l'India sapevano: non si poteva fare meglio di così. I Beatles avevano abituato il loro pubblico a un livello di qualità e innovazione impossibile da garantire ancora a lungo. Ormai ci si aspettava da loro con cadenza semestrale un capolavoro o un cambio di paradigma, o entrambe le cose insieme. Lady Madonna è uno dei brani dei Beatles che più si avvicina all'antico concetto di standard, quelle canzoni che conosci da sempre e puoi ascoltare tutti i giorni senza stancartene. Pur mantenendo un'impronta visibile del loro autore, gli standard possono essere rifatti da qualsiasi interprete e non tradiscono mai. Persino Fats Domino incise Lady Madonna, visto che tutti dicevano che sembrava un pezzo suo. Ne fece una buona versione in cui non cambiava praticamente nulla: il più grande complimento che Fats potesse fare a Paul McCartney. Ma sul serio, cosa puoi cambiare in Lady Madonna? Per Lennon era un pezzo "che non andava da nessuna parte". In un certo senso è vero: non c'era più nessuna parte dove andare, Lady Madonna si limita a mantenere la posizione. La gente si aspettava qualcosa di più, ma cosa?
67. Carry That Weight (Lennon-McCartney, Abbey Road, 1969)
Oh boy, questo peso te lo porterai addosso per un bel po' di tempo. Qualche settimana dopo, quando John Lennon manifestò l'intenzione di lasciare dal gruppo, disse, testuale: "voglio un divorzio". Se ci pensate, è terribile – qualsiasi divorzio lo è. Un matrimonio può finire, capita ai migliori. Ma un divorzio è per sempre. Ti segna la vita: non puoi smettere di essere divorziato: c'è un prima e c'è un dopo. E non capita a tutti – sposarsi, quello sì è alla portata di tutti. Sposarsi ti rende simile a chiunque altro, ma divorziare, quando capita, è come se capitasse solo a voi. Dovrete conviverci per tanto, tanto tempo. E dire che Paul ci aveva appena promesso di cantarci una ninna nanna. Invece, senza preavviso, parte un coro da stadio – la voce di Ringo è in evidenza, il ricordo di Yellow Submarine si inserisce subliminalmente, insieme a un presagio: questa cosa ce la porteremo addosso a lungo. E così siamo agli sgoccioli, e queste patetiche carte che ci stanno allontanando, queste ripicche da ragazzi, queste scemenze da avvocati sono il casus belli che ci dividerà per sempre, qualcosa per cui tutto il mondo ci rimprovererà finché campiamo, e alcuni di noi camperanno a lungo (per una macabra coincidenza, sono i due che cantano il coro).
Per tutte le volte che lo abbiamo accusato di inventarsi storie inutili, bisogna riconoscergli che nel momento in cui qualcuno doveva raccontare l'episodio più doloroso, è stato proprio Paul a non tirarsi indietro. E solo Paul del resto avrebbe potuto riuscirci – tutta l'esperienza maturata con le sue canzoni del disamore, alla fine gli ha permesso di realizzare con You Never Give Me Your Money e Carry That Weight un dittico di sincerità disarmante.
66. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Lennon-McCartney, nell'album omonimo, 1967)

È successo vent'anni fa oggi. Ci sono cose quasi impossibili da catturare con una macchina fotografica, o un registratore, o una videocamera. Per esempio, il momento in cui cresciamo – impossibile, lo facciamo troppo lentamente. La nostra prima nostalgia, il primo caso in cui ci voltiamo indietro: salvo che quando l'abbiamo vissuto non ce ne rendevamo conto, che era il primo. Oppure: il momento in cui nasce una moda. Il problema è che non nascono mai veramente, è tutto un perenne divenire. Londra, che a metà anni '60 era diventata il punto di riferimento della moda giovanile, tra 1966 e 1967 impose un brusco cambiamento di rotta, deciso non si sa bene da chi – probabilmente nessuno. In ogni caso, nel giro di qualche mese si passò da uno stile modernista, ispirato dalla corsa allo spazio e dalla op art, a un improvviso interesse per la chincaglieria del passato – all'improvviso Portobello invase Carnaby Street. Il perché non è chiaro e non è chiaro neanche il percome: la storia della moda procede un po' per narrazioni orali, poi ogni tanto qualcuno fa una mostra retrospettiva e una serie di collezioni, messe in fila, sembrano assumere un significato.
Non come la storia della musica, in cui almeno sai quali dischi hanno venduto e quali ti tiravano dietro: nella moda è tutto un successo fino a prova contraria e le prove nessuno le ha. Alla fine forse l'istantanea più affidabile di quel particolare momento è proprio quella scattata dai Beatles all'inizio del loro disco più ambizioso e colorato – pochi mesi prima, l'elegante Revolver si era concluso con il brano più avantgarde mai inciso dai Quattro, Tomorrow Never Knows. Il disco nuovo si presenta diversissimo già dalla copertina, eccessivamente variopinta: i Beatles non sono più gli unici protagonisti, anzi non sono mai stati così piccoli, vestiti da buffoni e circondati da un gruppo di celebrità intergenerazionale; come se il mondo degli adulti finalmente si fosse degnato di accoglierli. Quanto alla musica, beh – il primo brano sembra un rock piuttosto duro per il 1967, in linea con quanto suggeriva già Revolver nell'anno precedente. McCartney canta con la tipica foga little-richardiana su una nota sola: oggi non avremmo difficoltà a considerarlo un rap. È un suono brutalista e moderno: racchiude l'energia ribelle di una generazione e... dura sedici battute.
Poi partono gli ottoni.
Un pubblico finto reagisce con stupore; poi si mette a ridere. Ma è un disco o un musical? È come se i Beatles crescessero in quell'esatto momento: un istante impossibile da fermare sulla pellicola o sul nastro. Tutto quello che era importante un attimo prima... non lo è più. Molto altro bolle in pentola, avremo una sezione di ottoni e tanti numeri in costume. Sì, eravamo la rock band più importante del mondo, l'anno scorso. Adesso siamo qualcosa di nuovo, ma anche di vecchio. Qualcosa che comunque vi piacerà, sedetevi e godetevi lo show.
Succede tutto in pochi secondi. Il brano, a dire il vero, dopo l'inserto di ottoni continua a rockeggiare come se niente fosse. Invece è cambiato tutto, quello che nel 1966 era avanguardia ora è solo una posa fra tante. Nei negozi è arrivata roba nuova – che in realtà a guardare bene è roba vecchia, buffe giacche e vestiti di vent'anni fa. La guerra era appena finita, papà McCartney suonava vecchi standard jazz al pianoforte, mamma Lennon strimpellava il banjo, il Sergente Pepper insegnava alla sua banda a suonare. Possibile che nel 1967, mentre compitava parole a caso per il nuovo disco, Paul McCartney conoscesse già la Regola dei Vent'anni, quel teorema del consumo per cui nel momento in cui ogni generazione comincia a guardarsi indietro, il punto in cui si fissa è situato di solito vent'anni prima? Fino a poco prima forse guardarsi indietro non conveniva: c'era la guerra, razionamenti e bombardamenti. Nel 1967 all'improvviso è come se si aprissero gli archivi: tutto il passato diventa riciclabile, ricolorabile, interessante. La parola "postmoderno" è ancora un tecnicismo accademico: i Beatles non sono stati ancora informati ma sono già i più postmoderni di tutti. C'è però un prezzo da pagare; il nuovo disco sarà pieno di musica di ogni genere, ma il rock per ora è sospeso: confinato nel brano di esordio e nella ripresa sul secondo lato. Come se fosse un genere ancora troppo moderno per essere rivisitato.
65. You're Going to Lose That Girl (Lennon-McCartney, Help!, 1965)
"Mi farò un punto d'onore di portarla via da te". Cosa ci fa così in alto You're Going to Lose That Girl? Non lo so. È soprattutto colpa di Rolling Stone, nella loro classifica questo pezzo di Help! sta addirittura intorno al trentesimo posto. Eppure è uno dei brani meno innovativi del disco, un deciso sguardo indietro ai fasti della Beatlemania. Inserito nell'edizione inglese del disco tra due brani come Another Girl e Ticket to Ride, che mostravano ormai un approccio affettivo più adulto e libertino, You're Going ci precipita per un momento nella beatlesfera di due anni prima, quell'indistinta balera in cui i ragazzi vanno a corteggiare le ragazze con l'obiettivo di stringerne le mani tremanti. È il mondo che abbiamo iniziato a conoscere con She Loves You, di cui però You're Going to Lose rappresenta il capovolgimento: se in quel caso il cantante si dava da fare per ricongiungere due innamorati che un "l'orgoglio" aveva separato, qui la coppia ormai è entrata nella fase inerziale in cui non c'è neanche più bisogno di uscire. Salvo che il cantante non ci sta: se non la porti fuori stasera, amico mio, ci penserò io e la tratterò bene ("c-cosa stai facendo?" canta il coro, meno complice del solito). Sono passati soltanto due anni, eppure sembra già una rimpatriata, un pezzo alla vecchia maniera con John che si atteggia a corteggiatore consumato, salvo impennarsi verso il bridge con un falsetto che, l'avesse cantato qualsiasi altro cantante, ci lascerebbe parecchio perplessi.
Anche stavolta, il trucco per trovare un po' di profondità nella canzone è immaginare che Lennon sia entrambi i ragazzi (proprio come in This Boy): quello che tratta male la sua ragazza e quello che dice a sé stesso: se continui così, la perderai. (Qualche anno più tardi, ma è un dettaglio che non c'entra molto con la musica, Lennon avrebbe chiesto ad Alex Mardas di provarci con sua moglie, probabilmente per dargli un appiglio nella causa per il divorzio) (ancora qualche anno più tardi, quando non riusciva più a reggere il problematico partner, sarebbe stata Yoko Ono a chiedere alla segretaria di sostituirla nella complessa funzione di fidanzata) (ma questo è gossip alla fine, il rifugio del critico musicale che non sa più cosa raccontare) (non è neanche colpa mia, cosa ci fa questa canzoncina così in alto, appena sotto a...)
64. Sexy Sadie (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968).
Saxy Sadie, ma come hai fatto? Per te ogni uomo è uscito matto. C'è qualcosa che stona in Sexy Sadie. Probabilmente è il pianoforte, inciso più lentamente e poi accelerato – sì, Sexy Sadie fa parte di quel cospicuo insieme di canzoni che Lennon immaginava un po' più lente del risultato finale. La dissonanza del piano è il punctum del brano, la qualità che rende Sexy Sadie riconoscibile anche dopo pochi secondi. Un'altra qualità sconcertante di Sexy Sadie è l'inversione tra strofa e bridge – il secondo, se provate per una volta ad ascoltarlo da solo, è molto più cantabile e trascinante della prima, e porta un entusiasmo così solare che adombrerebbe persino certi brani di McCartney ("One sunny day, the world was waiting for a lover"). Eppure Lennon non ha mai pensato di invertire strofa e bridge: tutto questo entusiasmo solare, sin dall'inizio, era messo tra virgolette. Il risultato è un brano che per un minuto sembra prigioniero di una ruota di accordi scanditi dal piano che sembrano non avere un inizio o una fine – scivolano l'uno nell'altro in una matassa logica ma in cui non riesci a trovare il bandolo – finché il bridge non ti trova una possibile via di uscita che però ti riconduce presto allo stesso punto dove stavi annaspando un momento prima. Sexy Sadie, ma come facevi a saperlo?
Col Disco Bianco John Lennon diventa la persona che preferiamo tutti ricordare. Perfino da un punto di vista iconico, il Lennon più famoso resta quello sbarbato coi capelli lunghi nella foto ritratto – così diverso dal caporale baffuto di Sgt Pepper. È un uomo apparentemente più risolto di quello che incontreremo anche solo qualche mese più tardi, ed è molto ironico accorgersene proprio mentre canta la canzone più acida del disco contro un guru che lo aveva deluso. Viene quasi da rivalutarlo, questo Maharishi che invece di imporsi come un dio in terra si era lasciato scoprire come un uomo tra gli uomini, coi suoi difetti veri o presunti (le voci dei suoi approcci con le giovani ospiti, messe in giro da Alex Mardas, il personaggio più discutibile dell'entourage di Lennon, non sono mai state verificate). Lennon aveva bisogno senz'altro di meditare, di smetterla con qualche sostanza e di trovare il coraggio per chiudere il suo matrimonio; ma doveva anche recuperare il suo approccio disincantato che l'assunzione metodica di LSD aveva stemperato. E per quanto non ammetteremo mai di preferirlo al Lennon pop-surrealista di Strawberry Fields o di Walrus, il Lennon che amiamo è quello che mette l'umanità davanti al suo assurdo: quello di Happiness is a Warm Gun, di Bungalow Bill, di Sexy Sadie. Ci hai preso tutti in giro, ammette Lennon. Avremmo dato tutto quello che avevamo solo per sederci alla tua tavola. Come hai fatto a capire che stavamo cercando proprio te? È il Lennon in cui convivono al meglio il teppista di Liverpool ansioso di non farsi fregare, e il profeta internazionale con un messaggio per il mondo. Un equilibrio impossibile da mantenere se non per quei brevi istanti del Disco Bianco e i primi veri dischi solisti, Plastic Ono e Imagine. E tu lo sapevi per tutto il tempo, Sexy Sadie? O forse semplicemente sorridevi e fingevi di saperla lunga? Non importa, ha funzionato. Ma quanto è incredibile che a fine '68, all'apice del flower power, sul disco della band più importante del mondo ci fosse una canzone che sputtanava un guru indiano? Gli Stones, che ancora giocavano coi vecchi arnesi della religione occidentale in Sympathy for the Devil, sembrano a una rivoluzione di distanza.
63. Michelle (Lennon-McCartney, Rubber Soul, 1965)
Michelle/ma belle: sont les mots qui vont très bien ensemble. Perché ci proviamo con le straniere? Tu parli una lingua, lei un'altra: se malgrado questo state flirtando da mezz'ora, è abbastanza chiaro che entrambi cercate un'avventura. Non possono esserci equivoci su questo, per cui paradossalmente meno vi capite più è chiaro quello che desiderate l'una dall'altro e viceversa. È un modo di semplificare quel livello del corteggiamento che il romanticismo ha complicato in modo per molti insostenibile: il livello linguistico. È tutto molto più semplice, preumanistico: ci si guarda, ci si annusa si sorride, si ripetono frasi stereotipate che hanno un significato molto più basilare di quello offerto dal vocabolario ("I love you I love you I love you"). E poi per i maschietti ogni donna è un terreno da conquistare, il che rende la lingua straniera intrinsecamente sexy.
(Lo so che tutto questo è sessista. I Beatles sono un gruppo di ventenni degli anni '60: facevano notizia se nelle loro canzoni si parlava di droga, non di picchiare le donne. Non è colpa loro se oggi siamo diversi. Anzi in parte è anche merito loro).
La Francia è sempre stata un angolo cieco per i Beatles: il pezzo di continente europeo più vicino ma meno accondiscendente al loro fascino, così irresistibile altrove. L'Olympia aveva ricevuto i Beatles alla vigilia del boom degli USA, ma con freddezza, senza lasciarsi conquistare. Era anche un problema linguistico. Per fortuna dopo lo scoppio della Beatlemania la necessità di sfondare in mercati non anglofoni passò in secondo piano, per cui dopo avere re-inciso due singoli in un discutibile tedesco, Lennon e McCartney non dovettero ripetere l'exploit in altre lingue che conoscevano ancora meno (pensate se avessero provato a cantare qualche pezzo in italiano, come toccò fare persino ai Rolling Stones...)
E però la Francia restava lì, una frontiera vicinissima e solo apparentemente scontrosa. Non solo la Francia, ma un intero continente, un mercato di milioni di potenziali acquirenti di dischi, e un immaginario a cui i Beatles erano sensibili sin dagli anni del liceo, quel periodo in cui, spiega Paul, "tutti volevano essere Sacha Distel", ovvero chitarristi jazz prestati alla canzone confidenziale, ma soprattutto quel tipo di persona che passa da Juliette Greco a Brigitte Bardot con disinvoltura. "The bohemien French thing", insomma: Paul ha un chiaro ricordo di aver visto davvero a un festino di studenti d'arte (compagni di John) un ragazzo col pizzetto e la maglietta a righe cantare una languida chanson alla chitarra. In seguito lui stesso avrebbe cominciato a recitare per divertimento questa parte di chansonnier, ritirandosi in un angolo a bofonchiare in un francese immaginario di cui non abbiamo registrazioni – probabilmente era meno convincente del falso spagnolo di You Know My Name o Sun King. In queste situazioni suonava un arpeggio che gli aveva insegnato un compagno di classe, una cosa così antica che l'aveva imparata prima di invertire le corde della sua prima chitarra: il primo riff con linea di basso discendente della storia dei Beatles. Senza suonare particolarmente 'francese', era abbastanza diverso da tutto quello che i Beatles suonavano da poter sembrare, in un qualche modo, continentale.
Michelle nasce insomma nasce come farsa e non sarebbe neanche andata molto lontano se dopo il successo di Yesterday John Lennon non avesse proposto a Paul di ripescare "quell'arpeggio che suonavi alle feste", suggerendo anche il primo verso del bridge: "I love you I love you I love you". (Complimenti John, Paul probabilmente non ci sarebbe mai arrivato da solo...) Paul sceglie di conservare l'ispirazione vagamente francese del brano, facendosi dettare da un'amica un paio di frasi d'aggancio e creando la situazione di un idillio internazionale: idea semplice e geniale, che gli consente di bofonchiare il suo francese in modo credibile, o almeno non più ridicolo di qualsiasi giovane inglese in vacanza. Non sono in fondo tutte le canzoni d'amore dei Beatles che un grande frasario stereotipato per stranieri? Sin dai tempi di Love me Do / You know I love you / I'll always be true, i Beatles hanno riempito le loro canzoni di frasi d'aggancio per seduttori del sabato sera: e se nel 1965 il gioco cominciava a mostrare la corda, bastava postulare una ragazza straniera perché tutto tornasse miracolosamente semplice come due anni prima. Il testo di Michelle, se vi fermate a osservarlo, è demenziale: senz'altro il più scemo di Rubber Soul, ma anche il più furbo, perché si crea da solo una cornice in qui la demenzialità è perfettamente giustificata. Provate a immaginare la situazione se la voce narrante non fosse un divo del rock ma un tizio qualsiasi che approccia la tipa con una battuta sul suo nome: ti chiami Michelle? ah fa rima con ma belle! Ti amo ti amo ti amo, finché non trovo un altro modo te lo dico così. Ho bisogno, ho bisogno, bisogno... di farti capire cosa significhi per me, finché spero tanto che lo capirai. Ok, se la tizia non è scappata al primo bridge, evidentemente è interessata. Perché ci proviamo con le straniere? Perché possiamo spararle grosse, con la scusa che è l'unico modo di farsi capire. Ed ecco un'altra canzone autoperformativa: no, Paul non ci sta provando con una francese, ma con la Francia intera, e più in generale col mercato europeo. Il successo sarà spettacolare: numero 1 in Belgio, Paesi Bassi, Norvegia, e... Francia, dove uscì in formato EP. Negli USA non uscì come singolo ma in compenso diede ai Beatles l'unico Grammy per la canzone dell'anno, nel 1967 (quando ormai l'avventura francese doveva essere un ricordo sbiadito). L'anno prima Yesterday aveva avuto una nomination, ma non ce l'aveva fatta.
Michelle viene spesso accostata a Yesterday, l'altro brano del 1965 con cui Paul si impose come l'ambasciatore dei Beatles nei vasti territori musicali non lambiti dal rock. Yesterday però è un'ossessione notturna a cui i Beatles non sapevano che forma dare, fino al punto di farsi sostituire da un'orchestra di camera; Michelle è un brano freddamente costruito a tavolino intorno a un fraseggio preso in prestito, inciso con una rapidità impressionante e mai più ripreso, mai suonato dal vivo, liquidato con la freddezza con cui a vent'anni si superano le avventure di una notte. Il risultato è comunque sorprendente. Non importa quanto siano sceme le parole e imbarazzante la situazione: Paul le canta con un trasporto che ci consente per due minuti la sospensione della credulità. Per due minuti lo yeh-yeh diventa esistenziale. I cori sono soffusi come nei brani del decennio prima (è come se John e George si tenessero fuori dal cono di luce); l'assolo ha la magniloquenza tipica degli inserti di George Martin, ma è il perfetto correlato musicale di un latin lover che alterna frasi appassionate a conclusioni spicce. L'idea geniale è quel timbro felpato che sa di radio a onde corte, di jazz anni Cinquanta ascoltato ballando stretti.
62. The Long and Winding Road (Lennon-McCartney, Let It Be, 1970).
Quante volte ci ho provato. Qualche anno dopo lo scioglimento dei Beatles, The Long and Winding Road avrebbe finalmente trovato la sua giusta collocazione al termine del doppio The Beatles 1967-1970, volgarmente conosciuto come il "Disco Blu". In quella posizione era molto più facile accettarla che nel bel mezzo di un disco come Let It Be, di cui tradiva tutte le premesse: doveva essere un ritorno al r'n'r, e sembrava Bacharach; doveva essere un disco suonato dal vivo, e invece era appesantita da un'orchestrazione tipicamente spectoriana – insomma, non c'entrava nulla col disco, era uno di quei brani che gli altri tre Beatles non apprezzavano e dopo che ci aveva messo mano Phil Spector sembrava che lo detestasse anche Paul.
Invece al termine del Disco Blu funziona, proprio perché non suona del tutto Beatles: persino al termine di un doppio in cui i Quattro sembrano aver tentato ogni stile musicale possibile, quando arriva The Long abbiamo la netta sensazione che la storia sia finita e i titoli di coda stiano correndo. È la sigla finale, così come Love Me Do è la sigla iniziale del Disco Rosso. E come succede con le sigle al cinema, ti fa venire una gran voglia di uscire prima che sia finita. Sembra sempre molto, molto più lunga dei suoi tre minuti e mezzo: meriterebbe un'indagine sperimentale il modo in cui infallibilmente riesce a far perdere la concentrazione dell'ascoltatore a metà brano. Ha a che vedere forse con il metodo Phil Spector, quella sua abitudine a saturare i solchi con una quantità di stimoli che però rimangono tutti vaghi, indistinti – lo chiamano muro del suono, ma io l'ho trovato sempre più simile a una nuvola, una nebbia che ti nasconde i dettagli e ti lascia libero di sostituirli con quelli che peschi dalla tua memoria; ma è anche facile distrarsi, se non proprio addormentarsi.
Sappiamo che Spector aveva qualche buon motivo per sovraprodurre il prodotto: per prima cosa il demo aveva qualche problema oggettivo: in particolare era necessario distogliere l'attenzione dal basso di Lennon (sempre il Fender VI). Ma soprattutto era Phil Spector, insomma se chiami Phil Spector non è che ti puoi lamentare della sovrapproduzione, è come invitare Sgarbi in tv e prendersela perché dice le parolacce. In effetti l'equivoco è questo: la canzone che ti fa pensare che tutto sia finito, e che Paul sia rimasto solo su una lunga strada tortuosa, in realtà fu prodotta nella situazione opposta: era McCartney a essersi ritirato in campagna, furono Lennon e Harrison a proporre a Phil Spector di prendere il malloppo e trasformarlo in un prodotto finito. Considerata la situazione e il personaggio bisogna riconoscere che fu più misurato del suo solito: l'idea di aggiungere cori e violini era autorizzata dallo stile del brano, che sin da quei quattro accordi sincopati iniziali sembra un tentativo di Paul di inseguire Bacharach sui sentieri delle radio AM ormai negletti dalla generazione di Woodstock. Il trattamento inoltre non è molto diverso da quello che George Martin aveva riservato a Good Night, la sigla finale del Disco Bianco. Sappiamo che Paul si arrabbiò molto, ma sappiamo anche che ormai Paul era alla ricerca di un casus belli per mollare la ditta. Il suo rapporto con la sua ultima canzone beatle resta ambiguo: nella sua versione "nuda" di Let It Be, il brano suona di nuovo come nel demo, con un breve assolo organistico di Preston nel punto in cui Spector più sfrenava i suoi orchestrali: però quando la suona dal vivo a quegli archi sovrabbondanti non rinuncia.
In The Long Paul riprende e rimescola due suggestioni di altrettante canzoni dell'album: dal Let It Be il ricordo della madre; da Two of Us l'immagine della strada. Il risultato è un testo molto più ispirato del solito, che purtroppo fatica a imporsi all'attenzione distratta dai violini e dalla sensazione di trovarci al termine del percorso. Per commuoversi basta pensare (come con Two of Us) che Paul la canti a John. Una bella forzatura, certo, nel 1970. Già qualche anno dopo la situazione era molto diversa. Oggi ormai è impossibile non pensarci. Quante volte sono rimasto solo, quante volte ho pianto. In ogni caso non saprai mai in quanti modi ci ho provato... solo per ritrovarmi di nuovo su questa lunga strada tortuosa dove mi hai lasciato tanto, tanto tempo fa. Non lasciarmi ancora qui, guidami alla tua porta.
61. I Should Have Known Better (Lennon-McCartney, A Hard Day's Night, 1964).
Se questo è amore me ne devi dare di più! Dammene di più! Ok, cosa ci fa questa così in alto? Chi si è bevuto il cervello stavolta? Sempre Rolling Stone – ma anche Entertainment Weekly – per farla breve: gli americani. È una cosa di cui tener conto: mentre da questa parte dell'oceano siamo tutti abbastanza persuasi che i Beatles migliori siano quelli maturi, almeno da Rubber Soul in poi, negli USA la Beatlemania ha lasciato un segno più indelebile che forse non siamo in grado di comprendere. Ci manca la percezione dello choc, insomma, questi venivano non da Marte ma quasi: da Liverpool. Con il loro buffo accento e quel taglio di capelli così europeo, arrivavano a riproporre una serie di stilemi della musica popolare americana ma stravolgendoli completamente. A conquistare gli americani dev'essere stata questa sensazione di spaesamento e insieme di familiarità: heimlich/unheimlich. Prendi questo brano che apparentemente è l'ennesima variazione yeh-yeh, salvo che la progressione è abbastanza originale e contiene soluzioni che sorprendono ancora oggi gli esperti.
Nel reparto parole, Lennon si sta già costruendo un personaggio più ambivalente di quanto possa sembrare: è un maschio che ha appena scoperto che l'amore è un'esperienza molto più interessante di quel che credeva. Nel brano successivo avvertirà che l'amore è "molto più che stringersi la mano", ma qui in un certo senso la situazione è opposta: il John di I Should Have Known di mani deve averne strette già molte, né dev'essere a digiuno di pratiche anche più spinte: ma non contano più perché... non erano autentiche. Di fronte al Vero Amore, anche un lavoratore dell'indotto del quartiere a luci rosse di Amburgo ritorna vergine, e questo è veramente un colpo di genio. "Poteva succedere solo a me", dice John, e in un colpo solo ammette: (1) un passato scapestrato da teddy boy impenitente e (2) la coscienza pura di un bambino nuovo alle gioie dell'amore. Questo volevano le ragazze dai Beatles: il brivido del proibito, la tenerezza del ragazzino. Questo volevano da John e John lo sapeva meglio di tutti, hey hey hey! Quando vi dirò che siete mie, voi mi direte che mi amate. Quella soddisfazione che solo l'amore corrisposto ti dà, come un improvviso sbocco di miele nelle vene.
Comments (5)