L'autocritica maoista di D e G
28-11-2018, 12:18giornalisti, la Cina è vicina, TheVisionPermalinkPallidi, smorti, due stracci grigi messi ad asciugare su uno sfondo rosso drago, i due imperatori della moda non vi sono mai sembrati così nudi, così ridicoli: e adesso infatti li irridete. Adesso.
Adesso Crozza li può prendere in giro; adesso Gianni Riotta può ammettere che la crisi con la Cina è stata una débâcle – “Agire in un mondo unico e social come se vivessimo ancora nell’Italia chiusa anni Cinquanta, porta a disastri”; adesso Vittorio Zucconi su La Repubblica può persino mettere in dubbio la versione ufficiale dell’azienda, quella secondo cui i tweet violentemente anticinesi partiti dall’account di uno stilista sarebbero stati scritti da un malvagio hacker. Come se fosse la prima volta che da quell’account partono tweet disastrosi e autolesivi, come se lo stesso responsabile dell’account non avesse mai definito “brutta” Selena Gomez, o “fascista” Elton John. Fino a venerdì però non c’era quotidiano italiano che osasse mettere in discussione la bizzarra teoria degli hacker. Fino alla settimana scorsa non c'era quotidiano che potesse permettersi a cuor leggero di mettere in discussione Dolce e Gabbana. E così, mentre i siti di e-commerce ritiravano i prodotti griffati, il Ministero cinese annullava la sfilata-evento e su Instagram si postavano video di falò alimentati con i vestiti della coppia di stilisti, per i giornalisti italiani Dolce e Gabbana al massimo avevano sbagliato uno spot, urtato qualche indigeno troppo suscettibile.
Poi però è arrivato il loro grottesco video di scuse, e qualcosa è cambiato. Come se i predatori del circo mediatico avessero sentito l’odore del sangue: Dolce e Gabbana improvvisamente non erano più intoccabili. Non più i capricciosi tiranni del lusso, quelli che qualche anno fa per una recensione negativa avevano ritirato le inserzioni pubblicitarie a un quotidiano. Dolce e Gabbana erano stati colpiti. Non sono immortali, dunque. E quindi addosso – comodo, adesso.
Così comodo che forse vale la pena di chiamarsi fuori. Tanto la frittata è fatta, no? Dolce e Gabbana lavorano sugli stereotipi: lo hanno sempre fatto e per molto tempo ha funzionato. La caricatura di Italia che spacciavano al mondo era davvero ferma agli anni Cinquanta, e potrebbe persino essere stata controproducente per l’immagine della nostra nazione all’estero: ma funzionava, vendeva, e quindi perché lagnarsene. I problemi sono nati quando il metodo Dolce e Gabbana è stato esteso al resto del mondo globalizzato, in aree forse più sensibili ai problemi che gli stereotipi portano con sé.
Un primo segnale d’allarme arrivò durante la sfilata primavera-estate 2013, quando alcune modelle si presentarono in passerella con un ingombrante orecchino che lasciò perplessi i giornalisti anglosassoni (“Are they racist?“): rappresentava la testa di una donna nera; somigliava non troppo vagamente ai quelle raffigurazioni stilizzate e grottesche degli individui afroamericani stigmatizzate da Spike Lee in Bamboozled . In quell’occasione l’azienda si limitò a precisare che avevano voluto citare le “teste di moro”, un simbolo del folklore siciliano. Uno choc culturale interessante, su cui la stampa italiana non trovò molto da dire.
Così come si allarmò particolarmente l’anno dopo, quando le foto dell'”Hallowood Disco Africa” con gli stilisti truccati da africani fecero il giro del mondo e arrivarono in America, dove la “blackface” è ancora vista come un oltraggio dalla comunità afroamericana: un ricordo di quei minstrels show in cui attori bianchi truccati da neri ne irridevano i costumi mentre si appropriavano della loro musica. Gabbana non portava una blackface, ma delle foto sembrava divertirsi, sinceramente inconsapevole dei problemi che avrebbe potuto crearsi con i clienti di oltreoceano. Tanto chi si indigna di queste cose non compra Dolce e Gabbana, no?
I giornalisti italiani si fecero invece sentire nel 2015, quando lo stesso Gabbana definì “sintetico” il figlio di Elton John e quest’ultimo reagì annunciando che non avrebbe mai più comprato prodotti della griffe; al che Gabbana reagì definendolo “fascist“. Forse fu un hacker anche in quell’occasione, non si può escludere, ma non è questo il punto. Il punto è che allora i giornalisti italiani intervennero, sì: ma per difendere Gabbana; per cercare di spiegare e Elton John che quella di Gabbana su suo figlio era un’opinione, e le opinioni vanno rispettate. Certo, non credo che Elton John si sia scosso più di tanto per i rilievi di Beppe Severgnini, ma il problema resta: quello di una stampa nazionale che sembra spalleggiare Gabbana (o il suo hacker) per partito preso, anche a costo di scadere nel ridicolo... (continua su TheVision).
In un mondo globale sempre più insofferente nei confronti degli stereotipi culturali e di genere, se Dolce e Gabbana hanno potuto remare per anni in direzione contraria è anche colpa di chi, per tutto questo tempo, si è sforzato di trovarli geniali, fingendo di non vedere anche gli esempi più eclatanti, come la pubblicità che alludeva a una violenza sessuale di gruppo. Tutto questo finché un giorno non sono andati a sbattere contro la Repubblica Popolare Cinese. Adesso è tutta colpa loro: gli imperatori sono nudi, gli ex ciambellani di corte si accaniscono su coloro che fino a un momento fa veneravano. Trovano brutto il comunicato di scuse, poco credibile. Chissà se qualche autoeletto guru della comunicazione ha già fatto notare quello che per un qualsiasi studente della Storia del Novecento rasenta l’ovvio: quel video apparentemente imbarazzante è ancora una volta una rielaborazione di stereotipi orientali (l’autocritica maoista) e occidentali (Dolce e Gabbana sembrano due ostaggi davanti alla videocamera fissa).
Costretti a recitare con voce atona formule grottesche come “Chiediamo scusa ai cinesi perché ce ne sono tanti”, Dolce e Gabbana insistono sulla redenzione, ma in realtà stanno dicendo un’altra cosa: umiliazione. È vero che mancano i cappelli di carta con cui le Guardie Rosse di Mao cingevano le teste dei nemici del popolo, ma chi è nato e cresciuto dopo la Rivoluzione Culturale non dovrebbe faticare a cogliere un riferimento, anche inconscio: Dolce e Gabbana si comportano come due capitalisti rieducati, proletarizzati, pronti per indossare la tutina e inforcare la bicicletta.
Nel frattempo l’osservatore occidentale ridacchia, ma percepisce un altro messaggio preciso: Aiuto, siamo prigionieri. Ovviamente non crediamo in quello che stiamo dicendo, siamo ostaggi di questo nuovo mondo globale. Venite a salvarci, o almeno abbiate pietà di noi. Un video così goffo riesce a muovere le corde giuste di due pubblici opposti e complementari. Non male, per essere la mossa disperata di due stilisti a cui adesso, e solo adesso, gli Esperti rimproverano l’incapacità di comunicare. Lavorare sugli stereotipi è pericoloso, e prima o poi ci si brucia. Ma se Dolce e Gabbana ci hanno insistito fin qui, è perché fin qui tutto sommato funzionava. E funziona ancora, a dispetto di ogni critica. Anche coi cinesi, anche con noi.
 |
| Il problema non è avere un cannolo grande. |
Poi però è arrivato il loro grottesco video di scuse, e qualcosa è cambiato. Come se i predatori del circo mediatico avessero sentito l’odore del sangue: Dolce e Gabbana improvvisamente non erano più intoccabili. Non più i capricciosi tiranni del lusso, quelli che qualche anno fa per una recensione negativa avevano ritirato le inserzioni pubblicitarie a un quotidiano. Dolce e Gabbana erano stati colpiti. Non sono immortali, dunque. E quindi addosso – comodo, adesso.
Così comodo che forse vale la pena di chiamarsi fuori. Tanto la frittata è fatta, no? Dolce e Gabbana lavorano sugli stereotipi: lo hanno sempre fatto e per molto tempo ha funzionato. La caricatura di Italia che spacciavano al mondo era davvero ferma agli anni Cinquanta, e potrebbe persino essere stata controproducente per l’immagine della nostra nazione all’estero: ma funzionava, vendeva, e quindi perché lagnarsene. I problemi sono nati quando il metodo Dolce e Gabbana è stato esteso al resto del mondo globalizzato, in aree forse più sensibili ai problemi che gli stereotipi portano con sé.
 |
| Il problema è avere un grande cannolo |
Così come si allarmò particolarmente l’anno dopo, quando le foto dell'”Hallowood Disco Africa” con gli stilisti truccati da africani fecero il giro del mondo e arrivarono in America, dove la “blackface” è ancora vista come un oltraggio dalla comunità afroamericana: un ricordo di quei minstrels show in cui attori bianchi truccati da neri ne irridevano i costumi mentre si appropriavano della loro musica. Gabbana non portava una blackface, ma delle foto sembrava divertirsi, sinceramente inconsapevole dei problemi che avrebbe potuto crearsi con i clienti di oltreoceano. Tanto chi si indigna di queste cose non compra Dolce e Gabbana, no?
I giornalisti italiani si fecero invece sentire nel 2015, quando lo stesso Gabbana definì “sintetico” il figlio di Elton John e quest’ultimo reagì annunciando che non avrebbe mai più comprato prodotti della griffe; al che Gabbana reagì definendolo “fascist“. Forse fu un hacker anche in quell’occasione, non si può escludere, ma non è questo il punto. Il punto è che allora i giornalisti italiani intervennero, sì: ma per difendere Gabbana; per cercare di spiegare e Elton John che quella di Gabbana su suo figlio era un’opinione, e le opinioni vanno rispettate. Certo, non credo che Elton John si sia scosso più di tanto per i rilievi di Beppe Severgnini, ma il problema resta: quello di una stampa nazionale che sembra spalleggiare Gabbana (o il suo hacker) per partito preso, anche a costo di scadere nel ridicolo... (continua su TheVision).
In un mondo globale sempre più insofferente nei confronti degli stereotipi culturali e di genere, se Dolce e Gabbana hanno potuto remare per anni in direzione contraria è anche colpa di chi, per tutto questo tempo, si è sforzato di trovarli geniali, fingendo di non vedere anche gli esempi più eclatanti, come la pubblicità che alludeva a una violenza sessuale di gruppo. Tutto questo finché un giorno non sono andati a sbattere contro la Repubblica Popolare Cinese. Adesso è tutta colpa loro: gli imperatori sono nudi, gli ex ciambellani di corte si accaniscono su coloro che fino a un momento fa veneravano. Trovano brutto il comunicato di scuse, poco credibile. Chissà se qualche autoeletto guru della comunicazione ha già fatto notare quello che per un qualsiasi studente della Storia del Novecento rasenta l’ovvio: quel video apparentemente imbarazzante è ancora una volta una rielaborazione di stereotipi orientali (l’autocritica maoista) e occidentali (Dolce e Gabbana sembrano due ostaggi davanti alla videocamera fissa).
Costretti a recitare con voce atona formule grottesche come “Chiediamo scusa ai cinesi perché ce ne sono tanti”, Dolce e Gabbana insistono sulla redenzione, ma in realtà stanno dicendo un’altra cosa: umiliazione. È vero che mancano i cappelli di carta con cui le Guardie Rosse di Mao cingevano le teste dei nemici del popolo, ma chi è nato e cresciuto dopo la Rivoluzione Culturale non dovrebbe faticare a cogliere un riferimento, anche inconscio: Dolce e Gabbana si comportano come due capitalisti rieducati, proletarizzati, pronti per indossare la tutina e inforcare la bicicletta.
Nel frattempo l’osservatore occidentale ridacchia, ma percepisce un altro messaggio preciso: Aiuto, siamo prigionieri. Ovviamente non crediamo in quello che stiamo dicendo, siamo ostaggi di questo nuovo mondo globale. Venite a salvarci, o almeno abbiate pietà di noi. Un video così goffo riesce a muovere le corde giuste di due pubblici opposti e complementari. Non male, per essere la mossa disperata di due stilisti a cui adesso, e solo adesso, gli Esperti rimproverano l’incapacità di comunicare. Lavorare sugli stereotipi è pericoloso, e prima o poi ci si brucia. Ma se Dolce e Gabbana ci hanno insistito fin qui, è perché fin qui tutto sommato funzionava. E funziona ancora, a dispetto di ogni critica. Anche coi cinesi, anche con noi.
Comments (1)
Vota Chtulhu
16-11-2011, 17:31giornalisti, la Cina è vicina, migrantiPermalink
La badante e i professori
Anch'io sono tra quelli che hanno trovato sconvolgente l'articolo del Corriere in cui Federico Fubini e Danilo Taino hanno proposto di far votare i genitori anche per i loro figli, o di “rafforzare” il voto dei giovani (“permettiamo che quella di un ventenne conti magari 1,2, e di un trentenne almeno 1,1)”. Ma non per il crimine di lesa democrazia, che i due praticano solo a livello teorico (c'è gente che infierisce sulla moribonda con coltelli molto meno metaforici). Non sono un feticista della democrazia: è un sistema, ha i suoi difetti. Da nessuna parte è scritto che una maggioranza sappia individuare i problemi prioritari e risolverli meglio di una minoranza.
Certo, in generale è lecito pensare che ognuno capisca ciò che è bene per sé, e che quindi una maggioranza sappia agire perlomeno per il bene della maggioranza: e tuttavia questa, come tante altre belle e semplici idee occidentali, ha il difetto non piccolo di funzionare soltanto postulando uno sviluppo illimitato e risorse altrettanto illimitate. Così in certe brutte giornate mi sorprendo a pensare che la democrazia sia la principale colpevole del riscaldamento globale: è solo Lei ad avere concreta necessità di massificare il benessere, e a distribuire alla maggioranza luce acqua gas e benzina: se avessero vinto i nazisti probabilmente avrebbero schiavizzato la maggioranza della popolazione mondiale, con una conseguente contrazione dei consumi, della concorrenza e della produzione: oggi saremmo magari due o tre miliardi in meno e non ci sarebbe tutto questo inquinamento (non ci sarei però nemmeno io, quindi preferisco tenermi l'inquinamento).
Così, man mano che l'umanità procede verso la catastrofe (e io spero di sbagliarmi, ma sono sempre di quella generazione che a scuola si è vista The Day After, io sin da cucciolo sono stato addestrato a puntare il naso al primo vago lezzo di catastrofe) trovo inevitabile che la democrazia venga messa in discussione, e si richiamino i “tecnici”, di cui finalmente saggeremo la tecnica. Se poi parliamo di Monti, egli è ancora molto lontano dalla mia idea di cavaliere dell'Apocalisse; però per esempio non credo che la Cina diventerà nei tempi brevi una democrazia, e forse nemmeno lo spero: forse l'unica speranza per tutti noi sette miliardi è la politica del figlio unico del governo cinese, ma credo che solo una tirannide tecnocratica possa imporla. Non credo che usciremo democratici dal ventunesimo secolo (la maggior parte di noi non ne uscirà comunque, certo): perlomeno chi avrà la dubbia fortuna di discendere da noi non manterrà questa fiducia acritica nella democrazia, che è un sistema fantastico quando devi amministrare un'economia in espansione, non quando devi razionare acqua e benzina. Queste cose avrei potuto scriverle in qualsiasi momento degli ultimi dieci anni, ma forse non avevo il coraggio.
Poi negli ultimi giorni improvvisamente la democrazia è stata messa in discussione da Gramellini sulla Stampa, e ora da due prestigiosi studiosi sul Corriere. Cosa sta succedendo? Credo sia un banale effetto ottico del crepuscolo del berlusconismo (per quanto illusorio che sia): è giunto il momento delle monetine e tutti si domandano com'è possibile che ci siamo tenuti un tipo del genere per diciassette anni – che razza di sistema politico sia quello che consente a un pagliaccio simile di governare, o meglio, di impedire a qualche altra persona seria di farlo? Si chiama democrazia? Deve avere qualche grosso difetto.
E in effetti ne ha, e sopra ho descritto quello che ritengo il peggiore: la democrazia persegue il bene dei più, fino a esaurimento delle risorse e conseguenti probabili catastrofi. Però Berlusconi non è un difetto della democrazia, così come un baro non è un difetto del poker: è uno che a poker non ci deve giocare, non dovevamo nemmeno permettergli di sedersi al tavolo. L'antiberlusconismo è tutto qui: ostinarsi a credere che Berlusconi non sia un difetto della democrazia, ma uno che la democrazia l'ha pervertita dal primo istante in cui si è candidato (illegalmente) e le sue emittenze (ammucchiate illegalmente) hanno cominciato a inviarci consigli per le elezioni. L'antiberlusconismo è credere che la maggioranza degli italiani abbia votato Berlusconi non per chissà quale tara antropologica o culturale, ma semplicemente perché è stata truffata da un tizio che non ha rispettato le regole. E se non rispetti le regole, non è più democrazia: neanche se ogni tanto vince Prodi (ma la sua agenda è completamente stravolta da emergenze criminalità create ad arte dai media berlusconiani). Prova ne è che le democrazie cosiddette 'mature' non eleggono gente come Berlusconi. Non è che eleggano sempre fior di statisti, però solo in Thailandia hanno eletto un tizio paragonabile a Berlusconi – anche se là l'alternativa sono i colonnelli, forse lo sosterrei pure io. Anche se i colonnelli non avevano tutti i torti a cercare di estrometterlo. Io almeno la penso così. Perché resto antiberlusconiano.
Ma al Corriere non possono essere antiberlusconiani. Persino qualora ritenessero in cuor loro che Berlusconi sia stato la più grande disgrazia dai tempi della peste del Seicento. Il Corriere deve stare in mezzo, all'intersezione di base e bisettrice – altrimenti non è più Corriere. Se per dire invece di Berlusconi nel '94 fosse sceso in campo Chtulhu, e nel suo programma di governo avesse preteso orge a base di sangue fresco di tot vergini al semestre, Panebianco e Battista nei 17 anni successivi si sarebbero sforzati di trovare il punto medio tra Occhetto e Chtulhu, tra Prodi e Chtulhu, tra Veltroni e Chtulhu, tipo, ok, il secondo è un fetido mostro tentacolare ed evanescente che si nutre di incubi, ma anche la Festa del Cinema di Roma non è che abbia una programmazione così esaltante, ecco, in ciò consiste la medietà del Corriere.
Dal Corriere non è che possano dirci: “Va bene, Berlusconi ci ha fregato, ha abusato di una posizione di mercato dominante assolutamente illegale, auspichiamo che il governo Monti agisca prontamente contro questo trust che è un covo di potere a delinquere”. No. Bisogna dare la colpa agli italiani, perlomeno di quella metà che in qualsiasi momento avrebbe dovuto scegliere di non dar retta a metà delle tv, a metà dei giornali (ed è ovviamente colpa anche dell'altra metà che doveva fare opposizione in un modo più elegante). Quindi, invece di porsi l'unico problema sensato, ovvero: come sgominiamo una volta per sempre il partito-azienda che persegue gli interessi dell'azienda e non quelli dell'Italia? Quali leggi variamo? Dobbiamo scriverne di nuove o è sufficiente applicare le vecchie? Si può lasciar fare alla giustizia ordinaria o saranno necessarie misure straordinarie (=bomb Cologno)? ...Invece di discutere di tutto questo, ci si pone il problema della democrazia. Forse non funziona, visto che il baro vinceva le partite. Cosa facciamo? Facciamo votare solo quelli che hanno letto un po' di Costituzione (Gramellini)? Oppure diamo i voti calibrati a seconda dell'età (Fubini/Taino)? Così in un colpo solo non ci liberiamo soltanto di Berlusconi, ma di tutte le gerontocrazie, comprese quelle di sinistra che non vogliono mandarci in pensione a settant'anni per dare due spicci di sussidio ai giovani disoccupati.
Però non è questo che trovo sconvolgente dell'articolo di Fubini e Taino. Le loro proposte sono perfino ragionevoli, considerato che stanno infrangendo un tabù. Il punto è che loro partono dal presupposto (vero) che la maggioranza anziana degli italiani continuerà ad avallare politiche anziane, senza capacità né volontà di guardare troppo avanti. Ed è vero che andrà così – se gli italiani continueranno a votare. Ma perché mai dovrebbero votare soltanto gli italiani?
Ecco, la cosa sconvolgente dell'articolo di Fubini e Taino è la rimozione totale del problema numero uno (e della soluzione al problema numero uno): il voto agli stranieri. F&T parlano di un Paese in rapido invecchiamento, e lo siamo – se non contiamo gli stranieri. Se invece li contiamo, scopriamo che tutto sommato la bilancia tiene (terrebbe persino l'Inps). I giovani non sono meno rappresentati perché sono pochi. Sono meno rappresentati perché una parte di loro non ha il diritto di voto. Lavorano, consumano, pagano tasse e contributi, combattono insieme a noi la lotta quotidiana e impari per tenere basso lo spread – ma non votano, non vengono contati. La soluzione proposta da Fubini e Taino è dare un decimo di voto in più ai loro coetanei italiani. Sono due studiosi, hanno fatto una ricerca, si sono messi ad elaborare calcoli, magari simulazioni, e durante tutto questo tempo non gli è venuto in mente che ehi, esistono anche gli stranieri, e sono abbastanza giovani, e lavorano nella stessa nazione che ha il problema dell'innalzamento dell'età media. Magari mentre preparavano il loro articolo un'inserviente etiope stava spolverando gli scaffali, e non l'hanno vista. Troppo concentrati sul loro problema. Eureka, potremmo far votare i sedicenni, purché italiani, purché bianchi. Qualsiasi tabù si può infrangere, anche il suffragio universale, anche la democrazia – ma non penserete mica di far votare la badante moldava? Perché a quel punto forse aspetta, forse facciamo ancora in tempo a richiamare Chtulhu.
Anch'io sono tra quelli che hanno trovato sconvolgente l'articolo del Corriere in cui Federico Fubini e Danilo Taino hanno proposto di far votare i genitori anche per i loro figli, o di “rafforzare” il voto dei giovani (“permettiamo che quella di un ventenne conti magari 1,2, e di un trentenne almeno 1,1)”. Ma non per il crimine di lesa democrazia, che i due praticano solo a livello teorico (c'è gente che infierisce sulla moribonda con coltelli molto meno metaforici). Non sono un feticista della democrazia: è un sistema, ha i suoi difetti. Da nessuna parte è scritto che una maggioranza sappia individuare i problemi prioritari e risolverli meglio di una minoranza.
Certo, in generale è lecito pensare che ognuno capisca ciò che è bene per sé, e che quindi una maggioranza sappia agire perlomeno per il bene della maggioranza: e tuttavia questa, come tante altre belle e semplici idee occidentali, ha il difetto non piccolo di funzionare soltanto postulando uno sviluppo illimitato e risorse altrettanto illimitate. Così in certe brutte giornate mi sorprendo a pensare che la democrazia sia la principale colpevole del riscaldamento globale: è solo Lei ad avere concreta necessità di massificare il benessere, e a distribuire alla maggioranza luce acqua gas e benzina: se avessero vinto i nazisti probabilmente avrebbero schiavizzato la maggioranza della popolazione mondiale, con una conseguente contrazione dei consumi, della concorrenza e della produzione: oggi saremmo magari due o tre miliardi in meno e non ci sarebbe tutto questo inquinamento (non ci sarei però nemmeno io, quindi preferisco tenermi l'inquinamento).
Così, man mano che l'umanità procede verso la catastrofe (e io spero di sbagliarmi, ma sono sempre di quella generazione che a scuola si è vista The Day After, io sin da cucciolo sono stato addestrato a puntare il naso al primo vago lezzo di catastrofe) trovo inevitabile che la democrazia venga messa in discussione, e si richiamino i “tecnici”, di cui finalmente saggeremo la tecnica. Se poi parliamo di Monti, egli è ancora molto lontano dalla mia idea di cavaliere dell'Apocalisse; però per esempio non credo che la Cina diventerà nei tempi brevi una democrazia, e forse nemmeno lo spero: forse l'unica speranza per tutti noi sette miliardi è la politica del figlio unico del governo cinese, ma credo che solo una tirannide tecnocratica possa imporla. Non credo che usciremo democratici dal ventunesimo secolo (la maggior parte di noi non ne uscirà comunque, certo): perlomeno chi avrà la dubbia fortuna di discendere da noi non manterrà questa fiducia acritica nella democrazia, che è un sistema fantastico quando devi amministrare un'economia in espansione, non quando devi razionare acqua e benzina. Queste cose avrei potuto scriverle in qualsiasi momento degli ultimi dieci anni, ma forse non avevo il coraggio.
Poi negli ultimi giorni improvvisamente la democrazia è stata messa in discussione da Gramellini sulla Stampa, e ora da due prestigiosi studiosi sul Corriere. Cosa sta succedendo? Credo sia un banale effetto ottico del crepuscolo del berlusconismo (per quanto illusorio che sia): è giunto il momento delle monetine e tutti si domandano com'è possibile che ci siamo tenuti un tipo del genere per diciassette anni – che razza di sistema politico sia quello che consente a un pagliaccio simile di governare, o meglio, di impedire a qualche altra persona seria di farlo? Si chiama democrazia? Deve avere qualche grosso difetto.
E in effetti ne ha, e sopra ho descritto quello che ritengo il peggiore: la democrazia persegue il bene dei più, fino a esaurimento delle risorse e conseguenti probabili catastrofi. Però Berlusconi non è un difetto della democrazia, così come un baro non è un difetto del poker: è uno che a poker non ci deve giocare, non dovevamo nemmeno permettergli di sedersi al tavolo. L'antiberlusconismo è tutto qui: ostinarsi a credere che Berlusconi non sia un difetto della democrazia, ma uno che la democrazia l'ha pervertita dal primo istante in cui si è candidato (illegalmente) e le sue emittenze (ammucchiate illegalmente) hanno cominciato a inviarci consigli per le elezioni. L'antiberlusconismo è credere che la maggioranza degli italiani abbia votato Berlusconi non per chissà quale tara antropologica o culturale, ma semplicemente perché è stata truffata da un tizio che non ha rispettato le regole. E se non rispetti le regole, non è più democrazia: neanche se ogni tanto vince Prodi (ma la sua agenda è completamente stravolta da emergenze criminalità create ad arte dai media berlusconiani). Prova ne è che le democrazie cosiddette 'mature' non eleggono gente come Berlusconi. Non è che eleggano sempre fior di statisti, però solo in Thailandia hanno eletto un tizio paragonabile a Berlusconi – anche se là l'alternativa sono i colonnelli, forse lo sosterrei pure io. Anche se i colonnelli non avevano tutti i torti a cercare di estrometterlo. Io almeno la penso così. Perché resto antiberlusconiano.
Ma al Corriere non possono essere antiberlusconiani. Persino qualora ritenessero in cuor loro che Berlusconi sia stato la più grande disgrazia dai tempi della peste del Seicento. Il Corriere deve stare in mezzo, all'intersezione di base e bisettrice – altrimenti non è più Corriere. Se per dire invece di Berlusconi nel '94 fosse sceso in campo Chtulhu, e nel suo programma di governo avesse preteso orge a base di sangue fresco di tot vergini al semestre, Panebianco e Battista nei 17 anni successivi si sarebbero sforzati di trovare il punto medio tra Occhetto e Chtulhu, tra Prodi e Chtulhu, tra Veltroni e Chtulhu, tipo, ok, il secondo è un fetido mostro tentacolare ed evanescente che si nutre di incubi, ma anche la Festa del Cinema di Roma non è che abbia una programmazione così esaltante, ecco, in ciò consiste la medietà del Corriere.
Dal Corriere non è che possano dirci: “Va bene, Berlusconi ci ha fregato, ha abusato di una posizione di mercato dominante assolutamente illegale, auspichiamo che il governo Monti agisca prontamente contro questo trust che è un covo di potere a delinquere”. No. Bisogna dare la colpa agli italiani, perlomeno di quella metà che in qualsiasi momento avrebbe dovuto scegliere di non dar retta a metà delle tv, a metà dei giornali (ed è ovviamente colpa anche dell'altra metà che doveva fare opposizione in un modo più elegante). Quindi, invece di porsi l'unico problema sensato, ovvero: come sgominiamo una volta per sempre il partito-azienda che persegue gli interessi dell'azienda e non quelli dell'Italia? Quali leggi variamo? Dobbiamo scriverne di nuove o è sufficiente applicare le vecchie? Si può lasciar fare alla giustizia ordinaria o saranno necessarie misure straordinarie (=bomb Cologno)? ...Invece di discutere di tutto questo, ci si pone il problema della democrazia. Forse non funziona, visto che il baro vinceva le partite. Cosa facciamo? Facciamo votare solo quelli che hanno letto un po' di Costituzione (Gramellini)? Oppure diamo i voti calibrati a seconda dell'età (Fubini/Taino)? Così in un colpo solo non ci liberiamo soltanto di Berlusconi, ma di tutte le gerontocrazie, comprese quelle di sinistra che non vogliono mandarci in pensione a settant'anni per dare due spicci di sussidio ai giovani disoccupati.
Però non è questo che trovo sconvolgente dell'articolo di Fubini e Taino. Le loro proposte sono perfino ragionevoli, considerato che stanno infrangendo un tabù. Il punto è che loro partono dal presupposto (vero) che la maggioranza anziana degli italiani continuerà ad avallare politiche anziane, senza capacità né volontà di guardare troppo avanti. Ed è vero che andrà così – se gli italiani continueranno a votare. Ma perché mai dovrebbero votare soltanto gli italiani?
Ecco, la cosa sconvolgente dell'articolo di Fubini e Taino è la rimozione totale del problema numero uno (e della soluzione al problema numero uno): il voto agli stranieri. F&T parlano di un Paese in rapido invecchiamento, e lo siamo – se non contiamo gli stranieri. Se invece li contiamo, scopriamo che tutto sommato la bilancia tiene (terrebbe persino l'Inps). I giovani non sono meno rappresentati perché sono pochi. Sono meno rappresentati perché una parte di loro non ha il diritto di voto. Lavorano, consumano, pagano tasse e contributi, combattono insieme a noi la lotta quotidiana e impari per tenere basso lo spread – ma non votano, non vengono contati. La soluzione proposta da Fubini e Taino è dare un decimo di voto in più ai loro coetanei italiani. Sono due studiosi, hanno fatto una ricerca, si sono messi ad elaborare calcoli, magari simulazioni, e durante tutto questo tempo non gli è venuto in mente che ehi, esistono anche gli stranieri, e sono abbastanza giovani, e lavorano nella stessa nazione che ha il problema dell'innalzamento dell'età media. Magari mentre preparavano il loro articolo un'inserviente etiope stava spolverando gli scaffali, e non l'hanno vista. Troppo concentrati sul loro problema. Eureka, potremmo far votare i sedicenni, purché italiani, purché bianchi. Qualsiasi tabù si può infrangere, anche il suffragio universale, anche la democrazia – ma non penserete mica di far votare la badante moldava? Perché a quel punto forse aspetta, forse facciamo ancora in tempo a richiamare Chtulhu.
Comments (26)
Qi denuncia chi
23-05-2008, 01:54dialoghi, la Cina è vicina, migranti, raccontiPermalink L'anno della Tigre di Carta
L'anno della Tigre di Carta“Buongiorno, desidera?”
“Buongiorno, volevo fare una denuncia”.
“Sì, un attimo che accendo il terminale… è un furto?”
“No, veramente no”.
“Atto vandalico?”
“Io veramente ero venuto a denunciare… come si dice… scusi, sono poco pratico, sa? Un’in…”
“Un’intimidazione mafiosa!”
“No, no, un’immigrazione”.
“Ah”.
“Clandestina”.
“Sì, sì, ho capito”.
“Insomma, c’è questa persona qui che è un immigrato clandestino”.
“Sì”.
“E sono venuto a denunciarlo. Perché adesso è reato, no?”
“Ma questa persona, sa come si chiama?”
“Altroché”.
“Conosce il luogo dove abita, o dove lavora?”
“So tutto”.
“E ha ragionevoli argomenti per sostenere che si tratta di un immigrato clandestino?”
“Ne ho le prove”.
“Bene, lei ora mi dirà tutto, io verbalizzerò…”
“E andrete ad arrestarlo!”
“Se lo riterremo necessario”.
“Come necessario! Dovete farlo e basta! In Italia c’è… come si chiama… l’obbligatoria età”.
“L’obbligatorietà dell’azione penale. Certo che lei è un esperto”.
“Grazie. Ho studiato legge, al mio Paese”.
“Anche a me sarebbe piaciuto, ma sa… famiglia numerosa”.
“Non me lo dica”.
“Veniamo al dunque. Lei si chiama?”
“Qi Demei. Q, i, staccato Demei scritto come si pronuncia”.
“Ah, perfetto. E di cognome?”
“Qi”.
“Qi Qi Demei?”
“No, solo Qi staccato Demei”.
“Aaaaaah, ho capito. Scusi, eh, ma con tutti questi cognomi stranieri uno non ci capisce più…”
“Ha tutta la mia comprensione”.
“Bene. Allora, Qi Demei, nato il”
“Tredici luglio 1974”.
“Anno della tigre!”
“Complimenti. Non mi dica che...”
“Sì, confesso, sono anch’io del 1974. Dunque, Qi Demei, nato il tredici luglio 1974 e residente a…”
“Ahem… scriva così: residente a Canton, Cina”.
“Quindi lei non risiede in Italia”.
“No. Però una denuncia la posso fare lo stesso, no? Voglio dire… Se fossi un turista e mi rubassero il portafogli…”
“Giusto. Allora: Qi Demei, nato il 13/7/74 e residente a Canton, Cina, in data 23/9 presente anno si recava nella caserma dei carabinieri di Campogalletti (MU) e segnalava alle autorità competenti, ivi rappresentate dall’appuntato Panunzio Gabriele, la presenza su suolo italiano di un immigrato clandestino, rispondente al nome di-”.
“Sì?”
“Lo chiedo a lei: rispondente al nome di?”
“Eh?”
“Questo immigrato clandestino, insomma, come si chiama?”
“Ah, lui! Si chiama Qi Demei”.
“Cognome?”
“Qi”.
“Kikidemei?”
“No, Qi staccato Demei”.
“Aaaaah. Tra l’altro è un nome che ho già sentito… sta a vedere che ha dei precedenti”.
“Ma veramente…”
“Aspetti. Anche lei si chiama Qi Demei”.
“Non lo nego”.
“Un caso di omonimia, capisco”.
“No, forse non ha capito. Sono sempre io. Sono venuto a denunciare me stesso. Sono un immigrato clandestino. Arrestatemi”.
“Beh… beh… non corriamo”
“C’è la cosa, l’obbligatorietà dell’azione penale”.
“Ma scusi, perché ci tiene così tanto a farsi arrestare?”
“Si metta nei miei panni. Io lavoro ai mercati, faccio il giro della provincia. Tutte le mattine la sveglia alle cinque. Con la pioggia e con la neve. Cinque anni così. Non sono abituato, in Cina studiavo legge. Sono stanco”.
“Poteva anche venire prima”.
“Prima mi avreste rimpatriato come clandestino. Ma adesso non potete”.
“Come sarebbe a dire che non possiamo?”
“Non potete, perché l’immigrazione clandestina è diventato un reato, e quindi mi dovrete processare”.
“E che sarà mai un processo”.
“Ma io ricorrerò in appello”.
“Non mi faccia ridere … voglio dire, se tutti gli immigrati clandestini ricorressero all’appello…”
“Sì? Vada avanti”.
“Si bloccherebbero tutti i tribunali italiani!”
“Questo non è un problema mio. Io sono un indiziato di reato, e come tale ho diritto a un giusto processo – ah, e siccome lavorando io reitero il mio reato, perché rubo il lavoro ai commercianti italiani, credo che mi dovrete mantenere voi, in una prigione o altrove. Le vostre prigioni le ho viste, e confrontate al sottoscala dove dormo non sono male”.
“Ma scoppiano”.
“Già. Probabilmente sarete costretti a mettermi fuori, e a trovarmi un lavoro in attesa del giudizio. Ora, si dà il caso che io abbia studiato i tempi della giustizia italiana. Direi che cinque, sei anni di vitto e lavoro assicurati non me li toglie nessuno”.
“Ma poi la manderanno a casa”.
“Chi lo sa? Nel frattempo sarà cambiato il governo, e faranno una sanatoria. A dire il vero tutto lascia pensare che la sanatoria arriverà molto prima. È un peccato, perché poi mi toccherà tornare ai mercati. Io li odio, i mercati”.
“Doveva fare l’avvocato”.
“è vero. Andiamo avanti, le va?”
“Dunque: Qi Demei... segnalava alle autorità competenti, ivi rappresentate dall’appuntato Panunzio Gabriele, la presenza su suolo italiano di un immigrato clandestino, rispondente al nome di...”
“Qi Demei. Faccia copia incolla”.
“…nato il 13/7 eccetera… residente a?”
“Via Garibaldi tre, è il campanello con gli ideogrammi nel citofono. Se vuole lascio anche il cellulare”.
“Lei comunque la fa troppo facile”.
“Le cose stanno così! Adesso che sapete dove trovarmi siete costretti ad arrestarmi”.
“Ma lei potrebbe anche non essere un vero clandestino”.
“Certo che sono un vero clandestino”.
“Eh, facile a dirsi. Ma può provarlo?”
“Altroché. Non ho nemmeno un documento”.
“Questa non è una prova, al massimo è una mancanza di prove”.
“Sta scherzando?”
“Chi mi assicura, per esempio, che lei non abbia distrutto il suo permesso di soggiorno? Cioè, si metta nei nostri panni. Dobbiamo metterci ad arrestare il primo venuto soltanto perché dice di non avere documenti?”
“Prima lo facevate”.
“Ma prima era facile, con un foglio di via, al limite un bel charter e via al paese natale. Ma se adesso dobbiamo arrestarvi e giudicarvi tutti, eh, hai voglia”.
“Quindi non verrete ad arrestarmi”.
“No, credo di no”.
“La solita Italia. Fatta una legge, trovato l’inganno”.
“Piano con le parole, eh? Altrimenti...”
“Altrimenti?”
“Ti arresto per vilipendio”.
“Perfetto! Cos’è il vilipendio?”
“Sono le offese”.
“Ah, bene. L’Italia è una distesa di giunchi appassiti che oscilla al vento osceno della stupidità”.
“Eh?”
“Era un’offesa alla tua nazione. Arrestami”.
“Era solo una licenza poetica. Al massimo una libera espressione di giudizio. Non ti arresto”.
“Italia merda. Arrestami”.
“Ti piacerebbe, eh? Non ti arresto”.
“Mi devi arrestare! È vilipendio! C’è l’obbligatorietà!”
“No, invece, è satira, non ti arresto”.
“Il presidente è un invertito nazista”.
“Satira, satira politica”.
“Ma va’!”
“Come no? Guarda, rido anche, ah ah ah”.
“Donne italiane tutte puttane”.
“Ih Ih Ih, che spasso”.
...
Comments (27)
1/7.000.000.000
17-03-2008, 20:00attivismo, la Cina è vicinaPermalink Altri stracci
Altri stracciStavolta scrivo proprio a te, che qualche mese fa hai iniziato a portare uno straccetto rosso per la Birmania, e che poi, un giorno, non lo hai messo più.
E non credere che ti biasimerò per questo. Tra me e te non c'è nessun piedistallo su cui io possa salire anche solo un momento, nemmeno un tappetino, niente. Tu eri quello che portava lo straccetto, io quello che scuoteva la testa, e a distanza di mesi probabilmente sembriamo pirla uguale.
Però c'è stato un giorno – ci deve pur essere stato – in cui hai deciso che non l'avresti messo più. Un mattino in cui hai avuto meno tempo per vestirti o preoccuparti. La vita è fatta di singoli momenti, e non ci mancano certo le preoccupazioni per riempirli, eppure almeno due secondi per dire a te stesso “basta” devi averli spesi. Ti ricordi come ti sei sentito, in quel momento? Non è curiosità. Vorrei soltanto che tu sapessi che anch'io io mi sento così, tutti i giorni. Magari un secondo al giorno, ma la frustrazione è esattamente quella. Per cui lo vedi, alla fine lo straccetto a me non serviva davvero. E magari, per lo stesso motivo, tu hai fatto bene a metterlo. E pensi di rifarlo, adesso?
Gli storici avranno poi un'eternità a disposizione per stabilire se la Cina è diventata il futuro del mondo grazie o nonostante Marx e il suo materialismo storico, grazie o nonostante Mao e i suoi catastrofici balzi in avanti. Fatto sta che lo è diventato, principalmente per una questione demografica, e lo resterà ancora per un po'. Nel frattempo le nostre proteste lasciano il tempo che trovano. Se quel che scrive oggi Rampini non ti basta, ti consiglio un'inchiesta dell'Atlantic uscita sullo scorso Internazionale, che conferma più o meno la stima della riserva valutaria cinese, intorno ai 1000-1500 miliardi di dollari. È un dato che da solo squarcia il velo: la qualità della vita degli americani, quel valore che su tutti Bush riteneva sacro, è in ostaggio dei funzionari cinesi. Gli americani potranno continuare a consumare allegramente solo finché Pechino lo vorrà, e Pechino forse lo vorrà, perché se smettesse di sostenere il consumismo americano (e quindi il nostro) si troverebbe davanti a un'enorme crisi di crescita, senza precedenti storici: una prospettiva di fronte alla quale la repressione etnico-religiosa in Tibet impallidisce – e non credere che queste cose io le scriva a cuor leggero.
Perché sto scrivendo precisamente che il mio benessere di marca occidentale (taroccata a Singapore), già di per sé traballante, è fondato tra l'altro anche sulla repressione del Tibet, e che la globalizzazione è riuscita là dove le famigerate Ideologie del secolo scorso avevano fallito: per quanto possa aver corteggiato le dottrine comuniste io non sono mai stato complice di Pol Pot, ma vivendo in una società neoliberista sono complice di Hu Jintao e di Vladimir Putin, e il massimo lusso che posso concedermi è un dibattito sull'opportunità di boicottare le olimpiadi – rendiamoci un attimo conto, quelli sparano alla folla e noi discutiamo di olimpiadi. In verità vale la pena di assistere a testa alta ai giochi di Pechino, proprio perché celebreranno davvero la fine dell'ultimo sogno del Novecento: il sogno della democrazia, dell'autodeterminazione dei popoli, della libertà. Non c'è democrazia, non c'è libertà, e non ci sono popoli: c'è solo il mercato, e sul mercato l'indipendenza del Tibet non vale abbastanza.
Protestare ha senso? Certamente. Io ho protestato sin da bambino per questa o quella repressione e ho una stima sincera per chi lo fa. Un mio meccanismo di difesa interiore mi impedisce di abbracciare le cause che mi sembrino davvero senza speranza: la protesta può dare un senso alla vita, ma se quel senso è la sconfitta e la frustrazione, io mi scuso e mi chiamo fuori. Ho protestato per Tienammen, perché credevo sinceramente che la Cina fosse al bivio e che la democrazia fosse un'opzione praticabile: solo col senno del poi posso darmi torto. Ho protestato per l'Iraq, per i bombardamenti su Belgrado, e di nuovo per l'Afganistan e l'Iraq, perché ritenevo che nel mondo cosiddetto libero un margine di libertà esistesse davvero, e che la protesta civile lo potesse colmare, richiamando i governanti a più miti consigli. Ho protestato e protesto per la politica di occupazione di Israele, perché sono convinto che l'opinione pubblica occidentale giochi un ruolo in quel conflitto. Ma di fronte alla repressione in Tibet o in Birmania, e in Cina in generale, mi fermo. Non metto straccetti perché non li merito; o forse perché ritengo più dignitosa una posizione di consapevole disperazione. Sei libero di pensarla diversamente e di disprezzarmi pure, ma vorrei dirti un'ultima cosa.
Sono una persona, come te, e come te sono limitato in tutto. Anche nella mia disperazione. La Cina è gigante coi piedi d'argilla, che quella crisi di crescita la vivrà, prima o poi: forse tra trent'anni, quando sarà una nazione di figli unici di mezza età. Nessuno può dire come sarà il mondo per allora, ma per favore non pensare a me come a un disperato che si sfoga su un blog. Io credo di poter migliorare il mondo entro certi margini, e ci provo, tutti i santi giorni. Il mio lavoro, i miei studi, persino questo blog, sono fondati su questo. Da quando sono nato so di essere piccolo: ero un quattro-miliardesimi di umanità, in seguito sono diventato un sei-miliardesimo, e continuo a rimpicciolire, ma questo non vuol dire che io mi ritenga inutile. Non ancora. Se può servire a ricordartelo, a ricordarmelo, quello straccetto lo metterò anch'io. Il problema è che penso già al giorno in cui non avrò più voglia di metterlo, e i problemi saranno ancora là.
Comments (21)
well, you know
01-10-2007, 17:16Bush, la Cina è vicina, neoconiPermalinkTutti vogliamo cambiare il mondo...
La premessa è sempre quella: abbasso i dittatori (e i militari) e viva la libertà. In tutto il mondo. Amen.
Detto questo, ammetto che l’idea di vestirmi di rosso (o di zafferano), mi costa qualcosa, e che in questo giorni mi riesce difficile reincarnarmi nel ragazzino che andava in piazza per i giovani di Tienammen. Voi potreste dire che è l’età, la borghesia che si fa strada lungo le rughe. Ma non è solo questo. L’orizzonte che si apre sulla Birmania in questi giorni è oggettivamente più angusto di quello che si scoperchiava in Europa e in Asia nel 1989.
Il mondo del 1989, sotto i resti screpolati della guerra fredda, era un mondo vergine, senza un destino scritto. Nessuno sapeva come sarebbe andato a finire: non c’era più nessun equilibrio internazionale con cui fare i conti. Si andava in piazza perché si aveva la sensazione che il blocco orientale potesse crollare, e trasformarsi all’improvviso in qualcosa di nuovo. Oggi sembra ingenuo, ma in quel momento l’ingenuità era l’unica opzione.
Oggi, viceversa, è un lusso che non dovremmo permetterci. Possiamo vestirci di rosso (o di zafferano), ma dobbiamo ricordarci che la Birmania è un feudo della Cina, e che la Cina ha il suo veto nel Consiglio di Sicurezza; possiamo tifare per i monaci, ma nessuno ha ancora proposto di boicottare le olimpiadi di Pechino del prossimo anno; possiamo farci belli coi nostri accorati inviti alla libertà, ma nel frattempo sappiamo che la Cina entrata nel WTO, con le sue riserve di dollari e la sua manodopera che resterà a basso costo per generazioni, non è obbligata ad ascoltarci.
Accanto alla Cina c’è l’altra ex potenza in crisi, la Russia, molto più potente oggi di quanto non lo fosse nel 1988. Considerate semplicemente questo: Putin può farci passare l’inverno al freddo. È in grado di farlo. Nel 1988, Gorbaciov non poteva. Il mercato globale dell’energia ha reso inutili le testate nucleari: la paura del freddo è uno spettro molto più concreto di quello dei missili. E noi davvero pensiamo di poter fare pressione sull’asse Cina-Russia perché ci stanno a cuore i poveri monaci birmani?
E se un giorno – e mi auguro domani – la libertà arrivasse, la Birmania cosa diventerebbe? Un Paese civile e democratico o un altro fornitore di lavoro sottopagato? Oltre che, naturalmente, una meta per il turismo sessuale? È oggettivamente più difficile, oggi, fantasticare sulla libertà. Abbiamo visto troppe incarnazioni scadenti.
A far finta di niente, a tifare libertà sempre e comunque, si rischia di diventare stucchevoli come i neoconi, che a ogni rivolta vanno in brodo di giuggiole, e subito s’inventano il marchio (rivoluzione arancione, rivoluzione dei cedri, mancava soltanto la rivoluzione zafferano, appunto). È un’esibizione modaiola e a volte fastidiosa, visto che quel che possiamo fare per quelle persone è oggettivamente poco. Lo si è visto qualche anno fa, quando a seguire certi link sembrava che la rivoluzione progressista fosse imminente in Iran. E certo se bastasse un link, per aiutare i rivoluzionari, oggi l’Iran sarebbe una democrazia occidentale. Ma non lo è. Un’altra rivoluzione recente – quella arancione in Ucraina – forse sta per tramontare in queste ore, ed è difficile pensare che nelle cabine elettorali di Kiev non abbia inciso lo spettro di un altro inverno al freddo. E contro il freddo ben poco può l’agitar di bandierine.
I neoconi però insistono: il loro mondo è ancora quello del 1989, la rivoluzione liberale sembra sempre alle porte, se l’ONU continua a opporre dei veti si può anche sciogliere l’ONU, eccetera. Oltre a glissare sulla sostanza economica dei problemi, continuano a dare per scontato un fattore che oggi è in discussione: la forza dell’America, faro delle libertà mondiali... Ma è un faro molto più fioco e intermittente di qualche anno fa. E non è stato certo l’11 settembre a indebolirla. Il responsabile è Bush: doppiamente responsabile, perché non solo ha incastrato l’esercito più potente del mondo in una guerra di logoramento in Iraq, ma in quattro anni non è ancora riuscito a vincerla. In Iraq Bush ha scoperto le carte di quello che doveva essere la principale forza deterrente in mano alle democrazie occidentali: e gli è andata male. Peggio per lui e per noi. Non solo rischia la sconfitta militare, ma ora non può più bluffare; oltre al fatto che il gas russo e le riserve di valuta cinesi fanno comodo anche a lui. E al suo successore, che più di tanto non potrà cambiare le carte in tavola.
Ci sarà forse più libertà, nel mondo d’oggi; probabilmente in molti Paesi la vita è migliore rispetto al 1988. In compenso c’è meno speranza, in generale, al punto che è lecito chiedersi se il cambio sia stato un buon affare. È una sensazione non solo mia, che toglie l’aria e il gusto per la rivolta. Al tg1 l’han capito, e alla Birmania non dedicano nemmeno più l’apertura. Al vecchio panino di Mimun (Berlusconi-Fassino-Berlusconi) hanno sostituito quello nuovo di Riotta: un’esile fettina di Birmania tra due spesse fette di Garlasco. Corsi e ricorsi storici: dopo gli entusiasmi politici, subentrano i peli grigi e ci si butta sui romanzi noir. Ma sono io che invecchio, o il mondo?
Spero di essere io. In fondo mi fa rabbia dover sempre assistere in tv alle rivoluzioni degli altri. Il fatto è che non ho smesso di considerare la libertà come una lotta quotidiana: perciò in un monaco che fa lo sciopero della fame vedo più libertà che nel dibattito sulla finanziaria. Forse non saranno mai più liberi come oggi, mentre marciano e tirano sassi: tifare per loro è scontato, ma io li invidio proprio.
Comments (14)
edizione straordinaria
01-02-2007, 09:39coccodrilli, la Cina è vicina, migranti, Mondo CarpiPermalinkComments (16)
tabula rasa!
11-01-2007, 09:44chiudere i licei (con i prof dentro), la Cina è vicina, lingue mortePermalinkBisogna distruggere il latino
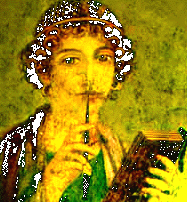 Caro Leonardo, hai sentito di quel quindicenne romano che avrebbe scritto all’economista di Financial Times chiedendo se è davvero così utile studiare il latino?
Caro Leonardo, hai sentito di quel quindicenne romano che avrebbe scritto all’economista di Financial Times chiedendo se è davvero così utile studiare il latino?
Sì, e ho anche trovato il link: toh.
Ma è scritto in inglese da economisti, non si capisce.
Già, è duro l’inglese, specie se lo studi nei ritagli di tempo tra una versione di latino e una di greco. Per fortuna la rubrica di Harford viene sempre tradotta in italiano da Internazionale: dovrebbe uscire in uno dei prossimi numeri.
Un quindicenne romano scrive all’economista del FT? Ce la beviamo?
Perché no? Dear economist è uno spasso. Harford risponde a qualsiasi domanda, ma con un’impostazione rigorosamente economista. Una volta ha risposto a un tale che chiedeva se in bagno fosse più conveniente abbassare o lasciare alzata la tavoletta. Perché non dovrebbe rispondere al 15enne romano?
L'economista risponde che il latino serve soltanto a discutere col Papa, e che il cinese sarebbe più utile. Tu naturalmente sei d’accordo con lui...
Al 90%. Specie quando sfata la leggenda che il latino ci aiuti a raffinare le nostre capacità logiche. È una sciocchezza. Quale sarebbe esattamente il contenuto ‘logico’ del latino? Le regole di morfologia e sintassi sono costruzioni a posteriori, piene di eccezioni e casi particolari. Al massimo si può dire che il latino sia molto complesso. Ma non più complesso della fisica quantistica o del cinese. Chi sostiene che l’apprendimento del latino renda più ‘elastici’ di una qualsiasi lingua straniera, di solito non ha studiato bene nessuna lingua straniera oltre al latino: insomma, è tutt’altro che un’intelligenza ‘elastica’.
Ma è una tesi sostenuta da molti…
…da molti insegnanti di latino, sì
Eppure chi si diploma al classico con buoni voti se la cava bene in qualsiasi facoltà.
Magari è anche vero. Ma non perché abbia studiato latino; semplicemente perché è una persona intelligente. In una buona percentuale è anche un ragazzo benestante, che gode nella sua famiglia di un’offerta culturale molto superiore a quella che gli offre la scuola. Nelle sua casa ci sono mensole piene di libri, canali satellitari di approfondimento, Internet, quotidiani già sfogliati, parenti laureati con i quali può scambiarsi opinioni. Gente così di solito va a scuola più per intrecciare relazioni che per approfondire conoscenze: se si trattasse solo di questo, potrebbe studiare in casa con molto più profitto.
Da soli? In casa?
Hai colto il problema: non si può. Per questi studenti cosiddetti ‘brillanti’, il liceo è soprattutto un parcheggio. E per un parcheggio quinquennale il latino è la materia ideale: non serve a nulla, ma occupa un sacco di tempo, e impararlo (approssimativamente) dà una certa soddisfazione. Ma non è che il latino ci renda più intelligenti: semplicemente, abbiamo deciso che gli alunni più intelligenti debbano sorbirsi cinque anni di latino. Se un giorno decidessimo di farli giocare per cinque anni a Yu-Gi-Oh, probabilmente il loro rendimento all'università sarebbe simile. Invece storicamente abbiamo scelto il latino, e continuiamo a insegnarglielo. Se almeno lo imparassero davvero.
Non lo imparano?
Una volta lo imparavano, forse. Ma prova a dare in mano l’Eneide a un qualunque diplomato della mia età. Chiedi di leggerlo e tradurtelo all’impronta. Non ce la farà. Ha studiato latino per cinque anni, ma senza vocabolario è un analfabeta. L’ottanta per cento, all’indomani dalla maturità, non riuscirà a decifrarti una banalissima lapide di chiesa.
Perché è una lingua molto difficile.
Forse. Oppure perché gli insegnanti del liceo non sono bravi. Oppure sono bravissimi, ma il metodo è tutto sbagliato. In ogni caso c’è qualcosa che non va. Dedichiamo al latino come minimo cinque anni della nostra vita, eppure nessuno lo sa, nessuno lo parla. Com'è possibile? Se l'insegnamento del latino fosse così efficace, dovremmo sfornare torme di latinisti. Non solo. Com’è che noi italiani abbiamo delle scuole elementari fantastiche e una percentuale di laureati da terzo mondo? Tra l’istruzione elementare e quella accademica c’è un dislivello pauroso: qualcosa in mezzo evidentemente non funziona, e nessuno ci ha ancora spiegato cos’è.
Magari è la Scuola media inferiore.
Magari sì. Però potrebbe anche essere il modello del Liceo, dove si continua a dare tanta importanza a una materia come il latino che – ammesso serva a qualcosa – comunque nessuno riesce a imparare come si deve.
Ma non è un’ossessione, quella del latino? È davvero così importante? Sul Giornale Lorenzo Scandroglio sostiene che il classico ormai è una riserva indiana. "Anche qualora si sia scelto un liceo, dove resistono le ultime sacche di «lingue antiche» sottoposte ad attacchi sempre più pressanti, sono ormai sempre più diffuse le sezioni sperimentali, senza la minima traccia né di latino, né di greco".
Io non so di che territorio parli Scandroglio: posso parlare del mio. Ogni anno mi arriva il libretto con l’offerta formativa delle scuole della provincia. Posso affermare che non esiste un solo liceo scientifico o classico, nella mia città, con una sperimentazione de-latinizzata. Se vuoi studiare spagnolo e tedesco, puoi: però devi farti anche le tue tre-quattro ore settimanali di latino. Affidate al prof di italiano, che di fatto diventerà il Boss del Consiglio di classe. Risultato: l’adolescente sarà istintivamente più motivato a sprecare un pomeriggio sulla versione che a memorizzare le declinazioni del tedesco (che pure sarebbero altrettanto “complesse”).
(Continua, stavolta sul serio)
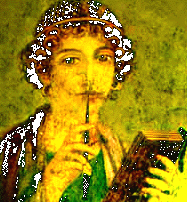 Caro Leonardo, hai sentito di quel quindicenne romano che avrebbe scritto all’economista di Financial Times chiedendo se è davvero così utile studiare il latino?
Caro Leonardo, hai sentito di quel quindicenne romano che avrebbe scritto all’economista di Financial Times chiedendo se è davvero così utile studiare il latino?Sì, e ho anche trovato il link: toh.
Ma è scritto in inglese da economisti, non si capisce.
Già, è duro l’inglese, specie se lo studi nei ritagli di tempo tra una versione di latino e una di greco. Per fortuna la rubrica di Harford viene sempre tradotta in italiano da Internazionale: dovrebbe uscire in uno dei prossimi numeri.
Un quindicenne romano scrive all’economista del FT? Ce la beviamo?
Perché no? Dear economist è uno spasso. Harford risponde a qualsiasi domanda, ma con un’impostazione rigorosamente economista. Una volta ha risposto a un tale che chiedeva se in bagno fosse più conveniente abbassare o lasciare alzata la tavoletta. Perché non dovrebbe rispondere al 15enne romano?
L'economista risponde che il latino serve soltanto a discutere col Papa, e che il cinese sarebbe più utile. Tu naturalmente sei d’accordo con lui...
Al 90%. Specie quando sfata la leggenda che il latino ci aiuti a raffinare le nostre capacità logiche. È una sciocchezza. Quale sarebbe esattamente il contenuto ‘logico’ del latino? Le regole di morfologia e sintassi sono costruzioni a posteriori, piene di eccezioni e casi particolari. Al massimo si può dire che il latino sia molto complesso. Ma non più complesso della fisica quantistica o del cinese. Chi sostiene che l’apprendimento del latino renda più ‘elastici’ di una qualsiasi lingua straniera, di solito non ha studiato bene nessuna lingua straniera oltre al latino: insomma, è tutt’altro che un’intelligenza ‘elastica’.
Ma è una tesi sostenuta da molti…
…da molti insegnanti di latino, sì
Eppure chi si diploma al classico con buoni voti se la cava bene in qualsiasi facoltà.
Magari è anche vero. Ma non perché abbia studiato latino; semplicemente perché è una persona intelligente. In una buona percentuale è anche un ragazzo benestante, che gode nella sua famiglia di un’offerta culturale molto superiore a quella che gli offre la scuola. Nelle sua casa ci sono mensole piene di libri, canali satellitari di approfondimento, Internet, quotidiani già sfogliati, parenti laureati con i quali può scambiarsi opinioni. Gente così di solito va a scuola più per intrecciare relazioni che per approfondire conoscenze: se si trattasse solo di questo, potrebbe studiare in casa con molto più profitto.
Da soli? In casa?
Hai colto il problema: non si può. Per questi studenti cosiddetti ‘brillanti’, il liceo è soprattutto un parcheggio. E per un parcheggio quinquennale il latino è la materia ideale: non serve a nulla, ma occupa un sacco di tempo, e impararlo (approssimativamente) dà una certa soddisfazione. Ma non è che il latino ci renda più intelligenti: semplicemente, abbiamo deciso che gli alunni più intelligenti debbano sorbirsi cinque anni di latino. Se un giorno decidessimo di farli giocare per cinque anni a Yu-Gi-Oh, probabilmente il loro rendimento all'università sarebbe simile. Invece storicamente abbiamo scelto il latino, e continuiamo a insegnarglielo. Se almeno lo imparassero davvero.
Non lo imparano?
Una volta lo imparavano, forse. Ma prova a dare in mano l’Eneide a un qualunque diplomato della mia età. Chiedi di leggerlo e tradurtelo all’impronta. Non ce la farà. Ha studiato latino per cinque anni, ma senza vocabolario è un analfabeta. L’ottanta per cento, all’indomani dalla maturità, non riuscirà a decifrarti una banalissima lapide di chiesa.
Perché è una lingua molto difficile.
Forse. Oppure perché gli insegnanti del liceo non sono bravi. Oppure sono bravissimi, ma il metodo è tutto sbagliato. In ogni caso c’è qualcosa che non va. Dedichiamo al latino come minimo cinque anni della nostra vita, eppure nessuno lo sa, nessuno lo parla. Com'è possibile? Se l'insegnamento del latino fosse così efficace, dovremmo sfornare torme di latinisti. Non solo. Com’è che noi italiani abbiamo delle scuole elementari fantastiche e una percentuale di laureati da terzo mondo? Tra l’istruzione elementare e quella accademica c’è un dislivello pauroso: qualcosa in mezzo evidentemente non funziona, e nessuno ci ha ancora spiegato cos’è.
Magari è la Scuola media inferiore.
Magari sì. Però potrebbe anche essere il modello del Liceo, dove si continua a dare tanta importanza a una materia come il latino che – ammesso serva a qualcosa – comunque nessuno riesce a imparare come si deve.
Ma non è un’ossessione, quella del latino? È davvero così importante? Sul Giornale Lorenzo Scandroglio sostiene che il classico ormai è una riserva indiana. "Anche qualora si sia scelto un liceo, dove resistono le ultime sacche di «lingue antiche» sottoposte ad attacchi sempre più pressanti, sono ormai sempre più diffuse le sezioni sperimentali, senza la minima traccia né di latino, né di greco".
Io non so di che territorio parli Scandroglio: posso parlare del mio. Ogni anno mi arriva il libretto con l’offerta formativa delle scuole della provincia. Posso affermare che non esiste un solo liceo scientifico o classico, nella mia città, con una sperimentazione de-latinizzata. Se vuoi studiare spagnolo e tedesco, puoi: però devi farti anche le tue tre-quattro ore settimanali di latino. Affidate al prof di italiano, che di fatto diventerà il Boss del Consiglio di classe. Risultato: l’adolescente sarà istintivamente più motivato a sprecare un pomeriggio sulla versione che a memorizzare le declinazioni del tedesco (che pure sarebbero altrettanto “complesse”).
(Continua, stavolta sul serio)
Comments (70)
- com'eravamo
02-02-2006, 03:21Bush, crisi energetica, Forum Mondiali, Il G8 di Genova 2001, la Cina è vicina, neoconi, Tremonti, WTOPermalinkTorto marcio
"Ma pensa che c'è gente che ancora si vanta di essere andata a Genova nel 2001!"
"Intendi al G8?"
"Tu guarda st'ignoranti..."
"Saputelli".
"Cacasotto".
"Picchiatori"
"Pacifisti".
"Terrioristi. Ma per cosa lottavano, poi, te lo ricordi?"
"Ma quelle cose lì, contro il governo e il commercio globale, non vogliamo un mercato del lavoro troppo competitivo, eccetera. Le solite cazzate da figli di papà"
"Pezzenti".
"Superficiali"
"Pesanti".
"Inconsistenti"
"Testardi. E naturalmente ce l'avevano con Bush".
"Di già? Ma che gli aveva fatto?"
"E che ne so. Il protocollo di Kyoto… Le cazzate sull'inquinamento e il risparmio energetico… La verità è che non si fidavano di un petroliere. I soliti dietrologi".
"Ingenui".
"Catastrofisti".
"Immaturi"
"Veterocomunisti".
"E Bush cosa gli disse?"
"Ma niente, lui era blindato nel porto, manco li vide. Deve aver detto: chi ci contesta ha torto marcio".
"Torto marcio? Come si dice in inglese?"
"E che ne so, lo lessi in italiano. Comunque rende l'idea".
"Aveva ragione. Erano solo dei velleitari".
"Dei nichilisti"
"Anarchici"
"Fascisti. E mi sembra d'aver detto tutto".
"E già".
"Ma cosa stai leggendo?"
"Io? Ah, è il libro di Tremonti. Avvincente. Te lo consiglio".
"Tremonti?"
"Interessante, molto interessante. Non la solita politica italiana da riunione di condominio. È un'analisi geopolitica di largo respiro".
"In poche parole…"
"In poche parole spiega che la società italiana sta correndo dei terribili rischi a causa del Wto, l'Organizzazione del Commercio Mondiale. Specie da quando è entrata la Cina, che non rispetta i diritti civili ed è molto competitiva sul mercato del lavoro".
"Forte Tremonti, eh?"
"Fortissimo. A proposito, hai sentito l'ultima di Bush?"
"Se ne va dall'Iraq?"
"No, no. Al discorso sullo Stato dell'Unione ha detto che gli USA sono dipendenti dal petrolio".
"Ha detto così?"
"Ha detto così: prima o poi dobbiamo ammetterlo, the United States Is Addicted to Oil. Che coraggio, eh?"
"Certo che quando ha ragione ha ragione".
"Cercheranno di importare meno petrolio dall'estero. E investiranno più soldi nei combustibili alternativi".
"Chiamali scemi. Adesso come adesso i soldi del petrolio arabo vanno agli emiri, gli emiri pagano la decima a Hamas, e alla fine col rifornimento di un gippone americano ci si finanzia il terrorista di Hamas. L'unico boicottaggio serio è smettere di comprargli il petrolio".
"Ed è anche una buona idea per l'ambiente. Con tutti 'sti uragani…"
"Quell'uomo è sempre pieno di buon senso".
"Peccato che in giro ci sia così poca gente ad ammetterlo. Specie da noi".
"Eh, ma cosa vuoi. Son tutti dei pecoroni".
"Bastian contrari".
"Carichi di pregiudizi".
"Segaioli".
"Selvaggi".
"Signori «so tutto io»"
"Incompetenti".
"Buoni a nulla e capaci di tutto".
"Smidollati".
"Paranoidi".
"Schizzati".
"..."
(Repeat and fade)
"Ma pensa che c'è gente che ancora si vanta di essere andata a Genova nel 2001!"
"Intendi al G8?"
"Tu guarda st'ignoranti..."
"Saputelli".
"Cacasotto".
"Picchiatori"
"Pacifisti".
"Terrioristi. Ma per cosa lottavano, poi, te lo ricordi?"
"Ma quelle cose lì, contro il governo e il commercio globale, non vogliamo un mercato del lavoro troppo competitivo, eccetera. Le solite cazzate da figli di papà"
"Pezzenti".
"Superficiali"
"Pesanti".
"Inconsistenti"
"Testardi. E naturalmente ce l'avevano con Bush".
"Di già? Ma che gli aveva fatto?"
"E che ne so. Il protocollo di Kyoto… Le cazzate sull'inquinamento e il risparmio energetico… La verità è che non si fidavano di un petroliere. I soliti dietrologi".
"Ingenui".
"Catastrofisti".
"Immaturi"
"Veterocomunisti".
"E Bush cosa gli disse?"
"Ma niente, lui era blindato nel porto, manco li vide. Deve aver detto: chi ci contesta ha torto marcio".
"Torto marcio? Come si dice in inglese?"
"E che ne so, lo lessi in italiano. Comunque rende l'idea".
"Aveva ragione. Erano solo dei velleitari".
"Dei nichilisti"
"Anarchici"
"Fascisti. E mi sembra d'aver detto tutto".
"E già".
"Ma cosa stai leggendo?"
"Io? Ah, è il libro di Tremonti. Avvincente. Te lo consiglio".
"Tremonti?"
"Interessante, molto interessante. Non la solita politica italiana da riunione di condominio. È un'analisi geopolitica di largo respiro".
"In poche parole…"
"In poche parole spiega che la società italiana sta correndo dei terribili rischi a causa del Wto, l'Organizzazione del Commercio Mondiale. Specie da quando è entrata la Cina, che non rispetta i diritti civili ed è molto competitiva sul mercato del lavoro".
"Forte Tremonti, eh?"
"Fortissimo. A proposito, hai sentito l'ultima di Bush?"
"Se ne va dall'Iraq?"
"No, no. Al discorso sullo Stato dell'Unione ha detto che gli USA sono dipendenti dal petrolio".
"Ha detto così?"
"Ha detto così: prima o poi dobbiamo ammetterlo, the United States Is Addicted to Oil. Che coraggio, eh?"
"Certo che quando ha ragione ha ragione".
"Cercheranno di importare meno petrolio dall'estero. E investiranno più soldi nei combustibili alternativi".
"Chiamali scemi. Adesso come adesso i soldi del petrolio arabo vanno agli emiri, gli emiri pagano la decima a Hamas, e alla fine col rifornimento di un gippone americano ci si finanzia il terrorista di Hamas. L'unico boicottaggio serio è smettere di comprargli il petrolio".
"Ed è anche una buona idea per l'ambiente. Con tutti 'sti uragani…"
"Quell'uomo è sempre pieno di buon senso".
"Peccato che in giro ci sia così poca gente ad ammetterlo. Specie da noi".
"Eh, ma cosa vuoi. Son tutti dei pecoroni".
"Bastian contrari".
"Carichi di pregiudizi".
"Segaioli".
"Selvaggi".
"Signori «so tutto io»"
"Incompetenti".
"Buoni a nulla e capaci di tutto".
"Smidollati".
"Paranoidi".
"Schizzati".
"..."
(Repeat and fade)
Comments (14)
- 2025
23-09-2005, 03:042025, crisi energetica, la Cina è vicinaPermalink Risciò a idrogeno
Risciò a idrogenoCaro Leonardo,
tutto bene? Un po' scosso? È dura, lo so. Vuoi un riassuntino? Ecco: più o meno vent'anni fa gli usastri decisero (sulla base di considerazioni non del tutto campate in aria) che avrebbero continuato a consumare idrocarburi e disseminare diossidi. La cosa inquietava i gialli (detti anche cinesi), da soli più o meno un quarto del consorzio umano: essi temevano che il riscaldamento globale provocato (forse) dall'effetto serra avrebbe ridotto drasticamente i raccolti di riso. Fu così che decisero di passare ad altre fonti d'energia, almeno loro. Tutto chiaro fin qui, no?
Ora si trattava di scegliere l'energia alternativa. L'opzione più immediata era la fissione nucleare; la Cina non aveva nemmeno bisogno di importare materie prime, le regioni centrali erano ricche di uranio: e chi avrebbe mai fatto caso ai tassi di radioattività nelle steppe dell'Asia centrale? Laggiù è ancora pieno dei freaks nati ai tempi dell'atomica sovietica.
Il Grande Balzo Nucleare conobbe però una brusca interruzione quando i primi due noccioli radioattivi sprofondarono in direzione Argentina (l'Argentina è agli antipodi della Rep Pop Cinese, lo sanno tutti). Malgrado l'enfasi operaista, i cinesi hanno una specie di congenita diffidenza nei confronti delle normative di sicurezza, molto utile quando si tratta di far dumping nel settore tessile, ma che con la fissione nucleare non paga.
E poi era anche una questione di mentalità. Il nucleare risponde a una logica centralizzata: c'è un grosso stabilimento (chiamato "centrale") che eroga energia elettrica a un contado. In apparenza l'ideale per una società monocratica e tecnorurale. I gialli però cercavano qlcosa di più. La globalizzazione fin de siècle li aveva contaminati, la modernizzazione post Xiao-Ping aveva creato una classe media di consumatori. Qui non si trattava soltanto di avere luce per le fabbriche e filobus: i gialli volevano le macchine! Come nei film usastri. E nella macchina non puoi metterci una pila a fissione. Bisognava trovare qualcos'altro. Qualcosa in grado di eclissare il fascino dell'oro nero, la fragranza inebriante della benzina appena munta al serbatoio.
Fu a quel punto che qualcuno, un giallo dal nome qualunque, si guardò intorno e disse (con ideogrammi suoi): ok, compagni, proviamo con l'idrogeno.
Le soluzioni migliori sono spesso le più banali. I gialli lo sanno. E non hanno questa fregola tutta occidentale dell'originalità a tutti i costi. Se l'idea migliore è venuta a qualcun altro, loro gliela copiano, che problema c'è. Avevano già copiato il nucleare. Trovarono il modo di scopiazzare anche le celle a combustibile, che da anni alimentavano i sistemi elettrici delle navette spaziali americane. Piazzarono un paio di spie alla Nasa – tanto, chi faceva più caso a un giallo in camice? Riportarono a casa i progetti più avanzati, secondo alcuni li perfezionarono (secondo altri no). Nel giro di cinque anni, ogni nucleo familiare urbano nella Rep Pop aveva la sua brava macchinetta a idrogeno. Col motore che non si scaldava mai. E uno scappamento che sputazzava ossigeno. L'impero di Diesel e Benz era finito.
Naturalm gli usastri non se la raccontano così. Sul supernet esistono un sacco di contenuti tesi a dimostrare che la pila a combustione è una tecnologia rigorosam made in USA. Hanno ragione. E le prime auto miste diesel-idrogeno nacquero in America ed Europa. Ma erano prodotti di nicchia, magari col catalizzatore ancora in platino. Costavano troppo. Erano un gadget per quel tipo di ricchi che si può permettere una coscienza ambientale.
La realtà è che gli usastri avevano sì scoperto la propulsione a idrogeno, ma più o meno come i greci all'apice della civiltà alessandrina scoprirono il vapore: alla stregua di una curiosità, di un optional. Teoricam, un'invenzione del genere avrebbe potuto scuotere la loro economia dalle fondamenta. Ma una civiltà secolare non ha quasi mai voglia di scosse di qsto tipo. Gli alessandrini non furono mai tentati di sostituire la forza lavoro degli schiavi con caldaie e bielle. Quanto agli usastri, avevano un sacro timore di alterare lo status quo, adottando un'energia più pulita. "Le pile a combustibile costano troppo", dicevano i produttori. E sarebbero continuate a costar troppo, finché nessuno programmava di adottarle in larga scala. Il libero mercato le rifiutava. Il regime di libera concorrenza sfavoriva un'innovazione senza prospettive di guadagno immediato. Il liberismo, in questo caso, assecondò l'inerzia e il declino usastro.
Ma i gialli, dall'altra parte del mondo, erano un miliardo e mezzo, guidati da una classe dirigente compatta. E quando un miliardo e mezzo di utenti di utenti passa di botto all'idrogeno, fidati, i costi di produzione precipitano. Dopo aver risolto il problema della locomozione privata, i gialli si avviavano di lì a poco a diventare il primo esportatore mondiale di automobili. A questo punto, capisci, era la guerra…
Comments (6)
- 2025
20-09-2005, 02:272025, la Cina è vicina, religioni, riscaldamentoPermalink
Il pericolo Giallo
Caro Leonardo
Come ti stavo dicendo: trovandosi a scegliere tra una catastrofe planetaria immediata e una nel medio-lungo termine, gli usastri fecero la scelta più ragionevole, cartesiana, occidentale: spassiamocela finché possiamo, e amen. Cercando di limitare le disgrazie, e magari di profittarne. Per esempio: le città sulla linea costiera si potevano trasferire nell'entroterra nordamericano, che è ben spazioso; agli uragani occorreva fare il callo, magari modificando un po' l'edilizia popolare, passando finalmente (secondo l'esempio europeo) dalla baracca in legno alla baracca in cemento. (E qui, pensa che pacchia per costruttori e immobiliaristi! Che meraviglioso fioccare di opportunità, un po' come dopo in Europa dopo qualche bombardamento a tappeto…) Altro cemento occorreva poi per imbrigliare in robuste dighe il Mississippi, nemico interno, che rischiava di invadere di acquitrini proprio il centro del Paese: dopodiché, tutto sommato, lo scenario non era dei peggiori. Il riscaldamento non avrebbe avuto troppi danni sull'agricoltura, il che era ottimo, perché nel giro di pochi anni il prezzo dei cereali sarebbe salito alle stelle negli altri Paesi allagati. Insomma, non tutti i mali venivano per nuocere…
Ma quando ti dico, Leonardo, che "gli usastri fecero la scelta più ragionevole", non vorrei che tu iniziassi a fantasticare paranoicam a un pomeriggio in cui un uomo, o più uomini (e magari anche qualche donna), bianchi e protestanti (ma anche un po' neri e cattolici) si riuniscono in una stanza (magari Ovale) a confrontare costi e benefici e concludere: "Ok, continuiamo pure a riscaldare l'atmosfera". No, decisioni di qsto tipo sono troppo importanti per essere prese in modo consapevole. In generale, l'idea di prendere decisioni ad alto livello in modo consapevole e razionale era considerata sorpassata in quei giorni. Come si diceva in quei tempi, in una lingua morta: laissez faire. Come il Debito Pubblico, anche il Riscaldamento Globale era diventato abbastanza grande per badare a sé(*).
La scelta degli usastri (o meglio, la loro non-scelta) poggiava però su un difettoso postulato: che ciò che andava bene per gli Usa sarebbe andato bene anche a tutti gli altri, volenti o no. Ma pur essendo di gran lunga i più potenti, e i maggiori responsabili dell'emissioni di Co2, gli usastri non erano l'unico impero sulla faccia della terra. Ce n'erano altri. I gialli, soprattutto. O cinesi, come preferivamo chiamarli, in quei tempi più gentili.
(O anche rossi, per via della loro religione).
A proposito di religione: è proprio vero che nessuno è profeta in patria. Lo disse per primo un nazareno che fece poi fortuna a Roma, a Mosca, finanche a San Francisco, ma è tuttora assai poco popolare a Nazareth. Come Buddha, che trovò la sua India in Tibet e in Giappone; Mosè stesso era un rinnegato egiziano. Ma l'esempio clamoroso è probabilm quello di Marx e Lenin. Si sarebbero mai immaginati, il filosofo tedesco e il rivoluzionario russo, che il loro destino era quello di fondare una quarta grande religione monoteista con capitale Pechino? Domanda stupida: un pescatore ebreo-palestinese chiamato Pietro poteva immaginarsi il cupolone di Michelangelo? E poi se la menano con le radici: ma cosa c'è di più contorto di una radice? Il marx-leninismo cinese è una tra le mille assurdità della storia. Tutto ciò che irrazionale è reale: ogni impossibilità è tale finché non si realizza. Eccetera eccetera.
La Repubblica Popolare Cinese è tuttora un robusto Stato teocratico; il potere è in mano a una casta sacerdotale che stila piani quinquennali e fucila gli eretici. E dire che a un certo punto sembrava quasi sul punto di occidentalizzarsi... Quando la Cina entrò nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, i guru festeggiarono: l'opinione corrente è che attraverso i buchi praticati per il commercio, le libertà occidentali sarebbero filtrate all'interno. Laissez faire. Laissez transpirer. Cazzate.
Si vide presto che la libertà non passava – ostruita da tonnellate di merci a prezzi stracciati, destinate a far saltare il banco mondiale dei diritti dei lavoratori. Dai fori uscì piuttosto una gelida brezza che trasportava perniciosi germi teocratici. Fu l'Occidente a orientalizzarsi, piano piano. Per contrastare la manodopera a prezzo irrisorio occorrevano Stati forti e gelosi delle proprie merci. Per avere Stati forti servivano ideologie forti. Siccome il comunismo in occidente era ormai irrecuperabile, non si trovò niente di meglio dei cari vecchi monoteismi tradizionali. E si videro così certe vecchie cariatidi ultraliberali, reduci da decenni di sermoni sulla fine delle Ideologie, accodarsi improvvisam sulla via di Damasco, riscoprire in un botto la Fede in Dio e nei suoi comandamenti, battezzarsi e bisbattezzarsi, ungersi e consacrarsi… troppo tardi, forse.
Anche i gialli avevano comunq i loro bravi problemi. Due, principalm: il riso e il petrolio. Due fonti energetiche indispensabili. Peccato che l'una escludesse l'altra.
Per alimentare il proprio sviluppo, la propria rivoluzione permanente, ogni anno la Cina importava dosi sempre più massicce di greggio. (Qsto, per inciso, stava già facendo lievitare i prezzi in tutto il mondo, e soprattutto in quei Paesi sciocchissimi in cui le merci viaggiavano principalm su gomma). Nessuno glielo impediva. Tutti riconoscevano il diritto dei gialli a liberare dosi sempre crescenti di diossido. Persino quel famoso Protocollo che comunq nessuno rispettava.
Intanto però i raccolti di riso calavano. E calavano a causa delle piene, dei tifoni, degli uragani. Cioè, in pratica, del Riscaldamento Globale.
Ora, mentre gli usastri avevano 'lasciato fare' alle lobbies, e le lobbies avevano mandato in vacca il consenso scientifico a furia di finanziamenti, i gialli, nella loro loro rigidità monoteista e vagam razionalista, continuavano ad avere per la Scienza un certo deferente rispetto. Se la maggior parte degli scienziati nel mondo continuava a collegare l'effetto serra alle carestia di riso, il Partito Comunista Cinese ci credeva. E prendeva le misure. Per questo era stato creato, no? per pianificare.
Per i mandarini del Celeste Impero Comunista si trattava di scegliere tra due opzioni: o comprare cereali dagli usastri, o trovare fonti di energia alternative per lo sviluppo industriale di un miliardo e mezzo di persone. E sì, possiamo anche fantasticare su cosa sarebbe successo se qualcuno di quei mandarini avesse avuto una passione per i popcorn. La Storia ci dice però che il Partito optò per la seconda soluzione: sostituire il petrolio con qualcosa di più pulito, possibilm made in China. Ma cosa?
(*)Qui c'è un probabile riferimento a un motto celebre di un Presidente usastro: "Il debito pubblico è abbastanza grande per badare a sé stesso", o qlcosa del genere.
Comments (3)
- 2025
20-05-2005, 02:322025, dialoghi, la Cina è vicinaPermalink La democrazia ha dei grossi limiti (e il tempo è una treccia)
La democrazia ha dei grossi limiti (e il tempo è una treccia)Ricapitolando, qlla notte a Bisanzio Arci m'insegnò tre cose. Cominciando dalla meno importante:
1. Io ho dei limiti. Tutto sommato, non sarei stato un'ottima alternativa a Berlusconi. Avrei portato al governo le mie incompetenze e idiosincrasie, così come lui aveva portato le sue. Il mio score finale era 2,5% ("gli annalisti ti ricorderanno come RUTELLI IL RISIBILE"). Da quel giorno mi fu più simpatico, tanto che in seguito fui onorato di prendere parte all'unità di crisi che organizzò il blitz e la liberazione del futuro pontefice del Teopop (io preparavo il caffè).
2. Anche la democrazia occidentale ha dei limiti, più tragici dei miei. Chiunque prenda per cinque anni il volante di una piccola grande nazione, può al massimo evitare dignitosam qualche buca nel tracciato. Non c'è tempo per cambiare la rotta. I principali disastri finanziari (la Fiat, la Parmalat), erano già in cantiere; i bond argentini sarebbero comunq crollati con o senza di me. In un senso aveva ragione Berlusconi: è colpa della gestione precedente. È sempre colpa delle gestioni precedenti.
"Sono qste maledette elezioni che ci fottevano. Ogni cinque anni cambiava tutto".
"E poi qlle a medio termine, le provinciali, comunali…"
"Se una farfalla batteva le ali ad Aci Trezza, a Roma cambiavano due ministri".
"E i referendum su questo e quello".
"Il sistema non selezionava buoni statisti. Selezionava solo ottimi conduttori di campagne elettorali. Che a loro volta avevano interesse a trasformare la vita politica nazionale in una campagna elettorale permanente. Ma scusa, tu investiresti in un'azienda che cambia tutti i quadri ogni cinque anni?"
"Ho investito un gatto, una volta".
"Ci difendevamo dietro l'alibi che lo Stato dovesse comunq divenire più leggero. Ma dove, ma quando. Lo Stato continuava a crescere, con gli interessi in ballo. Politiche ambientali, energetiche, militari; interi popoli in migrazione; la responsabilità dello Stato cresceva, e noi continuavamo a eleggere supplenti a tempo determinato. Se vuoi un lavoro fatto bene, non chiami un supplente a tempo determinato".
"Ma certo che no".
"Guarda i cinesi. Solo loro hanno saputo giocare la partita dall'inizio ad adesso. È dal 3000 BC che sono in campo. Hanno solo cambiato dinastia ogni tanto. La dinastia di adesso si chiama Partito Comunista".
"E funziona".
"Altro che piani quinquennali, i piani cinquantenari, fanno. Se c'è da spostare una regione per fare una diga, loro prendono la regione e la spostano. Niente comitati di protesta. Niente campagne elettorali. Pura gestione del potere. C'è tanto da imparare, sai".
3. Il futuro è già determinato, perché il tempo è una treccia. Qsta è l'idea di cui Arci andava più fiero. Come quel biologo (non mi ricordo il nome), che dopo aver studiato per anni il puzzle del DNA, un giorno si svegliò pensando: e se avesse la forma di una doppia spirale? Allo stesso modo, un giorno Arci si era svegliato con qsta idea: il tempo è una treccia, composta da vari fili annodati assieme e infiniti.
"I fili rappresentano i nessi di causalità. Mi spiego. Quand'ero studente una sera ho lasciato per sbaglio il frigo aperto, e ho rotto un pedale della bicicletta".
"Poverino, e quindi?"
"Lasciami continuare. C'è un filo che porta lo sportello del frigo lasciato aperto al buco al pedale della mia bicicletta: basta solo capire da dove passa. Nel frigo c'erano tre bistecche che il mattino dopo non erano molto fresche. Il filo lega sportello di frigo e bistecche".
"Non le hai buttate via".
"No. Detesto buttare via il cibo, così le ho mangiate. Ho camuffato il gusto del rancido alla maniera degli antichi: con molto pepe. Il filo passa dallo sportello del frigo al pepe".
"Il pepe fa male".
"Infatti tre giorni dopo ho avuto un'infiammazione alle emorroidi, e il filo passa anche da qui".
"Non so se ho voglia di sapere il seguito".
"L'infiammazione m'impediva di sedermi sul sellino della bicicletta, che era il mio mezzo di locomozione. Ma ero giovane e sportivo, così continuai a usarla per una settimana, reggendomi in piedi sui pedali. Finché uno dei pedali non ha ceduto sotto il peso. Ecco dove arriva il filo. Ma in realtà il filo non comincia e non finisce da nessuna parte: c'è un'infinità di fili che partono dall'infinito e finiscono nell'infinito".
"E se fosse un solo filo che compie infiniti giri?"
"È un'ipotesi molto elegante che ho accarezzato a lungo. Anche perché, se così fosse, basterebbe tirare il filo in un punto per cambiare tutto l'universo. Cambi le previsioni del tempo del 13 maggio 2001, metti bel tempo invece che pioggia, i berlusconiani vanno al mare, Rutelli vince le elezioni, l'Italia non va in crisi. Ma come vedi non è così. Il futuro è altrettanto determinato del passato. I fili sono infinitamente annodati tra loro, di modo che non puoi modificare più di tanto il loro assetto. Se tiri un filo da qsta parte, l'universo lo tira dall'altra, e il risultato finale non cambia".
"Stai dicendo che avresti rotto il pedale anche se avessi gettato via le bistecche?"
"Ti sto dicendo che oltre al filo che porta dalle bistecche al pedale, ce ne sono altri che passano per la mia passione smodata per il pepe, per il perno arrugginito dello sportello del mio frigo, per le mie emorroidi soggette a infiammazioni, per la fragilità dei pedali della mia bicicletta, tali da rendere comunq molto probabile il risultato finale. Le causalità sono fili, ma miliardi e miliardi di fili. Non puoi pensare di cambiare il mondo tagliandole un filo alla volta. Berlusconi ti sembrava molto importante, ma è solo un filo tra tanti".
"Un filo molto grosso".
"Non più grosso di tanti".
"Va bene, cosa mi vuoi dire? Che il futuro non si può determinare?"
"Ti sto dicendo che il presente è determinato tanto dal passato quanto dal futuro. È una sezione di una treccia infinita che non puoi districare, perché ciascun filo che la compone è infinito".
"Insomma, tu credi al destino".
"Ti sto presentando una descrizione scientifica e razionale del concetto di destino".
"Non ci vedo nulla di scientifico in qsto, Arci".
"Se ti rimetti il casco, ti posso mostrare scientificam in che modo…"
"No, va bene, mi fido".
Comments (8)
11-04-2001, 16:19Bush, contro l'identità, cultura, la Cina è vicina, scontro di civiltàPermalink
Le scuse dei cinesi
(ancora e sempre contro il concetto di differenza culturale)
…Noi però ci domandiamo come mai la Cina pretenda con tanta cocciutaggine delle scuse formali e non si accontenti del dispiacere espresso dagli Stati Uniti. Pensiamo allora che scusarsi abbia, nell'ottica cinese, lo stesso significato del nostro "chiedere perdono" e poniamo quindi la questione a partire da noi, cioè dall'Occidente.
Ed ecco che abbiamo, in scala per fortuna ridotta e soltanto sul piano culturale, almeno fino a questo momento, un tipico esempio di scontro tra civiltà. Se chiedere perdono e scusarsi avessero la stessa valenza, si capirebbe immediatamente perché l'America non accetta e sembrerebbe per lo meno temerario da parte cinese pretenderlo: chiedere perdono implica ammettere la propria colpa e nella nostra civiltà, che è quella della "colpa" - mentre quella cinese sarebbe invece la civiltà della "vergogna" - scusarsi e chiedere perdono hanno lo stesso significato, ovvero rimandano alle stesse categorie morali.
Renata Pisu, "Repubblica" di oggi.
Quanto siamo diversi. Quanto facciamo fatica a capirci. Già fra di noi che ci conosciamo la comunicazione non è che un reciproco patto di fraintendimento. Figurarsi poi quelli che non condividono la nostra lingua, la nostra "cultura"… I cinesi, per esempio. Scrivono con gli ideogrammi. Mangiano con le bacchette. Non bevono latte animale. E chiedono scuse formali quando gli americani violano il loro spazio aereo e fanno schiantare un loro pilota. Che gente strana. Che concetti misteriosi. "Scuse formali". Tradotto in occidentale cosa vorrà dire?
L'altro giorno ho lavorato con una traduttrice cinese. Lei leggeva delle frasi da turista ("Dov'è il bagno", "Mi sono perso", ecc.) e io incidevo. È stata un'emozione, perché il cinese (il mandarino, credo), è una lingua veramente diversa dalle nostre. Ma anche perché ci sono alcune cose che, malgrado millenni di sviluppo linguistico autonomo, malgrado gli ideogrammi, malgrado tanta cultura e tanta civiltà, ho capito al primo colpo. Le parole "mamma" e "papà", per esempio. E poi un tipo d'intonazione veramente universale, che fanno tutti i traduttori del mondo quando leggono una lista: ad esempio, quando arrivano alla penultima voce della lista, che siano persiani, cinesi o modenesi, fanno sempre la stessa nota, una specie di segnale: "e adesso sto per finire" (provate a leggere una lista a voce alta e capirete cosa intendo).
La cosa mi ha messo di buon umore. Va bene, siamo diversi, ma non così tanto. Probabilmente possiamo emozionarci e indignarci per le medesime cose. Purtroppo non avevo ancora letto l'interessante approfondimento culturale di Renata Pisu sulla Repubblica di oggi. No, i cinesi sono veramente diversi da noi, e non li capiremo mai – almeno finché non ce li spiega la Pisu o qualche altro giornalista con velleità antropologicoculturali.
Per esempio: se qualcuno li offende, pretendono che gli si chieda scusa. Ma pensa un po'. In Cina, questo "altro polo dell'esperienza umana", scusarsi, non implica a priori nessun riconoscimento di colpa, è un atto dovuto e senza drammatiche conseguenze, una ritualità da compiere, un'esigenza da rendere presente e da riproporre ogni qual volta se ne presenti l'occasione. Non si riconosce il valore catartico del perdono che per questo non si chiede e, di conseguenza, non viene concesso. Il fatto è che noi viviamo nella civiltà della "colpa", mentre i cinesi vivrebbero nella civiltà della "vergogna". La differenza non mi è molto chiara. I cinesi si scusano anche se non hanno colpa? Gli occidentali costretti a scusarsi non si vergognano? Mi pare di capire che per i cinesi "scusarsi" e "chiedere perdono" sono due concetti diversi. Sarà. Ma mi sembra una finezza, nel caso in questione.
Ecco, parliamo del caso in questione. Un aereo americano intercettato nel mar cinese. Per i trattati internazionali, si tratta di un luogo extraterritoriale. Per i cinesi no, perché è il mare che separa la Cina da Taiwan, e l'indipendenza di Taiwan non è mai stata riconosciuta. Per cui i cinesi si sentono violati, vanno a contrastarlo, succede un po' di confusione e ci scappa il morto. I cinesi sequestrano l'aereo americano, controllano se c'è qualche innovazione tecnologica da far propria, e intanto chiedono scuse formali agli americani, un po' per prendere tempo, un po' per non perdere la faccia con l'opinione pubblica (considerate che due anni fa la Nato gli ha bombardato un'ambasciata per sbaglio, a Belgrado). Gli americani non vogliono scusarsi, perché equivarrebbe a riconoscere che stavano violando lo spazio aereo cinese, cioè a riconoscere la sovranità cinese sull'omonimo mare. Mi sembra che questo sia tutto. Perché scomodare inedite categorie culturali, il confucianesimo, il cristianesimo? Non siamo mica dei barbari che si capiscono a gesti. E, se è per questo, non siamo più neanche tanto cristiani. (Né, sospetto, confuciani).
Il problema è che fino a oggi gli americani non avevano chiesto scusa: il massimo a cui si era arrivati era un "ci dispiace". Come a dire: "Sono cose che capitano". Non bisogna davvero immergersi nella cultura cinese per capire la differenza: un fatto "spiacevole" può avvenire senza la nostra responsabilità. Chiedere scusa invece significa ammettere la propria responsabilità. Quindi chiedere perdono. Forse i cinesi la vedono in maniera differente (da come si sono comportati in questo caso, mi sembra di no). Ma soprattutto: ammettere le proprie responsabilità significa ammettere che si violava lo spazio aereo cinese. Guerriglia diplomatica, altro che scontro culturale.
A meno che… ma che non sia questo il motivo per cui i top gun americani che si divertono a volare sotto le teleferiche nel territorio italiano, provocando decine di morti, non devono chiedere scusa a nessuno? Perché la nostra è la "cultura del perdono"? E allora come mai questa sensazione di… io sento come una specie di… ma sì, di rabbia, d'indignazione. Come mai? Devo avere un lontano parente a Pechino, o a Shanghai.
Ps.
Ho cercato "Sorry" nel bellissimo dizionario inglese-cinese www.zhongwen.com... e non l'ho trovato! E se non esistesse proprio la parola? Alla faccia della Pisu. Mi è andata meglio con "excuse":
(ancora e sempre contro il concetto di differenza culturale)
…Noi però ci domandiamo come mai la Cina pretenda con tanta cocciutaggine delle scuse formali e non si accontenti del dispiacere espresso dagli Stati Uniti. Pensiamo allora che scusarsi abbia, nell'ottica cinese, lo stesso significato del nostro "chiedere perdono" e poniamo quindi la questione a partire da noi, cioè dall'Occidente.
Ed ecco che abbiamo, in scala per fortuna ridotta e soltanto sul piano culturale, almeno fino a questo momento, un tipico esempio di scontro tra civiltà. Se chiedere perdono e scusarsi avessero la stessa valenza, si capirebbe immediatamente perché l'America non accetta e sembrerebbe per lo meno temerario da parte cinese pretenderlo: chiedere perdono implica ammettere la propria colpa e nella nostra civiltà, che è quella della "colpa" - mentre quella cinese sarebbe invece la civiltà della "vergogna" - scusarsi e chiedere perdono hanno lo stesso significato, ovvero rimandano alle stesse categorie morali.
Renata Pisu, "Repubblica" di oggi.
Quanto siamo diversi. Quanto facciamo fatica a capirci. Già fra di noi che ci conosciamo la comunicazione non è che un reciproco patto di fraintendimento. Figurarsi poi quelli che non condividono la nostra lingua, la nostra "cultura"… I cinesi, per esempio. Scrivono con gli ideogrammi. Mangiano con le bacchette. Non bevono latte animale. E chiedono scuse formali quando gli americani violano il loro spazio aereo e fanno schiantare un loro pilota. Che gente strana. Che concetti misteriosi. "Scuse formali". Tradotto in occidentale cosa vorrà dire?
L'altro giorno ho lavorato con una traduttrice cinese. Lei leggeva delle frasi da turista ("Dov'è il bagno", "Mi sono perso", ecc.) e io incidevo. È stata un'emozione, perché il cinese (il mandarino, credo), è una lingua veramente diversa dalle nostre. Ma anche perché ci sono alcune cose che, malgrado millenni di sviluppo linguistico autonomo, malgrado gli ideogrammi, malgrado tanta cultura e tanta civiltà, ho capito al primo colpo. Le parole "mamma" e "papà", per esempio. E poi un tipo d'intonazione veramente universale, che fanno tutti i traduttori del mondo quando leggono una lista: ad esempio, quando arrivano alla penultima voce della lista, che siano persiani, cinesi o modenesi, fanno sempre la stessa nota, una specie di segnale: "e adesso sto per finire" (provate a leggere una lista a voce alta e capirete cosa intendo).
La cosa mi ha messo di buon umore. Va bene, siamo diversi, ma non così tanto. Probabilmente possiamo emozionarci e indignarci per le medesime cose. Purtroppo non avevo ancora letto l'interessante approfondimento culturale di Renata Pisu sulla Repubblica di oggi. No, i cinesi sono veramente diversi da noi, e non li capiremo mai – almeno finché non ce li spiega la Pisu o qualche altro giornalista con velleità antropologicoculturali.
Per esempio: se qualcuno li offende, pretendono che gli si chieda scusa. Ma pensa un po'. In Cina, questo "altro polo dell'esperienza umana", scusarsi, non implica a priori nessun riconoscimento di colpa, è un atto dovuto e senza drammatiche conseguenze, una ritualità da compiere, un'esigenza da rendere presente e da riproporre ogni qual volta se ne presenti l'occasione. Non si riconosce il valore catartico del perdono che per questo non si chiede e, di conseguenza, non viene concesso. Il fatto è che noi viviamo nella civiltà della "colpa", mentre i cinesi vivrebbero nella civiltà della "vergogna". La differenza non mi è molto chiara. I cinesi si scusano anche se non hanno colpa? Gli occidentali costretti a scusarsi non si vergognano? Mi pare di capire che per i cinesi "scusarsi" e "chiedere perdono" sono due concetti diversi. Sarà. Ma mi sembra una finezza, nel caso in questione.
Ecco, parliamo del caso in questione. Un aereo americano intercettato nel mar cinese. Per i trattati internazionali, si tratta di un luogo extraterritoriale. Per i cinesi no, perché è il mare che separa la Cina da Taiwan, e l'indipendenza di Taiwan non è mai stata riconosciuta. Per cui i cinesi si sentono violati, vanno a contrastarlo, succede un po' di confusione e ci scappa il morto. I cinesi sequestrano l'aereo americano, controllano se c'è qualche innovazione tecnologica da far propria, e intanto chiedono scuse formali agli americani, un po' per prendere tempo, un po' per non perdere la faccia con l'opinione pubblica (considerate che due anni fa la Nato gli ha bombardato un'ambasciata per sbaglio, a Belgrado). Gli americani non vogliono scusarsi, perché equivarrebbe a riconoscere che stavano violando lo spazio aereo cinese, cioè a riconoscere la sovranità cinese sull'omonimo mare. Mi sembra che questo sia tutto. Perché scomodare inedite categorie culturali, il confucianesimo, il cristianesimo? Non siamo mica dei barbari che si capiscono a gesti. E, se è per questo, non siamo più neanche tanto cristiani. (Né, sospetto, confuciani).
Il problema è che fino a oggi gli americani non avevano chiesto scusa: il massimo a cui si era arrivati era un "ci dispiace". Come a dire: "Sono cose che capitano". Non bisogna davvero immergersi nella cultura cinese per capire la differenza: un fatto "spiacevole" può avvenire senza la nostra responsabilità. Chiedere scusa invece significa ammettere la propria responsabilità. Quindi chiedere perdono. Forse i cinesi la vedono in maniera differente (da come si sono comportati in questo caso, mi sembra di no). Ma soprattutto: ammettere le proprie responsabilità significa ammettere che si violava lo spazio aereo cinese. Guerriglia diplomatica, altro che scontro culturale.
A meno che… ma che non sia questo il motivo per cui i top gun americani che si divertono a volare sotto le teleferiche nel territorio italiano, provocando decine di morti, non devono chiedere scusa a nessuno? Perché la nostra è la "cultura del perdono"? E allora come mai questa sensazione di… io sento come una specie di… ma sì, di rabbia, d'indignazione. Come mai? Devo avere un lontano parente a Pechino, o a Shanghai.
Ps.
Ho cercato "Sorry" nel bellissimo dizionario inglese-cinese www.zhongwen.com... e non l'ho trovato! E se non esistesse proprio la parola? Alla faccia della Pisu. Mi è andata meglio con "excuse":

09-03-2001, 18:42calcio, giornalisti, la Cina è vicina, Manifesto, Moretti (Nanni)Permalink Quando è ormai il fine settimana, e non vale la pena di iniziare qualche cosa, ma d'altronde senza cliccare il cliccatore si annoia, che si fa?
Quando è ormai il fine settimana, e non vale la pena di iniziare qualche cosa, ma d'altronde senza cliccare il cliccatore si annoia, che si fa?
Si va nel sito del Manifesto. Li si trova sempre qualcosa di edificante.
Ieri per esempio ho trovato una recensione di certo Roberto Silvestri su La stanza del figlio di Nanni Moretti, di cui riporto un memorabile stralcio:
Più che la stanza, l'astanza, l'avrebbe chiamata Cesare Brandi, il contrario della realtà nella sua flagranza, preconscio e subconscio compresi. Niente naturalismo né realismo né surrealismo, né iper-realismo. E' mistero morettiano. E poi è il nono film e mezzo di Moretti (c'è un bacio vero, e un inizio di nudo di Laura Morante), il regista bradipo del cinema mondiale... Ma. Se a 15 anni avessi chiesto ai miei: "posso fare il sub?" mi avrebbero mandato a quel paese. Per chi abita nelle città di mare, le prospettive, però, son diverse […]
Certo, stralciare in questo modo non rende onore a una recensione che si prolunga per quasi 8000 caratteri, una monografia quasi (un'arecensione, direbbe Vittorio Panzana). Anche la chiusa, per esempio, è memorabile:
Andrea morendo indica una strada più misteriosa e sottomarina. E mette in guardia da una vita-fotocopia del contratto di Ancellotti: no alla vita agganciata alla produttività.
Ancellotti è il famoso allenatore della Juventus, ma forse il lettore medio ignora i termini del suo celebre contratto. Tanto peggio per lui, che pensa di poter arrivare alla pagina del cinema saltando le fondamentali rubriche sportive. La morale è: ci sono cose peggiori della morte, tipo i contratti a rendimento. Voi del resto ve li immaginate, i critici cinematografici del Manifesto con contratti a rendimento? Un tanto a battuta? Tantovale morire, in effetti.
Credo comunque che volesse dire che il film gli era piaciuto, che secondo lui valeva la pena di andarlo a vedere. Però… non so… ormai la trama me l'ha raccontata… mah.
Gli esilaranti calembour del Manifesto
Ma quel che mi rende ogni volta pieno di ammirazione è la capacità dei redattori del prestigioso quotidiano di saper riassumere tutti i fatti, i drammi e le tragedie del giorno, in sapienti giochi di parole, che strappano il sorriso del lettore nel mentre che lo educano a una visione più disincantata della realtà. Vediamo il titolone di oggi (venerdì). Salto Nel Voto. Mah. Non male, ma hanno fatto di meglio.
È difficile capire il perché, ma mi sembra di notare che l'estro dei redattori dia il meglio di sé in occasione di eventi luttuosi o catastrofici. Questa settimana abbiamo due o tre perle da mostrare:
Muore la scrittrice Luce d'Eramo: Una vita piena di Luce. (Un classico, ma funziona sempre).
Si diffonde il virus dell'afta epizotica, terribile per gli animali e i loro allevatori: Afta Siempre.
E (come in un crescendo wagneriano), così viene commentata la peggiore tragedia della settimana, il rogo di 41 bambini cinesi in una scuola (lavoravano alla preparazione di fuochi artificiali): Cina, pirotecnici compiti in classe.
Haaa haaa haaaa. Certo, detti a voce o anche riportati qui, estrapolati dal contesto, questi sapienti calembour perdono un po' del loro smalto, e diciamolo, non fanno così tanto ridere. Fanno però senz'altro meditare con maggiore lucidità sugli orrori del nostro quotidiano. Le smorfie che ci strappano sono l'espressione della nostra intelligenza critica. Afta siempre allevatori. Oggi è mancata la Luce. La classe… operaia va in paradiso. Heee heee heeee.
 Quando è ormai il fine settimana, e non vale la pena di iniziare qualche cosa, ma d'altronde senza cliccare il cliccatore si annoia, che si fa?
Quando è ormai il fine settimana, e non vale la pena di iniziare qualche cosa, ma d'altronde senza cliccare il cliccatore si annoia, che si fa?Si va nel sito del Manifesto. Li si trova sempre qualcosa di edificante.
Ieri per esempio ho trovato una recensione di certo Roberto Silvestri su La stanza del figlio di Nanni Moretti, di cui riporto un memorabile stralcio:
Più che la stanza, l'astanza, l'avrebbe chiamata Cesare Brandi, il contrario della realtà nella sua flagranza, preconscio e subconscio compresi. Niente naturalismo né realismo né surrealismo, né iper-realismo. E' mistero morettiano. E poi è il nono film e mezzo di Moretti (c'è un bacio vero, e un inizio di nudo di Laura Morante), il regista bradipo del cinema mondiale... Ma. Se a 15 anni avessi chiesto ai miei: "posso fare il sub?" mi avrebbero mandato a quel paese. Per chi abita nelle città di mare, le prospettive, però, son diverse […]
Certo, stralciare in questo modo non rende onore a una recensione che si prolunga per quasi 8000 caratteri, una monografia quasi (un'arecensione, direbbe Vittorio Panzana). Anche la chiusa, per esempio, è memorabile:
Andrea morendo indica una strada più misteriosa e sottomarina. E mette in guardia da una vita-fotocopia del contratto di Ancellotti: no alla vita agganciata alla produttività.
Ancellotti è il famoso allenatore della Juventus, ma forse il lettore medio ignora i termini del suo celebre contratto. Tanto peggio per lui, che pensa di poter arrivare alla pagina del cinema saltando le fondamentali rubriche sportive. La morale è: ci sono cose peggiori della morte, tipo i contratti a rendimento. Voi del resto ve li immaginate, i critici cinematografici del Manifesto con contratti a rendimento? Un tanto a battuta? Tantovale morire, in effetti.
Credo comunque che volesse dire che il film gli era piaciuto, che secondo lui valeva la pena di andarlo a vedere. Però… non so… ormai la trama me l'ha raccontata… mah.
Gli esilaranti calembour del Manifesto
Ma quel che mi rende ogni volta pieno di ammirazione è la capacità dei redattori del prestigioso quotidiano di saper riassumere tutti i fatti, i drammi e le tragedie del giorno, in sapienti giochi di parole, che strappano il sorriso del lettore nel mentre che lo educano a una visione più disincantata della realtà. Vediamo il titolone di oggi (venerdì). Salto Nel Voto. Mah. Non male, ma hanno fatto di meglio.
È difficile capire il perché, ma mi sembra di notare che l'estro dei redattori dia il meglio di sé in occasione di eventi luttuosi o catastrofici. Questa settimana abbiamo due o tre perle da mostrare:
Muore la scrittrice Luce d'Eramo: Una vita piena di Luce. (Un classico, ma funziona sempre).
Si diffonde il virus dell'afta epizotica, terribile per gli animali e i loro allevatori: Afta Siempre.
E (come in un crescendo wagneriano), così viene commentata la peggiore tragedia della settimana, il rogo di 41 bambini cinesi in una scuola (lavoravano alla preparazione di fuochi artificiali): Cina, pirotecnici compiti in classe.
Haaa haaa haaaa. Certo, detti a voce o anche riportati qui, estrapolati dal contesto, questi sapienti calembour perdono un po' del loro smalto, e diciamolo, non fanno così tanto ridere. Fanno però senz'altro meditare con maggiore lucidità sugli orrori del nostro quotidiano. Le smorfie che ci strappano sono l'espressione della nostra intelligenza critica. Afta siempre allevatori. Oggi è mancata la Luce. La classe… operaia va in paradiso. Heee heee heeee.






