Prima o poi lo prendono
12-07-2021, 13:12calcio, papàPermalinkIo potrei anche obiettare che però si coprono bene, tanto che i nostri proprio spazi non ne trovano, e Immobile non si vede da due partite, e anche Insigne, ma lui non risponde nemmeno, ha già detto tutto quello che deve dirmi e ha ragione – quand'è che non ha avuto ragione? Prima o poi qualcuno gliela mette dentro, magari un centrale. Magari juventino.
Anche se le partite le guardo da solo, non sono mai veramente da solo. A ogni passaggio, a ogni tiro, a ogni dribbling sento qualcuno commentare, gridare, sibilare, le voci di tutte le persone con cui ho visto una partita. Voci eccitate, arrabbiate, sorprese, tranquille. Molte volte dicono sciocchezze. Se la prendono da matti per falli inferti o simulati in quarti di finale di vent'anni fa. Tutto quello che so del calcio l'ho imparato da loro e quindi ne so veramente poco, in teoria. Ma se scavo sotto tutte quelle voci trovo come un brusio di fondo, una nota costante, la voce più tranquilla di tutte che non se la prende mai, tanto alla fine è un gioco. In effetti che ce ne viene in tasca a noi? (Tranne quella volta ad Atene, lì deve esserci restato male davvero se l'ho capito persino io, che ci stava male: ed è stata l'unica volta, l'unica che sono stato in pena per uno juventino).
Lui non avrebbe dato a notare nessuna particolare attenzione, anzi si sarebbe seduto davanti al televisore qualche minuto dopo il fischio – magari si sarebbe perso il gol inglese, come ieri ho fatto io. Non se la sarebbe presa affatto, un gol nei primi minuti non vuol dire niente. Sarebbe rimasto tranquillo per tutta la partita regolare, senza esibire il fastidio per i gridolini che mi uscivano ogni volta che vedevo un tiro che per me poteva andare in porta. Si sarebbe illuminato per il gol di Bonucci, ma senza urlare, come di una cosa che doveva per forza succedere. Poco dopo forse avrebbe spento, perché supplementari e rigori sono troppo stress, e a una certa età bisogna starci attenti. E il baccano, quaranta minuti dopo, non l'avrebbe probabilmente svegliato. Avrebbe festeggiato il giorno dopo: si fa per dire, un sorriso e via.
Anche se le partite le guardo da solo, non sono mai veramente da solo. Di calcio ne ho imparato così poco, ma anche stavolta mi è bastato. Se avessimo perso non sarebbe stato un dramma: se avessimo vinto senza rigori sarebbe stata più meritata. Se lui ci fosse stato comunque ora sarebbe contento. Lui non c'è più, proverò a essere contento io. Anche se ho il dubbio che non abbia più importanza.
Inginocchiarsi per chi, per cosa
23-06-2021, 00:08calcio, razzismiPermalinkLe foto sono strumenti potenti, ma non dicono necessariamente la verità. Le foto che immortalarono il podio olimpico dei 200 metri all'Olimpiade del 1968 mostrano due atleti neri col braccio alzato e il pugno chiuso – anche se non sappiamo ancora quanto il gesto costerà a entrambi, intuiamo di trovarci davanti a un gesto forte di protesta. A rendere l'immagine così potente è soprattutto il contrasto col terzo atleta, bianco e apparentemente indifferente: è lui a creare l'asimmetria necessaria. Il bianco guarda avanti, i neri protestano. Per innalzare quelle mani guantate serve così tanta forza di volontà che a Tommie Smith e John Carlos non ne resta per alzare la testa: sanno di essere vittime sacrificali ma fanno quel che è giusto fare, e poi sia quel che sia. Dopo aver visto queste foto è facile provare un moto d'odio per Peter Norman, il velocista australiano medaglia d'argento che guarda avanti e pare inconsapevole. È inevitabile ma è anche un errore: Norman non solo simpatizzava coi due colleghi e collaborò alla loro protesta (pagando anch'egli un prezzo alto); ma fu proprio lui a suggerire a Smith e Carlos di alzare in quel modo i pugni che, se ci fate caso, sono complementari: uno alza il destro e uno il sinistro.
 |
| John Carlos, Tommie Smith, Peter Norman (pubblico dominio). |
In effetti l'idea originaria era di alzare insieme pugni destri e sinistri, in una posa che avrebbe potuto essere scambiata per quella dell'atleta trionfante: a rendere esplicita la protesta nei confronti del segregazionismo USA sarebbero stati i guanti neri – oltre alla coccarda del movimento che promuoveva la protesta, l'Olympic Project for Human Rights. Carlos però si era scordato i guanti al villaggio olimpico. Fu Norman a suggerire a Smith di prestargli uno dei suoi: forse da australiano gli sfuggiva l'ostilità del pubblico mainstream americano nei confronti della gestualità del pugno chiuso, da decenni associata all'antagonismo di sinistra. Quello che invece Norman colse al volo è che mostrare i pugni spettava solo ai due colleghi: la loro protesta era giusta, ma era la loro protesta. Un pugno bianco e non guantato l'avrebbe soltanto annacquata. Norman si accontentò di indossare la coccarda dell'Olympic Project: tanto gli bastò per essere squalificato dalla federazione australiana. Ma perché mi sono messo a raccontare di un episodio di protesta sportiva di più mezzo secolo fa?
Molti lettori potrebbero averlo già capito (in fondo sono lettori del Post). Magari l'intento è confrontare le epiche e iconiche proteste del passato – quando alzare un pugno ti costava la carriera – con la situazione presente in cui ogni azione diventa immediatamente standardizzata e pigra, al punto che agli Europei non si capisce nemmeno più se il gesto veramente politico sia inginocchiarsi o no. Ecco, sì, forse volevo scrivere un pezzo del genere, ma come la metto con Colin Kaepernick? Come faccio a definire 'pigro' il gesto che ha inventato e che gli è costato una carriera professionistica nel football americano, non nel 1968 ma dal 2017 in poi? Quando Kaepernick smise di alzarsi durante l'inno nazionale Trump si era appena insediato alla Casa Bianca e i media stavano documentando una inquietante recrudescenza degli episodi di violenza delle forze dell'ordine nei confronti dei cittadini afroamericani (chi ricollega il gesto al più tardo assassinio di George Floyd sta già facendo della mitologia). In una prima fase Kaepernick rimaneva semplicemente seduto: un gesto di rottura molto forte nei confronti di una ritualità particolarmente consolidata negli USA, dove vige tuttora un rispetto religioso per simboli unificanti come l'Inno e la Bandiera. Ai giornalisti che glielo domandarono rispose senza mezzi termini: "Non mi alzerò per mostrare orgoglio per la bandiera di un Paese che opprime la gente nera e la gente di colore. Per me questo è più importante del football, e sarebbe egoista da parte mia guardare da un'altra parte. Ci sono morti nelle strade e gente stipendiata che uccide e la passa liscia". In seguito, dopo una serie di discussione con colleghi e veterani, Kaepernick decise di non restare seduto durante l'inno, ma di inginocchiarsi.
Il gesto nasce quindi da un compromesso: Kaepernick non intendeva offendere chi serve con orgoglio la sua nazione, ma continuava a far presente che questo orgoglio non poteva condividerlo. Così codificato, il gesto cominciò a essere imitato da alcuni colleghi, ma soprattutto divenne un'ossessione per Trump, che a più riprese chiese il licenziamento per chi lo praticava. Kaepernick probabilmente passerà alla Storia, proprio come Carlos e Smith: nel frattempo però ha smesso di giocare; nessuna squadra l'ha più cercato. Protestare è ancora un gesto rischioso, quando la causa è controversa e il pubblico non è pronto – ovvero, in tutti i casi in cui protestare ha veramente senso. Ecco, forse ora è chiaro dove sto andando a parare: quello che è nato negli USA all'interno di un movimento preciso (Black Lives Matter) con richieste precise (eliminare la violenza poliziesca soprattutto nei confronti della comunità afroamericana), forse in Europa è arrivato un po' di rimbalzo, più che per emulazione che per una reale esigenza sociale. Sto veramente arrivando lì? Perché non è molto lontano da quel che potrebbero dichiarare Orban e Salvini sull'argomento. Faccio ancora in tempo a correggere un po' la rotta?
A quanto pare i primi a inginocchiarsi in Europa sono stati i calciatori della Premier League – come sempre la Gran Bretagna è il filtro da cui ci arriva la cultura americana, un filtro tutt'altro che neutro. Inginocchiarsi su un campo di calcio inglese è un gesto irrituale, ma senza quella punta di blasfemia e vilipendio che veniva percepita sugli spalti degli stadi americani; la pratica si ispira esplicitamente al movimento Black Lives Matter, ma spostando l'obiettivo verso un più generico antirazzismo. Se è comunque abbastanza chiaro per cosa si stiano inginocchiando i calciatori inglesi, è un po' più difficile capire contro chi. Il bersaglio polemico non sembra più l'autorità costituita e le sue forze di polizia; in molti casi sembra che l'avversario sia il pubblico, le frange di tifosi che in effetti talvolta reagiscono fischiando. È uno scenario molto più vicino a quello degli spettatori italiani: la tensione tra squadre sempre più meticce e tifosi sempre più identitari o razzisti. A ogni contestazione, il sindacato dei calciatori professionisti ribadisce che i suoi iscritti continueranno a inginocchiarsi e che il pubblico questa cosa la deve accettare; insomma inginocchiarsi è un modo di chiedere al pubblico: da che parte stai? Anche in questo caso dietro al successo di un gesto di protesta c'è una negoziazione: inginocchiarsi è un gesto semplice, non rovina lo spettacolo e crea senz'altro meno tensioni e strascichi di altri (pensate ai casi in cui un calciatore o un'intera squadra reagisce ai cori razzisti ritirandosi dal campo e incorrendo in una squalifica).
Più che un gesto di protesta, in Europa l'inchino diventa un gesto identitario: appoggiare il ginocchio significa dichiarare rapidamente il proprio antirazzismo. Ed eccoci agli Europei, dove – contrariamente a quello che si sente in giro – nessun organo ufficiale ha chiesto ai calciatori di inginocchiarsi. I calciatori inglesi hanno fatto sapere che lo avrebbero fatto, gli scozzesi hanno scelto di farlo in occasione di Inghilterra-Scozia; altre nazionali sono andate in ordine sparso; la UEFA si è limitata a chiedere rispetto per chi decideva di inginocchiarsi. Nel frattempo però l'argomento ha raggiunto le prime pagine, forse perché la fase a gironi non è così eccitante (se a Cristiano Ronaldo basta spostare una bottiglietta per far discutere un paio di giorni). Con un'inversione tipica delle guerre culturali contemporanee, la scelta identitaria è diventata quella di non inginocchiarsi: persino Orban ha dedicato un po' del suo tempo a spiegare perché i calciatori ungheresi non sono tenuti a farlo. In effetti chi si inginocchia sta ancora protestando, o si sta limitando a citare in favore di videocamera un gesto ormai estrapolato dal contesto originario? La forza del movimento Black Lives Matter risiedeva anche nel modo in cui circoscriveva la sua protesta. Non un generico antirazzismo, ma le Vite dei Neri Contano: uno slogan che non a caso gli avversari hanno cercato di scimmiottare per depotenziarlo, con lo slogan All Lives Matter. La standardizzazione dell'inchino pre-partita corre forse lo stesso rischio: chi si inchina rischia di non sapere perché lo fa. Senz'altro non per chiedere il taglio dei fondi alla polizia americana, come chiedono gli attivisti BLM: e allora per cosa? Se è un gesto che si limita a definire un'identità, il rischio è che si trasformi in una ritualità vuota, l'ennesima pratica di virtue signaling un po' fine a sé stessa; col non trascurabile effetto collaterale di far emergere, per contrasto le posizioni di chi rivendica a voce alta il rifiuto dell'inchino, l'insofferenza per un antirazzismo imposto dall'alto più con la pressione mediatica che con la forza degli argomenti.
Spero di non essere frainteso (ma è inevitabile): sono contento se molti calciatori si sentono antirazzisti e vogliono testimoniarlo sul campo; ovviamente preferirei che avessero obiettivi chiari e non un generico antirazzismo d'importazione, visto che anche in Italia c'è molto da fare (pensate se qualche calciatore italiano s'inginocchiasse per le vittime delle forze dell'ordine italiane o per le vittime del razzismo italiano: pensate che scandalo vero sarebbe). Mi dispiace che tutto debba sempre essere importato acriticamente dall'America, non perché gli americani non abbiano ottimi motivi per protestare come protestano, ma perché sono motivi che non capiamo e comunque non sono i nostri. Ho la sensazione che l'inchino in Italia venga percepito come il blackface, cioè una cosa che non si è capito come funziona tranne che se ti sbagli tutto il resto del mondo ti dà del razzista e quindi anche chi non capisce prima o poi si adegua – laddove capire sarebbe sempre la cosa più importante. Trovo controproducente la pressione mediatica che sospinge giornalisti e politici a etichettare come razzisti i calciatori che rimangono in piedi e che magari semplicemente hanno le idee confuse (anche i calciatori a volte possono averle confuse). I gesti di protesta dovrebbero fare scalpore e generare emulazione, come successe a Carlos, Smith e a Kaepernick; se invece diventano divisivi, rischiamo che un sacco di gente si ritrovi sul lato dei razzisti semplicemente perché erano in piedi quando abbiamo fatto le squadre. Quando vedo un gruppo di calciatori un po' in ginocchio e un po' no, cerco di combattere l'impulso a dividerli in buoni e cattivi; lo stesso impulso che mi faceva odiare Peter Norman, quando ancora non conoscevo la sua storia e l'equilibrio con cui seppe stare dalla parte dei giusti senza togliere loro l'onore della ribalta.
(Quasi dimenticavo: oggi 23 giugno ricorre la festa dei 1003 Santi Martiri di Nicomedia, che si presentarono davanti all'imperatore Diocleziano per testimoniare la loro fede, e Diocleziano li fece ammazzare tutti e 1003. Giusto per ribadire che protestare è sempre stato pericoloso. Chi non rischia qualcosa non sta protestando davvero. Vale per tutti noi, in ginocchio o dritti in piedi).
Diego deve morire
26-11-2020, 20:22calcio, coccodrilli, fumetti, OttantaPermalinkDiego Armando Maradona termina la sua carriera calcistica in Italia il 17 marzo 1991, quando risulta positivo all'antidoping dopo una partita contro il Bari. Qualche mese dopo, ma sembrano secoli, nelle edicole italiane appare Nathan Never, un frullatore bonelliano in cui entrano tutti gli ingredienti della cultura fantascientifica degli anni Settanta-Ottanta. Film, fumetti, serie tv, manga, deve entrarci tutto perché i lettori vogliono trovarci tutto che fa sognare (e che non possono ancora rivedersi su Youtube), e nel giro di un anno ci entra anche Maradona, spudoratamente ritratto nel ruolo del protagonista di una storia (Il campione) che mette insieme Rollerblade, la Cosa dell'altro mondo e chissà cos'altro.
Maradona ci entra con la sua faccia inconfondibile e il suo carattere difficile (due minuti dopo averlo conosciuto, Legs vuole già menarlo) perché al tempo avvocati e procuratori hanno altro a cui pensare, ma anche perché a quel punto è già una Leggenda, persino nel senso di storia che si può accomodare come pare e piace a chi la racconta, e non può avere che un finale tragico: manca ancora il finale di carriera in Spagna e Argentina, l'assurdo mondiale del '94, eppure in un giornalino a fumetti italiano del '92 è già scritta la sentenza: Diego è un alieno nascosto tra noi mortali e inviso agli Dei, Diego tra vincere e sopravvivere non ha realmente scelta, Diego deve morire. È come se tutto fosse già inevitabile e necessario, persino nei dettagli finali: un collasso cardiocircolatorio, la pena che il destino infligge a chi vuole vivere troppo e troppo in fretta.
L'ultima notte
30-05-2020, 21:57anniversari, autoreferenziali, calcio, famigliePermalink Quella sera c'era la finale di Champions, Barcellona contro una squadra credo tedesca.
Quella sera c'era la finale di Champions, Barcellona contro una squadra credo tedesca.Di fronte al Grande Cancello dell'ospedale c'era un kebab, e io avevo fame, e quindi andai a mangiare il kebab. Stavano ancora giocando il secondo tempo.
Io il calcio ho smesso di guardarlo da un pezzo, pure mentre masticavo mi sembrava che il Barcellona stesse giocando contro l'oratorio, magari il prestigioso oratorio di Monaco o Brema o Schleswig Holstein, ma insomma sembravano terrorizzati, impalati, non c'era partita. La finale di Champions sembrava un allenamento, mi sembrava una presa in giro, non capivo.
E intanto erano passati... venti minuti? Quanto ci si mette a masticare un kebab? Riattraversai la strada.
Il Grande Cancello era chiuso.
Come chiuso?
Così. Prima si entrava, adesso no. A farci caso c'era anche scritto sopra, c'era un cartello con gli orari. Ma era rivolto verso l'esterno, per cui uscendo non me ne ero proprio accorto.
Oppure non ci avevo fatto caso. Nella mia città gli ospedali non ce li hanno i cancelli, la gente quando vuole entrare entra. Ma questa non era esattamente la mia città e adesso io ero fuori.
Fuori dall'ospedale.
Stavo per diventare padre ed ero fuori.
Per un lunghissimo minuto riflettei sulla mia inadeguatezza, sulla mia avventatezza, su porca puttana son dieci anni che non guardo una partita mi devo proprio metter lì a cercar di capire perché non marcano Messi? Consapevole che qualsiasi cosa avrei detto o fatto nella vita, non c'era più niente da fare, sarei sempre rimasto il padre rimasto fuori dal cancello.
"Papà maccheccazzo vuoi che manco c'eri la notte che son nato, mavvanculo va".
"Figliolo, fu un attimo, avevo fame".
"Papà, ma vaffanculo, c'era Messi in tv lo sanno tutti".
Per sempre questo. Una notte, una sola notte nella vita mi serviva, e mi ero messo a guardare il Barcellona.
Per un lungo minuto pensai a tutto questo.
Poi girai l'angolo ed entrai dal Pronto Soccorso.
Non era successo niente, non sarebbe successo niente ancora per parecchio. Passai la notte sul pianerottolo, accucciato tra la panchina e la macchinetta degli snack. Ma dormii sodo. Negli anni successivi lo avrei spesso rimpianto.
Il Santo che batté il Brasile. Due a uno.
04-06-2019, 01:55calcio, repliche, santiPermalinkSan Cono di Diano o Teggiano (XIII secolo), patrono ufficioso di chi si rovina al lotto e della nazionale di calcio dell'Uruguay.
 |
| E lo stadio era pieno (record ineguagliato di spettatori). |
Non era una finalissima vera e propria perché, per la prima e fin qui unica volta nella storia della FIFA, la fase finale del torneo era un girone all'italiana con quattro squadre: ma le due europee qualificatesi, Spagna e Svezia, si erano dimostrate molto inferiori al gioco delle sudamericane. Il Brasile, in particolare, aveva infierito su entrambe: 7-1 contro la Spagna, 6-1 contro la Svezia. L'Uruguay aveva più modestamente superato la Svezia per 3 reti a 2, e contro la Spagna aveva addirittura pareggiato. Dunque quella sera al Brasile bastava un pareggio. Già, ma voi avreste mai scommesso su un pareggio del Brasile, al Maracanà appena costruito, davanti a duecentomila spettatori paganti, nella finale di Coppa del Mondo?
Era stato un mondiale stranissimo, un difficile tentativo di recuperare la normalità dopo la lunga interruzione dovuta alla guerra mondiale. Su 16 squadre qualificate, solo 13 si erano presentate. L'India era stata squalificata perché si faceva un punto d'onore di giocare a piedi nudi. La Scozia non era venuta perché non sopportava l'idea di non essere testa di serie come l'Inghilterra. L'Inghilterra non aveva molta esperienza del gioco oltremanica, e si ritrovò sbigottita a perdere 0-1 contro gli Stati Uniti d'America. L'Italia - detentrice del titolo, conquistato dodici anni prima in camicia nera - si era presentata stremata da un viaggio di tre settimane in transatlantico. Le altre squadre avevano preferito prendere l'aereo, ma la federazione italiano aveva appena perso gran parte dei titolari nel disastro di Superga, e non se la sentiva di rischiare. Il transatlantico si era rivelato un pessimo ambiente per un ritiro: tutti i palloni dopo qualche giorno erano finiti nell'oceano. Inseriti in un girone a tre con Svezia e Paraguay, perdemmo con la prima che pareggiò col secondo, e a quel punto eravamo già fuori: vincemmo comunque col Paraguay ed eravamo già pronti a re-imbarcarci.
A quel punto non restava che tifare Uruguay, una delle nazioni più italiane del mondo. Italiani erano i cognomi dei titolari più titolati: Ghiggia, Schiaffino. Entrambi avrebbero qualche anno più tardi indossato la maglia della nostra nazionale. Il capitano, Obdulio Varela, prima della partita invoca addirittura un santo italiano, Cono da Diano. Promette, in cambio della vittoria, di compiere un pellegrinaggio a piedi da Montevideo al santuario di San Cono a Florida, ridente cittadina dell'Uruguay. Ma perché proprio San Cono?
 |
| La cappella di San Cono a Florida (Uruguay) |
Del resto il forno era il suo habitat, ci entrava dentro per cucinare; col tempo aveva magari sviluppato una certa resistenza. È anche vero che morì giovane: e che a un anno dal decesso ancora non avevano deciso dove seppellirlo. Ne reclamavano le spoglie ancora incorrotte sia Diano che Padula - quest'ultimo centro non so a che titolo - finché non si decise di tirare a sorte, abbandonandole a metà strada su un carretto legato a due buoi. I due buoi presero di buona lena la strada per Diano e si fermarono solo davanti alla chiesa del paese. Vince Diano, perde Padula.
Gli abitanti lo eleggono subito protettore del paese e ricorrono a lui a ogni crisi. Le solite cose: una guerra coi vicini, un assedio, un’epidemia, il terremoto del 1857. Santificato nel 1871, durante le migrazioni di fine Ottocento Cono comincia a essere venerato anche nell’Altro Mondo. In particolare a Florida, Uruguay, dove al suo esordio in una processione pubblica fa tremare la terra. L’Uruguay ha la sua parte di sfortune, come ogni Paese del mondo, ma non è zona sismica: il terremoto è un prodotto d’importazione, grazie San Cono. Per diciassette anni nessun sacerdote mette piede nella cappella a lui dedicata. Più che superstizione, è il segno di un conflitto tra la comunità italiana che l’aveva portato con sé da Teggiano e la curia locale, ispanofona. Il dissidio viene superato in un modo bizzarro quando il 3 giugno del ’45 sulla ruota di Montevideo esce il 3. Il giorno della morte di San Cono, il giorno della sua festa in Cielo.
Due giorni dopo si estrae il primo premio della lotteria nazionale: il numero del biglietto finisce per 3. Può essere una coincidenza, ma a quel punto molti bravi uruguagi si mettono a giocare numeri che finiscono per 3. La situazione degenera al punto che le lottomatiche del Paese decidono di imporre limiti alle puntate sul 3 nelle settimane a cavallo tra maggio e giugno
A questo punto la cabala si scatena. Il tre negato in Uruguay può sempre uscire sull’altra riva del Rio della Plata, in Argentina. Oppure si può giocare il 2, o il 4: è l’intenzione che conta, il Santo capirà. Se esce l’12, è il secolo in cui nacque; il 13, quello in cui morì. A proposito, forse morì a 18 anni: controlla, due settimane fa è uscito un 18. È stato canonizzato nel 1871: prova il 18, il 71 o 1+8+7+1=17. La sua cappella è al numero 50 della strada numero 26. E così via.
L’ultima partita della Coppa del Mondo del 1950 si giocò il 16 luglio (1+6=7: le lettere di S-a-n-C-o-n-o). Gli spettatori erano 199.854, di cui un centinaio uruguagi. Molti tifosi brasiliani vestivano già la maglietta Brasil campeão 1950. La partita fu preceduta da un discorso del prefetto che salutava i connazionali come campioni del mondo. Insomma si possono dire tante cose dei brasiliani, ma non che pecchino di scaramanzia.
Venti minuti dopo Ghiggia serve un cross a Schiaffino. Uno a uno. Tosto, però, l’Uruguay. E va bene, tanto al Brasile basta un pareggio. D’altro canto, è il Brasile. Nello suo stadio nuovo, concepito apposta per il trionfo. Non può mica cominciare a coprirsi, non sarebbe nemmeno capace. Altri tredici minuti. Ancora Ghiggia. Due a uno per l’Uruguay.
Due più uno fa tre.
A quel punto l’Uruguay serra le file – forse sanno che San Cono non ha più numeri a disposizione – o forse è il silenzio spaventoso dei duecentomila spettatori che non festeggiano più, non gridano più. Quando l’arbitro fischia tre volte, la Coppa sembra dissolversi in una nebbia d’angoscia. La banda non suona perché non si sono portati lo spartito dell’inno dell’Uruguay, e di suonare quello del Brasile non è veramente il caso. Jules Rimet, presidente FIFA e inventore della coppa del mondo, cerca le autorità brasiliane per andare a consegnare il trofeo, ma non le trova – sono tutti scappati. Scende in campo, vede piangere i soldati in uniforme di gala che dovrebbero creare il cordone di sicurezza. Individua Varela, lo saluta, gli consegna il trofeo d’oro che comincia a scottargli in mano, e scappa pure lui. Sulle gradinate non c’è la violenza come la conosciamo oggi. I brasiliani se la prendono con sé stessi. Si lanciano dagli spalti. Alcuni accusano fitte al petto; si contano almeno dieci infarti. Molti avevano scommesso sulla vittoria. Il governo proclamerà tre giorni di lutto nazionale. Il Brasile non giocherà per due anni, e abbandonerà per sempre la maglietta bianca e il colletto blu con cui aveva disputato tutte le competizioni internazionali fino a quel momento (la tenuta verde-oro debutterà quattro anni più tardi nel mondiale in Svizzera).
Al santuario di San Cono, Florida, tra gli ex-voto c’è una maglietta bianco-azzurra della nazionale dell’Uruguay. La leggenda racconta che l’abbia portata un calciatore, a piedi da Montevideo.
PS: Forse avrete sentito dire che quest’anno, dopo 64 anni, la Coppa del Mondo si disputa di nuovo in Brasile. Il 24 giugno si gioca Italia-Uruguay. 2+4=6. Giugno è il sesto mese. 6+6=12. 1+2=3. Coincidenza? Noi della rubrica dei santi del Post crediamo di no.
Il piccolo centravanti africano
03-09-2014, 02:37calcio, migranti, racconti, ragazzini, scuolaPermalinkNon è che gli alunni mi salutino mai troppo volentieri, incrociandomi sul corso; ma è ai primi di settembre che cominciano a nascondersi dietro le colonne, quasi vergognandosi di abbronzature perfette. Hanno un gelato in mano e una ben più fredda consapevolezza sulle spalle: non ce la faranno mai a finire i compiti. Li hanno appena iniziati. Forse non vale neanche la pena di provare. Io faccio finta di niente, e penso che forse era più onesto Mahmadou.
Mahmadou era nero e centravanti prima che fosse cool. Non era esattamente un campione - sgambava tra l'area e il centrocampo in magliette sempre troppo larghe sulle spalle, eredità di un fratello maggiore; aveva fiato e un buon tocco, ma era ancora troppo cucciolo per mettere in soggezione terzini e portiere. Anche i suoi compagni più cari lo chiamavano Mamma, soprannome sommamente infelice a cui si era affezionato. Mamma me lo disse chiaro e tondo, quando in giugno fui per dettare i compiti delle vacanze: non se li sarebbe scritti, un po' perché aveva lasciato a casa il diario, un po' perché dai, non ne valeva la pena; quell'anno andava in vacanza anche lui, e non poteva portarsi i libri giù in Africa.
Obiettai che poteva farne comunque un po' prima di partire; mi spiegò che partiva subito, appena finita la scuola; che non ci sarebbe stato nemmeno il tempo di mandare i genitori a ritirare la pagella, l'aereo si stava già scaldando sulla rampa. Né poteva posporli al ritorno, i compiti, perché sarebbe tornato tardissimo, a settembre inoltrato, se non più in là: non dovevamo però preoccuparci, potevamo benissimo cominciare la scuola senza di lui. Portarsi i compiti giù al villaggio? Fuori discussione: anche se si fosse trovato un posticino in valigia - e non c'era - Mamma mi spiegò che la vita nel villaggio è molto diversa da quella che conduciamo qui: c'è tutta una dimensione comunitaria che purtroppo a noi sfugge, blindati come siamo nelle nostre nicchie alienanti. Una volta arrivato laggiù, Mamma si sarebbe messo immediatamente a giocare a pallone coi suoi amici, perché è così che funziona; e non avrebbe smesso finché l'aereo del ritorno non avesse iniziato le procedure di decollo. Mi spiegò, Mahmadou, che la sola idea di dire ai coetanei: "ora non posso giocare, devo fare i compiti" era da rigettare come un ingenuo cascame del mio colonialismo interiore: in una società rurale africana non ci si può isolare dal gruppo, non si possono fare i compiti. La volontà di isolarsi si trasforma immediatamente in uno stigma sociale, quando non somatizza prendendo le forme di una vera e propria malattia. Davvero volevo renderlo un paria, un lebbroso agli occhi dei suoi fratelli? Non poteva fare i compiti; non dipendeva da lui. Eccetera.
"Ora prendi un foglio e te li scrivi lo stesso".
"Ma prof..."
"Qualcuno ha una penna da prestare a Mahmadou?"
Verso i primi d'agosto ormai l'ordine alfabetico degli alunni è un ricordo lontano, che si infrange tra la lettera G e la L. Per quanto possano riempirmi di vita fino a metà giugno, i loro volti svaporano nel giro di due mesi, e così a momenti non riconobbi Mahmadou, un pomeriggio che passai per l'Africa, diretto alla coop. L'Africa in questione era il parcheggio di un centro direzionale affacciato sull'incrocio: un luogo losco a un'ora dal tramonto, ma ideale per il calcetto, a causa di un materiale gommoso, nero, con cui era stato pavimentato, più morbido del cemento - anche se assorbe il calore del primo pomeriggio come una spugna, e non lo lascia andare fino a mezzanotte. Mamma teneva un Supertele in grembo. Lui e i suoi amici indigeni erano seduti sul muretto che delimitava il continente, a prender fiato: sarebbe stato il momento giusto per un sorso d'acqua o magari un gelato, ma avrebbero dovuto lasciare l'Africa nera, attraversare la strada e aprire una linea di credito col barista cinese.
Mahmadou fu di parola: passò tre mesi interi nella sua Africa di quartiere, senza mai venir meno alle regole non scritte della tribù. A settembre tornò tra noi, senza penna né diario. Com'è andata l'Africa, Mahmadou? Bene, prof, bene. Là è tutto diverso, la vita non stinge sotto la pioggia, né imbrunisce col sole. Ogni cosa ha per sempre quel colore con cui uscì dallo stampo.
Il santo che fermò il Brasile (due a uno).
03-06-2014, 03:34calcio, santiPermalink
San Cono di Diano o Teggiano (XIII secolo), patrono ufficioso di chi si rovina al lotto e della nazionale di calcio dell'Uruguay.
L'Uruguay è un piccolo Paese con un record calcistico impressionante: schiacciato tra Brasile e Argentina, ha vinto più Coppe America di entrambi. In effetti, ha vinto più Coppe America di qualsiasi altro Paese. È stata la prima nazione a organizzare una Coppa del Mondo (1930) e a vincerla; nelle due edizioni successive - vinte dall'Italia - non partecipò nemmeno. Si ripresentò nel 1950, al primo mondiale disputato in Brasile: e proprio contro il Brasile si trovò a disputare l'ultima partita, decisiva per aggiudicarsi il torneo. Al Maracanà, figuratevi.
Non era una finalissima vera e propria perché, per la prima e fin qui unica volta nella storia della FIFA, la fase finale del torneo era un girone all'italiana con quattro squadre: ma le due europee qualificatesi, Spagna e Svezia, si erano dimostrate molto inferiori al gioco delle sudamericane. Il Brasile, in particolare, aveva infierito su entrambe: 7-1 contro la Spagna, 6-1 contro la Svezia. L'Uruguay aveva più modestamente superato la Svezia per 3 reti a 2, e contro la Spagna aveva addirittura pareggiato. Dunque quella sera al Brasile bastava un pareggio. Già, ma voi avreste mai scommesso su un pareggio del Brasile, al Maracanà appena costruito, davanti a duecentomila spettatori paganti, nella finale di Coppa del Mondo?
Era stato un mondiale stranissimo, un difficile tentativo di recuperare la normalità dopo la lunga interruzione dovuta alla guerra mondiale. Su 16 squadre qualificate, solo 13 si erano presentate. L'India era stata squalificata perché si faceva un punto d'onore di giocare a piedi nudi. La Scozia non era venuta perché non sopportava l'idea di non essere testa di serie come l'Inghilterra. L'Inghilterra non aveva molta esperienza del gioco oltremanica, e si ritrovò sbigottita a perdere per uno a zero contro gli Stati Uniti d'America. L'Italia - detentrice del titolo, conquistato dodici anni prima in camicia nera - si era presentata stremata da un viaggio di tre settimane in transatlantico. Le altre squadre avevano preferito prendere l'aereo, ma la federazione italiano aveva appena perso gran parte dei titolari nel disastro di Superga, e non se la sentiva di rischiare. Il transatlantico si era rivelato un pessimo ambiente per un ritiro: tutti i palloni dopo qualche giorno erano finiti nell'oceano. Inseriti in un girone a tre con Svezia e Paraguay, perdemmo con la prima che pareggiò col secondo, e a quel punto eravamo già fuori: vincemmo comunque col Paraguay ed eravamo già pronti a re-imbarcarci.
A quel punto non restava che tifare Uruguay, una delle nazioni più italiane del mondo. Italiani erano i cognomi dei titolari più titolati: Ghiggia, Schiaffino. Entrambi avrebbero qualche anno più tardi indossato la maglia della nostra nazionale. Il capitano, Obdulio Varela, prima della partita invoca addirittura un santo italiano, Cono da Diano. Promette, in cambio della vittoria, di compiere un pellegrinaggio a piedi da Montevideo al santuario di San Cono a Florida, ridente cittadina dell'Uruguay. Ma perché proprio San Cono?

Cono Indelli nacque a Diano (in seguito conosciuta come Teggiano, provincia di Salerno) alla fine del dodicesimo secolo, e scappò appena poté in un monastero benedettino a Montesano della Marcellana. Lì visse una vita breve, santa e, per i nostri parametri, noiosissima, ravvivata da qualche saltuario evento miracoloso: come quella volta che vennero a trovarlo i genitori e lui dimostrò l'amore che riservava loro nascondendosi in un forno acceso. Quando se ne andarono ne saltò fuori incolume: miracolo! Pur di non dire ciao papà, ciao mamma.
Del resto il forno era il suo habitat, ci entrava dentro per cucinare; col tempo aveva magari sviluppato una certa resistenza. È anche vero che morì giovane: e che a un anno dal decesso ancora non avevano deciso dove seppellirlo. Ne reclamavano le spoglie ancora incorrotte sia Diano che Padula - quest'ultimo centro non so a che titolo - finché non si decise di tirare a sorte, abbandonandole a metà strada su un carretto legato a due buoi. I due buoi presero di buona lena la strada per Diano e si fermarono solo davanti alla chiesa del paese. Vince Diano, perde Padula (continua sul Post...)
Tutti figli di Bearzot
11-07-2012, 18:33calcio, miti, Ottanta, replichePermalink(È un pezzo di due anni fa, stasera ha un po' di senso).
A vederlo da qui, il Calcio italiano sembra avere avuto due incarnazioni, che per comodità possiamo chiamare “in bianco e nero” e “a colori”. Dunque il calcio in bianco e nero è un mondo di leggende, sacrifici, uomini di poche parole dal destino spesso tragico, magliette a strisce strette e senza scritte, riprese accelerate. Il calcio a colori è un mondo di stelle e stelline, scritte ovunque, indossatori di scarpe, spot di telefoni, risse in campo e sugli spalti, azioni al rallentatore. Al centro di questo grande cambio di paradigma, per un curioso accidente, c'è il Mundial del 1982, e la nazionale di Bearzot, coi suoi uomini che hanno un piede nel mondo antico e uno già in quello moderno, ma non appartengono davvero a nessuno dei due.
Aspettate, aspettate, non cliccate via. Non sono venuto qui a dirvi che il nostro mondiale è stato più bello del vostro; vorrei soltanto cercare di spiegare ai più giovani e ai più anziani che per noi, che eravamo al mondo da nemmeno dieci anni, fu qualcosa di diverso e irripetibile, né una saga in bianco e nero né una fiction a colori. Un romanzo, un incredibile romanzo, il primo vero romanzo che abbiamo visto consumarsi tra la tv e i giornali (quanti giornali! E che titoli! Me ne ricorderò sempre uno, che forse non era nemmeno in prima pagina, in un maiuscoletto che pugnalava il cuore: IL CAMERUN CI FA PAURA).
Vorrei spiegare che prima di tutti i grandi romanzi di formazione degli anni Ottanta, prima di Pat Morita che ti fa dare la cera e togliere la cera, prima di Rocky che spacca la legna, persino prima dei napoletani che sfidano a football gli yankees della base Nato e ovviamente si fanno massacrare, finché Bud “Bulldozer” Spencer non si rompe i coglioni ed entra in campo, prima che qualcuno dicesse “coniglio” a Michael J. Fox, insomma, prima di ogni cosa, ci fu quella nazionale pesante, che non riusciva a giocare contro la Polonia, non riusciva a battere il Perù; quella nazionale criticata da tutti che aveva paura del Camerun, quella nazionale passata al secondo turno per una pietosa differenza reti, quella nazionale che quando si ritrovò in un girone a tre con Brasile e Argentina fu data per spacciata dai nostri saggi padri.
Noi invece, non sapendo davvero nulla di calcio, che altro potevamo fare se non sperare, pregare, sognare che i potentissimi sudamericani si liquefacessero come nella Bibbia accade agli empi nemici di Israele. E così fu: il Dio della nostra infanzia ascoltò le querule preghiere dei suoi figli piccoli e quella nazionale, già vergogna delle italiche genti, si rialzò sferragliante come Mazinga prima che gli diano il colpo di grazia, e sconfisse l'Argentina di Maradona, trionfò sul Brasile di Zico e Falcao, passeggiò sulle spoglie della Germania di Muller e Rummenigge, e ci diede il primo vero lieto fine della nostra vita; non una semplice vittoria: una crescita, un riscatto. Lo avevamo sognato, ora il sogno era realtà. Ed era appropriato che i protagonisti di questa avventura avessero nomi bizzarri, da romanzo ungherese: Zoff, Bearzot (anche se poi chi segnava i gol portava cognomi più rassicuranti: Rossi, Tardelli).
L'allenatore, in particolare, fu immediatamente assunto nel nostro olimpo di nonni rassicuranti, con Pertini ed Enzo Ferrari (che per me a nove anni avevano davvero il volto intercambiabile): uomini saggi che tenevano dritto il timone, incuranti delle sconfitte passeggere, essi vegliavano sui nostri sonni e ovviavano ai disastri dei nostri genitori. Senza di loro, Gilles Villeneuve non sarebbe stato che un locale campione d'autoscontro. Erano loro ad aver pescato Paolo Rossi dal vortice del calcioscommesse; ad aver creduto in lui per quattro lunghe partite mentre si aggirava per l'area avversaria struggendosi nel tentativo di rammentarsi le regole del giuoco. E i nostri saggi padri lo fischiavano, maledicendo Bearzot e chi ce l'aveva mandato, e l'Argentina '78 era un'altra cosa, per tacer del Messico.
 Come poteva non scattare l'immedesimazione, come potevamo non sentirci tutt'uno con quel Paolo Rossi timido, incapace, distrutto dalle critiche, che a un certo punto si sblocca e piazza tre gol ai brasiliani? Era ovvio che prima o poi sarebbe successo anche a noi: ci saremmo sbloccati. Avremmo spiccato il volo e superato in elevazione tutte le difficoltà. Non è escluso che da qualche parte, nella nostra testa, ci crediamo ancora: ci sbloccheremo prima o poi, la faremo vedere a tutti. Forse sarebbe bastato trovare un saggio maestro, un nonno partigiano, un Bearzot che credesse in noi.
Come poteva non scattare l'immedesimazione, come potevamo non sentirci tutt'uno con quel Paolo Rossi timido, incapace, distrutto dalle critiche, che a un certo punto si sblocca e piazza tre gol ai brasiliani? Era ovvio che prima o poi sarebbe successo anche a noi: ci saremmo sbloccati. Avremmo spiccato il volo e superato in elevazione tutte le difficoltà. Non è escluso che da qualche parte, nella nostra testa, ci crediamo ancora: ci sbloccheremo prima o poi, la faremo vedere a tutti. Forse sarebbe bastato trovare un saggio maestro, un nonno partigiano, un Bearzot che credesse in noi.Non ci furono sequel al romanzo: chiusa la copertina Bearzot tornò immediatamente un comune mortale, il selezionatore di nazionali mediocri, che non si qualificarono agli Europei e uscirono agli ottavi in Messico. Ci furono altri mondiali, e anche se non abbiamo mai smesso di tifare per gli azzurri, da qualche parte nel nostro cuore c'era come una resistenza, l'idea che nessuna fiaba sarebbe mai stata bella come quella di Bearzot. Magari piangemmo persino nel '90, quando la cavalcata trionfale di Baggio e Schillaci si schiantò sulla più bituminosa Argentina mai vista: piangemmo, ma qualcosa dentro di noi diceva meglio così, ci sta bene, abbiamo voluto vincere tutte le partite e ci siamo dimenticati che non c'è vera gloria senza sofferenza.
Soffrimmo di più per l'Italia di Sacchi, che in partenza poteva sembrare ancora più arrogante di quella di quattro anni prima, ma poi fu messa in ginocchio da infortuni e squalifiche che la resero un'armata brancaleone, trascinata di peso da Baggio fino al malinconico finale. In seguito i calciatori diventarono sempre meno simpatici, eppure avevano un modo di mettersi nei guai che ti costringeva a credere in loro, a sperare nel riscatto, a cercare nel fondo del nostro cuore il Dio delle vittorie assurde che avevamo pregato nel 1982. Persino l'europeo di Grecia diventò interessante soltanto quando Totti si fece cacciare, e Cassano scese in campo e segnò, ma Svezia e Danimarca fecero melina e allora pianse: sì, Cassano pianse. Due anni dopo, in pieno scandalo Moggi, era di nuovo una questione di riscatto: i nostri gladiatori pompati e tatuati dovevano dimostrare di essere professionisti all'altezza, e forse ce la fecero, ma poi.
Poi, l'ho scritto, almeno in me qualcosa si è rotto – qualcosa, credo, tra la testata di Zidane e la scenetta odiosa di Totti con la coppa in mano. Non riesco più ad appassionarmi, mi sembro una donna che vede ventidue idioti a spasso per un prato e cambia canale. Non capisco - se mai l'ho capito - che senso abbia far giocare miliardi di budget contro milioni di debiti, non riesco più a trovare motivi d'interesse. Non posso nemmeno dire che rimpiango il calcio che fu: se riguardo al Mundial dell'82 con gli occhi di oggi, mi rendo conto che fu una bella impresa, sì, ma come tante altre, nulla di davvero eccezionale: non ci voleva un genio a capire che quel Brasile non sapeva difendersi, e Bearzot probabilmente non era un genio.
L'unica cosa che mi porto dentro, alla quale non voglio rinunciare, è il mio concetto di vittoria, che è quello dei film degli anni Ottanta dove Rocky deve sempre prima andare al tappeto, sanguinare, vedere doppio, spaccare la legna, mettere la cera, togliere la cera... per vincere domani. Il mio concetto di vittoria è che la vittoria in sé non m'interessa. Non voglio essere il più forte, non trovo nessuna gloria nel nascere Maradona. Non ci sarebbe gloria nemmeno nel battere il Brasile, se prima non hai avuto paura del Camerun. Per me l'unica vittoria che abbia senso è la vittoria di Paolo Rossi, che sbeffeggiato dal mondo intero spicca il volo, supera due ciclopi brasiliani in elevazione e la mette dentro. Perciò mi troverete sempre coi perdenti: non perché mi piaccia perdere, ma perché sto aspettando l'unica vittoria che mi farebbe godere realmente: la vittoria di Davide su Golia, di Bearzot sui mostri del calcio, di Pertini sui fascisti i nazisti e i democristiani. Voi tifate pure per la vostra squadra miliardaria: mica vi giudico, e mi fareste un piacere se non giudicaste me. Siamo semplicemente diversi, abbiamo avuto educazioni diverse, ci siamo letti romanzi diversi negli anni in cui leggere i romanzi ci serviva davvero. Adesso per capirsi forse è tardi, voi state da una parte, io dall'altra, e non m'importa quante palle mi mettete dentro: l'importante è la sola palla che un giorno metteremo noi. Ne basterà una sola, a un certo punto ci sbloccheremo, scenderà Bulldozer, il signore degli Eserciti, vi faremo un culo così, la palla schiacciata in meta scoppierà e non ne verranno fabbricate altre, non ci saranno rivincite, il mio romanzo finirà in quel momento.
"Non si celebra il nulla"
23-05-2012, 01:38calcio, campagna elettorale (permanente), internet, Pd, TwitterPermalinkQuesto non è un pezzo sulla politica. Non c'è nulla che valga la pena di scrivere in questi giorni che non sembrerà ridicolo tra un mese. Non è neanche un pezzo sul calcio. Forse è un pezzo sullo stile. Il problema con lo stile è che se non sai cos'è, non capisci nemmeno che ti manca. La maggior parte delle persone ne ha quel poco che basta per capire che gliene servirebbe di più. E poi c'è Adinolfi. Purtroppo questo è anche un pezzo su Mario Adinolfi.
Adinolfi sta su twitter. Ha anche un blog a dire il vero, cioè lo aveva sul Cannocchiale, poi lo ha chiuso, poi lo ha riaperto, non lo so, non è che sia così interessante in fin dei conti. Io lo seguo su twitter, e tanto mi basta. Sì, non è un grande indizio di stile da parte mia. Su twitter Adinolfi ha tutta una teoria su cosa bisogna fare e cosa no, tutto un catechismo che vi risparmio; lui sostanzialmente lo usa per esprimere le sue opinioni politiche, festeggiare quando vince a poker e tifare Juventus. Quest'ultima cosa lo rende più di altri un cinguettatore molesto, perché, non so se ci avete fatto caso, poche cose si sopportano meno nel flusso di twitter di uno che non commenta nemmeno la partita in modo tecnico, no, lo usa solo per fare i cori come in curva, ma d'altro canto Adinolfi è così. Tifa la Juventus, la quale squadra almeno di questo non ha colpe. La domenica che ha vinto il campionato magari vi siete chiesti chi sono stati gli sfigati che hanno fatto invasione di campo, ecco, Adinolfi c'era e si è fatto pure il video col telefonino e l'ha pure messo su internet, perché Adinolfi è uno che in internet ci crede, sa come usare internet per farsi compat... per attirare l'attenzione sul personaggio. Vabbe'.
campioni di sto kazzo..ma andate a lavorare,con tutti i problemi ke ci sono in italia pensate a ste minkiate,poi se ce da andare a manifestare x sto paese ke sta andando in rovina nessuno si muove..siete dei pecoroni di merda,ke italiani di merda e pure ciukki,bravi coglionazzi pensate al calcio ke sicuramente vi darà da mangiare...koglioniiiiiiiiiii.Ora io dirò una cosa di calcio, una sola. Non ho mai sopportato la Juventus. Quando sei bambino hai bisogno di una squadra che compensi la tua autostima, tanto meglio se è l'unica con due stelle sullo stemmino. Io probabilmente avevo un'autostima pazzesca, una sindrome da onnipotenza mai veramente rientrata, perché dopo attenta riflessione scelsi il Torino. Però voglio aggiungere un'altra cosa, un'ultima. Per quanto io possa avere odiato la Juventus bistellata dei miei tempi, il mio era un odio grondante di stima. Confusamente sapevo che non mi sarei mai potuto fare dei nemici migliori di Platini, di Zoff, di Boniperti, di Trapattoni. Era una squadra che aveva stile, non è solo un modo di dire. Anche quel modo di vincere ma non stravincere: per esempio il campionato mai due volte di fila, sarebbe stato inelegante. Il mio era un odio che si è incrinato in due momenti precisi, filtrando un dolore sincero: Juventus-Amburgo e Juventus-Liverpool. Ci soffro ancora a pensarci, che quella squadra non ha mai veramente vinto una Coppa come si deve. Se la meritava ma non è successo, e ciò me la rende un po' più Torino di quanto non sia Juventus. Quella Juventus non esiste più, anche questo non è un modo di dire. È cambiato tutto nel frattempo, stravincere è diventato un imperativo commerciale, però tutta la polemica sulla terza stella, ecco, al di là di tutto, è la morte dello stile. Uno sportivo che ha stile, se ritiene che gli sia stata fatta un'ingiustizia, se pensa che gli siano stati scippati due scudetti, alza le spalle e dice: va bene, siccome me li merito li rivincerò. Questo è lo sport, questo è lo stile, questo è l'unica labile connessione tra il guardar tirare calci a un pallone e il diventare uomini. Che era il fine per cui lo abbiamo inventato, lo sport moderno: diventare uomini. Non intrattenere bamboccioni quarantenni che si filmano l'invasione di campo, manco avessero vinto loro. (Sì, Adinolfi, non "avete vinto" voi tifosi: han vinto loro, voi al massimo avete pagato il biglietto, eh, ma questa cosa, se non ti è entrata a sedici, a quaranta è durissima)......!!!!!!!!!!!!! (D'altronde, se carichi un video su youtube che reazioni ti aspetti? No vabbe' ma sei tu l'internettologo).
Sabato sera c'è stata Juventus-Napoli, finale di Coppa Italia. Per i non esperti: è un trofeo nominalmente importante, ma sempre un po' snobbato dal pubblico. Per alcune squadre di livello medio è un palcoscenico fondamentale. Comunque stiamo parlando di un trofeo professionistico, ci si aspetta che tutti diano il meglio. Adinolfi, che su twitter aveva appena finito di esternare la sua opinione criminologica sulla bomba di Brindisi (Non è una bomba di mafia, questa è opera di un Brevnik all'italiana, trovatelo subito), si è messo subito a spiegare che la Coppa per lui era un "portaombrelli", non gli interessava, e vabbe'. Ha vinto il Napoli e Adinolfi ha commentato così:
E uno dice sì, un po' acidino, ma d'altronde è un tifoso, bisogna entrare nella semantica dei tifosi. Magari tra un po' cancella. E dopo un po':
Capisci che twitter è demoniaco? Perché son tutte opinioni non richieste, cioè Adinolfi, fermati, che rosicata indegna, che piccola grande figura di merda stai facendo, e perché? Sei un personaggio pubblico, ti sei anche candidato, e questi sono quei momenti in cui uno ti legge e pensa: fortuna che non t'abbiamo eletto. E non ha niente a che vedere con le tue idee o le tue appartenenze, ha unicamente a vedere con lo stile, però non credo di potertelo spiegare se non sai cos'è. C'è una differenza, ci dovrebbe essere, tra il "tifare" una squadra e regredire a uno stadio infantile di sfottò e pappapero. La famosa questione generazionale. Il guardare all'estero, dove i trenta-quarantenni si fanno sotto nel mondo della politica: vatti a vedere se un trentenne di belle speranze inglese si mette a commentare una partita così sui twitter. Io scommetto di no. Il "tifo", nei Paesi sportivi, implica un rispetto per gli avversari, per la competizione, per la bellezza del gioco, che tu in questi piccoli momenti mostri di non sapere neanche dove sta di casa, e spero violentemente che tu non sia rappresentativo di una tifoseria o di una società. Comunque magari era solo lo sfogo di un momento e dopo un po' gli è passata.
 |
| Non gli è passata. |
Certo, c'è il particolare trascurabile che Adinolfi era in una lista del PD, partito di cui ha stracciato la tessera un anno fa, con un intervento molto polemico nei confronti della segreteria Bersani. Al tempo noi pochi adinolfologi (razza strana) ci domandavamo in cosa consistesse abbandonare il PD, dal momento che Adinolfi non aveva nessun ruolo a nessun livello: di solito i divorzi comportano qualche rinuncia, ma non era chiaro a cosa stesse rinunciando il nostro. Per esempio, a un eventuale seggio in parlamento qualora se ne presentasse l'eventualità? No, pare di no, adesso che si è liberato un posto Adinolfi si è sbrigato ad annunciare che entrerà nel gruppo del PD, "da indipendente": che bella espressione anni Ottanta, mi fa tornare in mente Zbigniew Boniek. Un altro stile, comunque.
Questo non era un pezzo di politica. Era un pezzo sullo stile. Per esempio. Cosa c'è di peggio di sputare nel piatto in cui si mangia? Ci può essere qualcosa di peggio? Sì, qualcosa c'è: riprendere il piatto dopo un po' e rimettersi a mangiare come se nulla fosse. Da indipendente. D'altro canto, che senso ha parlarne. Chi legge fin qui, o condivide il mio parere su Adinolfi (e allora è inutile continuare) o è Adinolfi. Nel qual caso non credo che possa capire cosa intendo per "stile". Probabilmente pensa che lo stia prendendo in giro perché è sovrappeso. No, Adinolfi, giuro, il girovita non c'entra niente.
Heautontimorumenopolis
03-09-2011, 00:59calcio, scioperiPermalinkÈ sempre dura ripartire a settembre; però ti consola il pensiero che stavolta sarà diverso; che stavolta, con l'agosto che c'è stato, saranno tutti incazzati no? insomma hai visto cosa ha fatto il governo? E cosa non ha fatto? Cioè è palese, evidente, lapalissiano, non si sta neanche a discutere, stavolta si va davvero alle barricate, e poi
poi suona la sveglia e ti versi un primo caffè, arrivi a scuola in scioltezza e dal parcheggio cominci a sentire le voci, dalle finestre, voci di colleghe che si lamentano (ci hanno tagliato le classi, i bidelli, i metricubi, gli armadietti), si lamentano, senti come si lamentano; ma poi
poi ti scorre l'occhio sul foglio delle adesioni allo sciopero, ed è pieno di "no", e se tu sei ancora così addormentato da reagire, "Ma come no scusate, ma vi rendete conto?" loro ti rispondono che gli scioperi ormai li fanno solo quei capitalisti dei calciatori che non vogliono pagareilcontributodisolidarietà, fine.
E allora ti svegli, e ti ricordi che sei in Italia, e chiedi sommessamente scusa a Tremonti e Berlusconi e Bossi e compagnia, sì, dimenticavo, voi state solo eseguendo gli ordini. Mi ero un attimo dimenticato di chi vi ha messo lì. Maledetta memoria corta, maledette vacanze lunghe.
(Sullo sciopero dei calciatori cfr. Costa).
Ovunque (è piazzale Loreto)
08-06-2011, 19:55Berlusconi, calcio, fascismo, memoria del 900PermalinkAnche perché il fascismo, quel fascismo ruspante che ti abbiamo sempre perdonato finché ci paravi i rigori, Capitano, non è che può trasformarsi in un'enciclopedia buona a tutti gli usi, come accade a quelli che a furia di lamentarsi che a scuola non si insegnano le foibe, e le stragi del triangolo rosso, e a pretendere nei programmi di tutte le scuole le foibe (e il triangolo rosso), dopo un po' l'unica cosa che sanno dirti di tutto il Novecento è che ci sono state delle foibe e un triangolo (rosso). Non dico che non siano storie importanti, ma impariamone altre. Perché non è vero che tutto intorno a noi ci parla di Mussolini. Siamo noi che abbiamo questa fissa per Mussolini e lo vediamo in qualsiasi uomo di potere, da quando Forattini infilava Craxi nello stivale e anche prima.
Altrimenti continuiamo la solita recita: il calciatore fascistone che tira fuori Piazzale Loreto, il blog sinistroide che risponde Ma-gari, sarebbe ora di appendere tutti i disonesti e intrallazzoni eccetera eccetera. Come se fosse una fune che ognuno può tirare dalla sua parte, Piazzale Loreto, mentre invece è un simbolo che dovrebbe unirci, fascisti e antifascisti, nella vergogna. Se ne abbiamo studiato quel poco per sapere che non ci fu nessuna gloria nello sparacchiare e sputacchiare sui cadaveri; che Pertini se ne andò disgustato, che il CLN deplorò immediatamente e unanimemente la "macelleria messicana", e che a tutt'oggi non si è ancora capito chi abbia dato l'ordine di portare lì le salme e appenderle alla tettoia della pompa di benzina. Nulla di cui andare fieri, davvero: Mussolini avrebbe potuto morire da combattente, e si fece catturare travestito mentre fuggiva; quanto agli italiani, Capitano, non ha tutti i torti: hanno questo vizio di tenersi tutta la saliva per quando i potenti cadono in disgrazia. Lei poi stava semplicemente pensando a quella banda un po' sgangherata di calciatori pizzicati a truccare le partite, ma forse nelle ossa ammaccate ha sentito lo Zeitgeist: c'è un'aria strana in questi giorni, a Roma hanno perfino messo in scena una farsa di Gran Consiglio. Poi magari non succederà nulla, come non è successo nulla tante altre volte, ma a Piazzale Loreto in questi giorni ci stanno pensando in tanti: più per mancanza di fantasia che per reale attinenza.
Tanto che io, solito bastianino, sento qui di dover lasciare un piccolo voto: il giorno che Silvio sarà caduto - ma caduto sul serio - domani o tra vent'anni, prometto che non sprecherò una sola cattiva parola, un solo sputo per lui; e ne rispetterò la salma. Magari dagli anni Quaranta si può uscire anche così.
I figli di Bearzot
23-12-2010, 01:18calcio, coccodrilli, mondiali, OttantaPermalinkA vederlo da qui, il Calcio italiano sembra avere avuto due incarnazioni, che per comodità possiamo chiamare “in bianco e nero” e “a colori”. Dunque il calcio in bianco e nero è un mondo di leggende, sacrifici, uomini di poche parole dal destino spesso tragico, magliette a strisce strette e senza scritte, riprese accelerate. Il calcio a colori è un mondo di stelle e stelline, scritte ovunque, indossatori di scarpe, spot di telefoni, risse in campo e sugli spalti, azioni al rallentatore. Al centro di questo grande cambio di paradigma, per un curioso accidente, c'è il Mundial del 1982, e la nazionale di Bearzot, coi suoi uomini che hanno un piede nel mondo antico e uno già in quello moderno, ma non appartengono davvero a nessuno dei due.
Aspettate, aspettate, non cliccate via. Non sono venuto qui a dirvi che il nostro mondiale è stato più bello del vostro; vorrei soltanto cercare di spiegare ai più giovani e ai più anziani che per noi, che eravamo al mondo da nemmeno dieci anni, fu qualcosa di diverso e irripetibile, né una saga in bianco e nero né una fiction a colori. Un romanzo, un incredibile romanzo, il primo vero romanzo che abbiamo visto consumarsi tra la tv e i giornali (quanti giornali! E che titoli! Me ne ricorderò sempre uno, che forse non era nemmeno in prima pagina, in un maiuscoletto che pugnalava il cuore: IL CAMERUN CI FA PAURA).
Vorrei spiegare che prima di tutti i grandi romanzi di formazione degli anni Ottanta, prima di Pat Morita che ti fa dare la cera e togliere la cera, prima di Rocky che spacca la legna, persino prima dei napoletani che sfidano a football gli yankees della base Nato e ovviamente si fanno massacrare, finché Bud “Bulldozer” Spencer non si rompe i coglioni ed entra in campo, prima che qualcuno dicesse “coniglio” a Michael J. Fox, insomma, prima di ogni cosa, ci fu quella nazionale pesante, che non riusciva a giocare contro la Polonia, non riusciva a battere il Perù; quella nazionale criticata da tutti che aveva paura del Camerun, quella nazionale passata al secondo turno per una pietosa differenza reti, quella nazionale che quando si ritrovò in un girone a tre con Brasile e Argentina fu data per spacciata dai nostri saggi padri.
Noi invece, non sapendo davvero nulla di calcio, che altro potevamo fare se non sperare, pregare, sognare che i potentissimi sudamericani si liquefacessero come nella Bibbia accade agli empi nemici di Israele. E così fu: il Dio della nostra infanzia ascoltò le querule preghiere dei suoi figli piccoli e quella nazionale, già vergogna delle italiche genti, si rialzò sferragliante come Mazinga prima che gli diano il colpo di grazia, e sconfisse l'Argentina di Maradona, trionfò sul Brasile di Zico e Falcao, passeggiò sulle spoglie della Germania di Muller e Rummenigge, e ci diede il primo vero lieto fine della nostra vita; non una semplice vittoria: una crescita, un riscatto. Lo avevamo sognato, ora il sogno era realtà. Ed era appropriato che i protagonisti di questa avventura avessero nomi bizzarri, da romanzo ungherese: Zoff, Bearzot (anche se poi chi segnava i gol portava cognomi più rassicuranti: Rossi, Tardelli).
L'allenatore, in particolare, fu immediatamente assunto nel nostro olimpo di nonni rassicuranti, con Pertini ed Enzo Ferrari (che per me a nove anni avevano davvero il volto intercambiabile): uomini saggi che tenevano dritto il timone, incuranti delle sconfitte passeggere, essi vegliavano sui nostri sonni e ovviavano ai disastri dei nostri genitori. Senza di loro, Gilles Villeneuve non sarebbe stato che un locale campione d'autoscontro. Erano loro ad aver pescato Paolo Rossi dal vortice del calcioscommesse; ad aver creduto in lui per quattro lunghe partite mentre si aggirava per l'area avversaria struggendosi nel tentativo di rammentarsi le regole del giuoco. E i nostri saggi padri lo fischiavano, maledicendo Bearzot e chi ce l'aveva mandato, e l'Argentina '78 era un'altra cosa, per tacer del Messico.
 Come poteva non scattare l'immedesimazione, come potevamo non sentirci tutt'uno con quel Paolo Rossi timido, incapace, distrutto dalle critiche, che a un certo punto si sblocca e piazza tre gol ai brasiliani? Era ovvio che prima o poi sarebbe successo anche a noi: ci saremmo sbloccati. Avremmo spiccato il volo e superato in elevazione tutte le difficoltà. Non è escluso che da qualche parte, nella nostra testa, ci crediamo ancora: ci sbloccheremo prima o poi, la faremo vedere a tutti. Forse sarebbe bastato trovare un saggio maestro, un nonno partigiano, un Bearzot che credesse in noi.
Come poteva non scattare l'immedesimazione, come potevamo non sentirci tutt'uno con quel Paolo Rossi timido, incapace, distrutto dalle critiche, che a un certo punto si sblocca e piazza tre gol ai brasiliani? Era ovvio che prima o poi sarebbe successo anche a noi: ci saremmo sbloccati. Avremmo spiccato il volo e superato in elevazione tutte le difficoltà. Non è escluso che da qualche parte, nella nostra testa, ci crediamo ancora: ci sbloccheremo prima o poi, la faremo vedere a tutti. Forse sarebbe bastato trovare un saggio maestro, un nonno partigiano, un Bearzot che credesse in noi.Non ci furono sequel al romanzo: chiusa la copertina Bearzot tornò immediatamente un comune mortale, il selezionatore di nazionali mediocri, che non si qualificarono agli Europei e uscirono agli ottavi in Messico. Ci furono altri mondiali, e anche se non abbiamo mai smesso di tifare per gli azzurri, da qualche parte nel nostro cuore c'era come una resistenza, l'idea che nessuna fiaba sarebbe mai stata bella come quella di Bearzot. Magari piangemmo persino nel '90, quando la cavalcata trionfale di Baggio e Schillaci si schiantò sulla più bituminosa Argentina mai vista: piangemmo, ma qualcosa dentro di noi diceva meglio così, ci sta bene, abbiamo voluto vincere tutte le partite e ci siamo dimenticati che non c'è vera gloria senza sofferenza.
Soffrimmo di più per l'Italia di Sacchi, che in partenza poteva sembrare ancora più arrogante di quella di quattro anni prima, ma poi fu messa in ginocchio da infortuni e squalifiche che la resero un'armata brancaleone, trascinata di peso da Baggio fino al malinconico finale. In seguito i calciatori diventarono sempre meno simpatici, eppure avevano un modo di mettersi nei guai che ti costringeva a credere in loro, a sperare nel riscatto, a cercare nel fondo del nostro cuore il Dio delle vittorie assurde che avevamo pregato nel 1982. Persino l'europeo di Grecia diventò interessante soltanto quando Totti si fece cacciare, e Cassano scese in campo e segnò, ma Svezia e Danimarca fecero melina e allora pianse: sì, Cassano pianse. Due anni dopo, in pieno scandalo Moggi, era di nuovo una questione di riscatto: i nostri gladiatori pompati e tatuati dovevano dimostrare di essere professionisti all'altezza, e forse ce la fecero, ma poi.
Poi, l'ho scritto, almeno in me qualcosa si è rotto – qualcosa, credo, tra la testata di Zidane e la scenetta odiosa di Totti con la coppa in mano. Non riesco più ad appassionarmi, mi sembro una donna che vede ventidue idioti a spasso per un prato e cambia canale. Non capisco - se mai l'ho capito - che senso abbia far giocare miliardi di budget contro milioni di debiti, non riesco più a trovare motivi d'interesse. Non posso nemmeno dire che rimpiango il calcio che fu: se riguardo al Mundial dell'82 con gli occhi di oggi, mi rendo conto che fu una bella impresa, sì, ma come tante altre, nulla di davvero eccezionale: non ci voleva un genio a capire che quel Brasile non sapeva difendersi, e Bearzot probabilmente non era un genio.
L'unica cosa che mi porto dentro, alla quale non voglio rinunciare, è il mio concetto di vittoria, che è quello dei film degli anni Ottanta dove Rocky deve sempre prima andare al tappeto, sanguinare, vedere doppio, spaccare la legna, mettere la cera, togliere la cera... per vincere domani. Il mio concetto di vittoria è che la vittoria in sé non m'interessa. Non voglio essere il più forte, non trovo nessuna gloria nel nascere Maradona. Non ci sarebbe gloria nemmeno nel battere il Brasile, se prima non hai avuto paura del Camerun. Per me l'unica vittoria che abbia senso è la vittoria di Paolo Rossi, che sbeffeggiato dal mondo intero spicca il volo, supera due ciclopi brasiliani in elevazione e la mette dentro. Perciò mi troverete sempre coi perdenti: non perché mi piaccia perdere, ma perché sto aspettando l'unica vittoria che mi farebbe godere realmente: la vittoria di Davide su Golia, di Bearzot sui mostri del calcio, di Pertini sui fascisti i nazisti e i democristiani. Voi tifate pure per la vostra squadra miliardaria: mica vi giudico, e mi fareste un piacere se non giudicaste me. Siamo semplicemente diversi, abbiamo avuto educazioni diverse, ci siamo letti romanzi diversi negli anni in cui leggere i romanzi ci serviva davvero. Adesso per capirsi forse è tardi, voi state da una parte, io dall'altra, e non m'importa quante palle mi mettete dentro: l'importante è la sola palla che un giorno metteremo noi. Ne basterà una sola, a un certo punto ci sbloccheremo, scenderà Bulldozer, il signore degli Eserciti, vi faremo un culo così, la palla schiacciata in meta scoppierà e non ne verranno fabbricate altre, non ci saranno rivincite, il mio romanzo finirà in quel momento.
Get ready, 'cause here I come
04-08-2010, 00:01calcio, concerti, jukebox '10, musica, YalePermalinkIo dunque quattro anni fa mi trovavo a New Haven, Connecticut, travestito da studente. Non un granché come copertura, ma facevo del mio meglio per tenere la mia italianità sotto i livelli di guardia, e se provai a prepararmi un ragù con carne macinata agli estrogeni, ciò rimase confinato nel mio cucinino di woodland street, ingombrato da un frigorifero enorme che sparava aria fredda sui piedi.
Poi un giorno, stavo attraversando il grande prato centrale - su un lato stavano già montando il palco per i Temptations, ci sarebbe stato di lì a poco un concerto gratis dei Temptations! - lo stavo attraversando in linea retta, quando mi ritrovai in mezzo a una partita di calcetto. A New Haven, tanto tanto lontano dalla casetta mia. Mi fermai a guardarli, perché insomma, uno non sa cosa aspettarsi da americani che giocano a calcetto, chissà se sanno toccare palla (e invece magari al college hanno fatto un seminario sul dribbling). E una ragazza in tuta che si era accorta che mi ero fermato, mi disse: wanna play? Qualcosa del genere.
Una voce nella mia testa mi diceva vacci piano, è tipo dieci anni che non tocchi palla neanche tu. E gli americani saranno anche scarsi a soccer, ma le americane hanno vinto già due coppe del mondo. Ma era solo un bisbiglio nella mia testa. Il resto della mia testa stava gridando all'unisono po, po po po po po, po. Io sono il campione del mondo. Io sono venuto tra voi nordamericani ignoranti a insegnarvi il bel giuoco. Aspettate solo un attimo che poso lo zainetto.
Quand'ero piccolo mi ritenevo in grado di giocare nel cortile della scuola, prima della campana. Siccome nessuno mi aveva mai invitato, la mia unica possibilità era lottare su tutti i palloni, tutti. Non avevo un attaccante da marcare io, io marcavo il pallone. L'unica cosa che so fare.
Il problema è che non ero uno più uno studente: quella era solo una copertura: avevo la maglietta, il laptop nello zainetto, i calzoncini, ma a guardarmi bene si vedevano i capelli bianchi, e il fiato era quello di un trentaqualcosenne, sicché dopo quattro epici minuti di gioco, io morii. Più o meno. Ebbi giusto il fiato di salutare e ringraziare, cedetti il mio posto a un nigeriano (cominciava a formarsi una fila), e mi accasciai, me lo ricordo benissimo, praticamente sotto il pennone della bandiera, pensando guarda te se mi tocca morire sotto le stelle e le strisce. Passò un aeroplano, mi sembrò che andasse a est. Ciao aeroplano, gli dissi, salutami la mamma europa, io mi sa che resto qui. Sul green di New Haven. Per aver voluto giocare a pallone, alla mia veneranda età.
Due sere dopo, sullo stesso green, arrivarono i Temptations. Un quartetto di simpatici signori dell'età di mio padre. Mi aspettavo una cosa piuttosto malinconica. Ma la malinconia non sanno neanche cos'è, i Temptations. Ballarono per tre ore, in perfetta sincronia. Mentre ballavano cantavano, non sbagliarono niente. Sudavano e cantavano, tra un pezzo e l'altro intrattenevano. Professionali, carismatici, energetici, quattro atleti di sessant'anni. Io ne avevo la metà, e su quel prato ero morto dopo aver inseguito per tre minuti un pallone.
Su Youtube i video recenti dei Temptations non rendono loro onore. Sembrano davvero una congrega di vecchietti, garantisco che quella sera non furono così. I Temptations. Che rocce. Su gente così non cresce il muschio.
un destino minuscolo
15-06-2010, 01:04calcio, contro la lingua italiana, scuolaPermalinkUno sarebbe anche tentato di dire vabbè, chissenefrega, ho una vita sola, arrangiatevi. Probabilmente a questa conclusione sono arrivate per prime le mie colleghe delle elementari, perché le ultime infornate di bambini che ci hanno consegnato non hanno proprio più la minima idea.
Molti hanno tagliato il nodo gordiano: scrivono tutto in stampatello e amen. Tu spieghi che lo stampatello è scomodo, che conoscere due grafie è meglio che saperne scrivere una sola, che è il momento di acquisire più manualità, di sperimentare la comodità, la fluidità del corsivo. Loro restano scettici. Tu li ammazzi con due ore di dettato. Lo scetticismo diminuisce. Ma rimane sempre il problema che non sanno dove mettere le maiuscole. Tu glielo spieghi. Loro ti guardano strano. Cos'è questo punto fermo che ci obbliga a mettere una maiuscola, talvolta persino ad andare a capo, ma chi si crede di essere? Ma poi in generale cos'è questa storia degli obblighi, delle regole, posso uscire? Voglio parlarne col preside. Posso mandargli mio padre? Mio padre si firma tutto minuscolo e non gli è mai successo niente.
Tu glielo spieghi. Tutti i santi giorni, tu gli ripeti i motivi per cui le maiuscole servono. Ci aiutano a orientarci sulla pagina. A distinguere il nome comune dal nome proprio. A dare importanza alle cose che se lo meritano. Il mondo è così vasto e così ricco di cose interessanti da studiare, ma non c'è mai abbastanza tempo perché ogni santo giorno bisogna ribadire il concetto che non vi potete firmare con le lettere minuscole, piccoli deficienti. Comunque è il mio mestiere, eh, mi pagano, per cui insisto. Ogni giorno.
Tempo buttato via. Soldi sprecati.
Je Maintiendrai
16-06-2008, 11:42calcio, fratelli d'I.Permalink La lealtà degli altri
La lealtà degli altriOra io non è che voglia sempre dare addosso alla nazionale per partito preso, ma questa manfrina della lealtà, questa storia per cui l'Olanda adesso contro la Romania dovrebbe giocare “lealmente” (cioè vincere o pareggiare una partita che non ha nessun bisogno di vincere o pareggiare) la trovo insostenibile: degradante per chi ne parla e per chi ascolta.
Il calcio non è così. È uno dei pochi sport dove si può pareggiare a oltanza (anzi il pareggio sembra quasi il destino del match). Per questo esistono classifiche avulse e differenze reti; e se non vi piacciono, datevi al volley. Per questo esistono (dalla notte dei tempi) gironi a quattro invece che eliminatorie frattali come a Wimbledon. Per questo esistono strategie per qualificarsi al turno successivo senza bruciare tutte le energie. Niente a che vedere con la lealtà.
La lealtà è un'altra cosa. Si misura dai falli dati, e dal fair play. Ma quando in un girone di quattro squadre tu, Olanda, sei già matematicamente prima con una giornata di anticipo, non c'è nessun motivo razionale perché non ti rilassi: quella partitella di allenamento con dentro tutte le riserve te la sei conquistata sul campo (strapazzando campioni del mondo e vice, scusate se è poco). Ora starai già pensando a prepararti per passare ai quarti, e magari in semifinale: perché dovresti affaticarti con la Romania? Non te lo chiede il regolamento, non te lo chiede un malinteso concetto di “lealtà”, non te lo chiede nessuno a parte i dirigenti di una squadra avversaria che hai già sonoramente battuto sul campo. E che a star zitti farebbero una figura migliore.
Sta tranquilla che l'Italia, al tuo posto, farebbbe esattamente la stessa cosa: la “lealtà” è un concetto strano che tira fuori soltanto quando non riesce a infilare la palla in rete. Come quattro anni fa, ai tempi di Svezia e Danimarca: due squadre da cui ci aspettavamo la stessa malintesa “lealtà” semplicemente perché non eravamo riusciti a batterle . Il bello di avere un lungo archivio:
Noi siamo cialtroni e cattolici, e fieri d'esserlo, ma abbiamo bisogno che da qualche parte in Europa o nel mondo ci siano dei protestanti che abbiano lealtà e giudizio anche per noi. In loro abbiamo più fiducia nei che in noi stessi. Loro non fingono (noi fingiamo). Loro non rubano (noi rubiamo). Loro, se sono nostri alleati, è solo per il nostro bene. Loro, se vengono a liberarci, è per un calcolo disinteressato, per pura bontà. Insomma, loro sono migliori di noi, ma quel tipo di migliore di cui non si nutre invidia, perché ti lascia libero di goderti i tuoi difetti. Quel primo della classe generoso che ti fa copiare i compiti. È sempre alto e biondo, ma ogni tanto cambia lingua. Da sessant'anni in qua parla soprattutto inglese: prima parlava tedesco: è sempre un amicone che ci onora della sua amicizia, ci fa copiare tutto e non ci chiede nulla in cambio.
È una bella invenzione, questo amico biondo. Eppure, basterebbe ragionarci un po'. Tornare ai fondamentali. Cos'è l'etica protestante? Non è, prima di tutto, un'etica del lavoro? Noi li volevamo leali, loro sono stati professionali. C'è una bella differenza.
E cos'è la professionalità? È la capacità di far fronte ai propri impegni con costanza, massimizzando profitti ed eliminando gli sprechi.
…mentre nello stesso tempo, da un'altra parte del mondo, c'è un popolo di sognatori che ancora ragiona in termini di lealtà, e attende la sua Vittoria, che le porga la chioma. Aspetta, aspetta e spera.
Po Po Po Po Po
11-06-2008, 10:05calcio, dialoghi, fratelli d'I., migrantiPermalink Gelosia
Gelosia“Sarai contento, eh, che abbiamo fatto una figura di merda”.
Ma tu come fai a saperlo, scusa.
“Perché credi che io non li capisco, i tipi come te? Credi che non ti vedo?”
In effetti cosa vuoi vedere, con quella montatura da deficiente? Davanti agli occhi hai più tartaruga che lenti.
“Credi che non lo so, che tu tifi per i Rifiuti, tifi per il Crack in Borsa, per il Caropetrolio, per il malore di Silvio, hai tifato per l'Olanda e domani persino Romania?”
Beh, sono simpatici, con quei nomi da vampiri.
“Credi che non lo so, che ti sto sul cazzo?”
Ma non farmi una scenata qui per questo, dai.
“Credi che non ci arrivo?”
Va bene, sì, hai visto giusto, mi stai sul cazzo.
“Aha!”
Ma scusa, non dovrei? Solo tu hai il diritto di odiare gli zingari e i lavavetri? Perché non dovrei odiare te per come ti vesti, per quello che sei? Sei meno qualificato di me e guadagni il doppio, la mia macchina potrebbe stare nel baule della tua, non l'hai comprata così grande apposta per starmi sul cazzo? E non dovrei godere, adesso, a ogni rincaro? Tu mi credi in possesso di chissà quale sensibilità raffinata ma non è così, io odio esattamente come odi tu, e se tu ne hai il diritto perché io no?
“È proprio qui, è proprio qui che ti volevo! Tu sei come me!”
In un certo senso sì, in un altro no, e adesso ti saluto.
“Aspetta, non ho finito. E poi sei un razzista, esattamente come me”.
Un razzista?
“Sì! Perché non importano gli occhiali, non importa la macchina, non importa niente. Io ti sto sul cazzo perché mi chiamo Mario e sono italiano. Dillo che è così”.
Ma no, non è così.
“Ah, non è così?”
No.
“E allora immaginami soltanto un po' più scuro, stessi occhiali e macchina, però mi chiamo Omar. Di colpo ti sto simpatico. Di' di no”.
...
“Aaaah, non riesci a dir di no! Lo vedi? Il contrario di un razzista è un razzista tale e quale!”
Dunque. Vediamo. Intanto, io sono una persona razionale, e non c'è nessun motivo per cui un Omar che lavora quanto te debba vivere peggio di te.
“Ma non c'è neanche nessun motivo per cui tu debba volergli bene, mentre io ti sto sul cazzo a priori! Ammetti che è così!”
Forse ho capito. Questa è una scenata di gelosia. L'Italiano Medio si è incarnato, è sceso al bar e mi sta facendo una crisi di gelosia. Perché voglio bene a Omar, e a lui no.
“E a Mariescu, e a Mariovich, e a Ma-Ru che l'anno scorso ancora stava sugli alberi, ma a me no! A me no! Scusa, eh, se ti ho ospitato e riverito per tutti questi anni...”
Mi hai trattato da coglione, per tutti questi anni. Quelli ancora no. Probabilmente lo faranno, appena annuseranno di che pasta sono, ma per ora gli do una possibilità.
“E questa sarebbe la tua spiegazione?”
Spiegazione razionale.
“No, non è razionale un bel niente. Io ti dico che c'è del morboso, nel tuo trescare col terzo mondo. Come quello scrittore, quello là come si chiama, che si faceva le vacanze in Africa”.
Sai benissimo come si chiama, lo vedi come sei? Ti riduci ad affettare un'ignoranza che non hai. E comunque quello che smignotta nei Caraibi sei tu. Io non me lo trombo, il Terzo Mondo, io ci lavoro.
“Tu dai voti migliori agli stranieri”.
Li incoraggio. Ne hanno bisogno.
“Anche mio figlio ne ha bisogno”.
Tuo figlio ha bisogno di ceffoni.
“Lo vedi! Due pesi due misure”.
Impacchetta tuo figlio e spediscilo nel Punjab, vediamo quanto ci mette a imparare l'Urdu.
“Ma c'è un motivo, lo vuoi capire che c'è un motivo storico per cui io non devo impacchettare mio figlio e Omar sì? Se siamo tutti uguali, perché Omar è dovuto venire a rompere me? Si vede che lui di me aveva bisogno. E allora deve comportarsi bene!”
Anche tu hai bisogno di lui, e lo sai.
“Ma ce ne sono tanti come lui, e io posso scegliere! Ne ho il diritto! Perché la mia nazione è più ricca e se Omar non si comporta bene, a casa! C'è la fila! E questa non è arroganza, queste sono le cose come stanno, va bene? E ti dirò di più”.
Sentiamo.
“Che io posso essere uno stronzo, può darsi, un arrogante, è possibile, e può darsi che non abbia gusto in fatto di occhiali o di magliette, ma Omar non è meglio di me. In nulla è meglio di me. Sotto quella crosticina di terzo mondo è uno stronzo tale e quale me. Se l'Urdu fosse una grande nazione e l'Italia una piccola, lui tratterebbe me come io tratto lui. Tale e quale”.
E in quel caso io vorrei più bene a te.
“Ma tu queste cose devi capirle. Perché altrimenti, con tutti i libri che ti leggi, non riuscirai a capirla mai la gente”.
La gente. È una vita che mi dite che non capisco la gente. Tutti a farmi lezioni sulla gente. Inchiodano all'incrocio, mi fanno la lezione, ripartono sgommando. Gente che due anni fa si è presa il macchinone a benzina con gli incentivi, oggettivamente dei pazzi. Bastavano tre righe di giornale per sapere che il petrolio sarebbe andato su su su, però non è che puoi chiamarli tutti minchioni, perché anche se non sono esperti del prezzo degli idrocarburi, sono tutti esperti di gente, massimo rispetto. Ma vi volete anche mettere un po' nei panni miei? È una mezza vita che prendo lezioni di gente, e ancora non basta. Ancora non vi capisco, ancora non vi amo. Poi un bel giorno arriva Omar, anzi suo figlio. Magari ha appena finito di prendere a sberle il vostro. Però poi si fa avanti quatto con un foglio in mano e chiede: professore, per favore, che c'è scritto. È una lettera che gli è arrivata a casa. Lui capisce solo che vogliono dei soldi. Stai tranquillo, gli dico, è un rimborso del ticket. Hai fatto un esame, tre anni fa, ma hai pagato più del dovuto, devi andare in posta e te ne danno indietro. E lui mi dice grazie. E io per la prima volta in molti anni mi sento utile, ci voleva molto? Utile. Mi sento come doveva sentirsi un maestro nel suo paesino a metà Ottocento, una persona che si rispetta perché sa leggere e scrivere, e quindi è utile. Non ce la fate proprio a capire che il problema è tutto qui? Con tutte le vostre lezioni di vita non lo avete mai capito, che io volevo solo sentirmi utile.
“E io volevo solo sentirmi amato”.
Io non ti amo. Sei uno stronzo. Forza Romania.
“E tu sei un povero professorino inutile. Po po po po”.
si prenda le sue irresponsabilità
13-11-2007, 10:08calcio, cattiva politica, Giuliano AmatoPermalink Ministro Amato, oggi è martedì, e lei non ha ancora presentato le sue dimissioni. Mi sembra un fatto abbastanza grave, che potrebbe avere ripercussioni sulla sicurezza di noi tutti. Proprio quella sicurezza che come ministro lei dovrebbe avere a cuore.
Ministro Amato, oggi è martedì, e lei non ha ancora presentato le sue dimissioni. Mi sembra un fatto abbastanza grave, che potrebbe avere ripercussioni sulla sicurezza di noi tutti. Proprio quella sicurezza che come ministro lei dovrebbe avere a cuore. Non le dirò “si prenda le sue responsabilità”: è una frase fatta, e peraltro non è vera. Lei non è responsabile di un colpo partito lungo l’Autostrada del sole. Né della devastazione e del saccheggio, o come lo chiamano adesso, “terrorismo”: come se devastazione e saccheggio non fossero già cause sufficienti per un bel po’ d’anni di galera. Il punto è proprio questo: lei non è responsabile. E siccome non lo è, siccome non è stato capace di esserlo, dovrebbe farsi da parte, e lasciare il suo posto a qualcuno che certe responsabilità è in grado di assumerle. È un mestiere difficile, ma la paga è buona.
Altri mestieri, ben più rischiosi, non sono altrettanto ben remunerati. Il poliziotto che, sfortunato o incosciente, ha lasciato partire un colpo perpendicolare ai sensi di marcia dell’A1, verrà processato, e probabilmente perderà il suo lavoro. È abbastanza ingiusto che nel frattempo lei resti dov’è, senza pagare nemmeno un poco la sua imperizia e la sua irresponsabilità.
Da bambini c’insegnavano a non fare come lo struzzo, che nell’emergenza nasconde la testa sotto la sabbia. Oggi sappiamo che era tutta una montatura delle maestre, gli struzzi non fanno così. Dev’essere proprio lei, Ministro Amato, a tener viva la tradizione? Per una mezza domenica, mentre la furia montava, la Polizia e il Ministero degli Interni hanno mantenuto la versione del “colpo sparato in aria”: un’offesa all’intelligenza di tutti. Persino a quella degli ultras.
Ministro Amato, io non giustifico la violenza degli ultras. Ma so che esiste, che da decenni è studiata, e che esistono strumenti per imbrigliarla e persino governarla. E da domenica so pure che lei questi strumenti non li sa usare. Perciò è opportuno che lasci l’incarico a qualcuno più esperto e al passo coi tempi. Lei è un uomo colto, esperto di economia, politico navigato: i campi in cui può mettere a frutto le sue competenze sono numerosi, e se tra questi non c’è, come s’è visto, la gestione della pubblica sicurezza, io non ne farei un dramma. Bisognerebbe cominciare a capire che a un certo livello di professionalità (e di rimunerazione), le seconde occasioni per chi sbaglia non esistono più.
Vizi italiani (1): gente volgare
10-07-2007, 08:56calcio, fratelli d'I., mondiali, vizi italianiPermalink Scriverò meno parolacce
Scriverò meno parolacceScriverò meno parolacce
Scriverò meno parolacce
Davvero, non è per fare l’antisnob – che comunque sarebbe snob: io ricordo di essere stato felice, seriamente felice, appena Grosso segnò l’anno scorso. Parte della mia felicità derivava senza dubbio dal trovarmi in un’aula piena per metà di francesi, che per due ore ci avevano urlato nelle orecchie zizù, zizù (e una manciata di questi francesi ci toccò poi consolarla per lunghe ore, sempre per via del loro odiosoamato zizù, zizù). Ma non escludo per qualche minuto di essermi sentito davvero fiero di essere italiano, fiero di una nazionale senza molta classe ma con tanto carattere, e sudore, e scarponi, tutte caratteristiche che in fondo mi ritrovo.
Ricordo anche molto bene quando è finita: appena il pupone è salito sul palco della premiazione col tricolore a mo’ di foulard, come un tredicenne in gita scolastica. Insomma, è il momento più alto della tua carriera sportiva, è un momento di gioia per tutta la nazione, e tu fai il pagliaccio. Per conto mio la festa era terminata, e rovinata.
Se almeno Totti avesse avuto l’esclusiva della cafonaggine. Ma Gattuso, l’eroico Gattuso, invece di posare immediatamente per una statua di marmo da riprodurre e distribuire in tutte le piazze italiane, cominciava a bere e a dire sciocchezze ai giornalisti, estasiati. “Abbiamo avuto due coglioni grossi come una casa, nel senso che abbiamo lottato su tutti i palloni”. In mondovisione. In seguito avrebbe alluso a pratiche anali. Un bell’esempio per tutti i minorenni maschi d’Italia, ma del resto che cosa ti aspetti? Gattuso era allenato per l’occasione da un CT che a telecamere accese dava degli stronzi ai giornalisti.
Si fanno tanti confronti tra il 2006 e il 1982, il più delle volte giocando sui dati soggettivi: certo, nel 1982 mi divertivo anche solo a giocare a biglie sulla spiaggia, non c’è dubbio che stessi meglio, perciò viva Bearzot. Alcuni dati oggettivi però ci sono: quell’Italia segnava di più e non diceva le parolacce. Perlomeno non le diceva davanti ai microfoni, che per me fanno tutta la differenza.
Da emiliano, ho sviluppato una certa tolleranza per la bestemmia sul luogo di lavoro: ma quando parli ai microfoni, tu parli ai tuoi bambini. Non credo che Bruno Conti o Ciccio Graziani avessero uno spessore culturale superiore a quello di Totti o Gattuso, ma so che loro non avrebbero mai detto “abbiamo avuto due coglioni grossi come una casa”. Nel 1982 le parolacce avevano il loro posto, e il loro senso. Oggi no. Oggi sono abbellimenti retorici, per gente che si trova un microfono davanti e deve usare l’unica retorica che sa. “Non è per fare una leccata”, diceva Gattuso prima di fare un complimento a Del Piero. Coglioni, stronzi, leccate, vaffanculo: tutte parole vecchie, arcinote ben prima del 1982; la novità è che hanno tracimato. Si sentono in tv, in radio, sono il principale espediente usato dai registi italiani per far ridere il pubblico. Quel che è successo alla lingua italiana è che sono saltati i registri: quello basso e volgare ha contaminato tutti gli altri.
Gli inglesi non ne hanno un’idea. Gli inglesi sono convinti che Berlusconi abbia dato alla Thatcher della “gnocca” (l’Independent suggerisce di pronunciare “nyocca”), e questo basta per un articoletto di colore. In realtà Berlusconi ha detto persino di peggio: “Se fosse stata una bella 'gnocca' me la ricorderei ancora...” Invece, siccome la lady di ferro ha semplicemente piegato i laburisti, i sindacati e l’Argentina, Berlusconi fa un po’ fatica a ricordarsela. E uno se la dovrebbe prendere con Gattuso? Gattuso dice la parolaccia perché è l’unica cosa un po’ spiritosa che gli viene in mente, in fondo lui lavora coi piedi. Berlusconi invece lavora con la lingua, è un laureato, ha un intero impero editoriale che può scrivergli i discorsi, e puntualmente se ne esce con queste cose: la Thatcher non è una bella gnocca, Prodi dice stronzate, gli elettori non sono così coglioni da votare contro i loro interessi, eccetera. Senza dubbio Berlusconi ha qualche responsabilità nella degenerazione del lessico italiano, un fenomeno recente quanto lui. Ma non è senz’altro stato il primo. I due pionieri sono stati Bossi e Cossiga, anticipati forse da Pannella.
A questo punto – siccome qui non ci si accontenta del facile moralismo sulle parole volgari – bisogna spiegare cosa c’è, di così scandaloso, in questa tracimazione delle parolacce. Cosa ci perdiamo? Beh, per prima cosa ci perdiamo le parolacce. Sono preziose. Hanno un’energia rara, che deriva da un elemento (l’osceno) difficile da maneggiare. Ma come le monete, le parole soffrono l’inflazione. Ci fu un tempo in cui dare dello stronzo a qualcuno era quasi una maledizione biblica: come se l’obiettivo dell’insulto dovesse trasformarsi d'incanto in una colonnina di escremento solido. Ma se comincio a dare dello stronzo a chicchessia, il mondo non si popola di siffatte colonnine, al contrario: è la parola “stronzo” a sapere sempre meno di fece e sempre più di uomo. Alla fine oggi stronzo è quasi un complimento, nessuno pensa più che in principio trattavasi di materia fecale. Abbiamo guadagnato un sinonimo (abbastanza inutile) per “simpatica canaglia”, e abbiamo perso una parolaccia straordinariamente forte. Ecco un motivo per non dire più le parolacce: per salvarle dalla morte più grigia, la banalizzazione. Occorrerebbe invece lavorare in senso inverso: ridurre l'uso delle parole forti, salvarle per i momenti speciali. “Rogna”, in sé, non è nemmeno così volgare: ma quando Dante la piazza nel bel mezzo del Paradiso, sembra veramente che vengano giù i Santi.
Infine: la parolaccia è un limite del linguaggio. Se anche il lessico politico raggiunge quel limite, esaurisce tutte le sue possibilità (non a caso vi ricorrono spesso uomini politici anziani, che nulla più hanno da perdere). Di cosa parleremo negli spogliatoi e nelle caserme, quando gli onorevoli si saranno presi tutte le nostre parole sconce? Perciò abbiamo bisogno di una nuova classe dirigente che la smetta di blandire il popolo con le battute da osteria, e se questa classe dirigente non c’è, ci arrangeremo con Veltroni, che questa cosa l’ha capita da tempo, almeno. L’ha capita meglio dei blogger, me compreso, che alla facile parolaccia indulgono.
E tuttavia, se da (cattivo) politico volentieri lancerei una campagna paternalista anti-parolaccia, da (cattivo) linguista sarei scettico sui risultati. Non è così che vanno le cose. Quando le parole tracimano, tracimano, non c’è niente da fare. Forse puoi convincere Gattuso a non dire più “coglioni” in conferenza stampa (e in effetti è incredibile che nessuno glielo abbia spiegato), ma non i bambini che ormai Gattuso lo hanno sentito. Direi che tutte le parolacce della mia generazione ormai sono state assorbite dal lessico tv. Come a dire che hanno smesso di essere parolacce, e che difficilmente i posteri le riconosceranno tali. I nostri sbadati lettori futuri troveranno estremamente formali le nostre dispute a base di “stronzo” e “vaffanculo”, esattamente come noi irridiamo gli antenati coi loro “perdindirina” e “Gesù Giuseppe e Maria”.
Non avete un’idea di quante parole d’uso comune o persino scientifico siano state, in un’altra epoca, parole sconce. La vagina era il fodero della spada, il glande era la ghianda: eufemismi piccanti da non pronunciare davanti a una signora. In fondo la volgarità è una porta del linguaggio, da cui entra il materiale grezzo che nel corso dei secoli l’erosione dell’uso trasforma in parola comune. Mettersi davanti alla porta è un gesto abbastanza stupido. E allora?
E allora vaffanculo. Forse vale la pena di sdoganarle tutte, ripeterle fino alla noia, finché non perdano quell’infinitesimale residuo di simpatica volgarità che trattengono ancora. Quando saranno parole come le altre, Berlusconi non avrà nemmeno più interesse a pronunciarle.
E nel frattempo ci sarà sempre, in uno spogliatoio o in un campeggio, qualche oscuro geniale ragazzino pronto a inventare sconcezze nuove. Perché ce n’è bisogno. Basta che non tracimino subito: la lingua ha i suoi tempi.
aspettando i treni, guardandosi in giro
08-02-2007, 09:36calcio, circenses, Inghilterra, Scalfarotto, società dell'avanspettacoloPermalink A letter to Ivan
A letter to IvanCaro Scalfarotto,
abbi pazienza per questo mio finto tono informale, in realtà non ci conosciamo. Non ho neanche votato per te alle primarie, mi scuserai.
Ho appreso con piacere del tuo nuovo incarico in Inghilterra.
Ti scrivo perché ho letto che l’altro giorno, mentre guardavi il notiziario BBC su uno schermo al plasma, a bordo del “carissimo ma efficientissimo trenino Heathrow Express che in 15 minuti ti porta in centro a Londra”, ti chiedevi che senso avesse, in Italia, continuare col campionato di calcio.
[...] non si capisce a cosa serva questa specie di circo putrido, incivile, sanguinolento e fallimentare. Davvero: a cosa serve? A chi giovano le devastazioni sui treni e negli autogrill? Chi è responsabile del fatto che da decenni si tollerano le peggiori manifestazioni di violenza e le più meschine apologie di nazismi, fascismi, forni crematori e quant'altro? Perché non lo si è ripulito fino ad oggi come è successo in ogni altro paese civile? Qual è il contributo del calcio professionistico alla cultura sportiva del paese? Che danno verrebbe alla nazione semplicemente levandolo definitivamente di mezzo?
Forse era una domanda retorica; o forse da lassù è davvero difficile capire queste cose, con tutto il movimento che c’è. In ogni caso lascia che ti spieghi, caro Scalfarotto, che levare il calcio agli italiani, a questo punto, sarebbe come sospendere la morfina a un malato grave (forse terminale). Non è detto che non sia la cosa giusta: ma bisogna andarci coi piedi di piombo. Qui da noi siamo riflessivi, lo sai. È un vizio che prendiamo da giovani, aspettando a lungo i treni.
Nello stesso pezzo ti chiedi perché non è mai venuto in mente a un nostro Ministro dell’Interno di telefonare all’Home Office britannico, per chiedere come si fa a risolvere il problema degli hooligans. Domanda più che legittima. Eppure, dopo attenta riflessione (tanto il treno non arriva), sono giunto alla conclusione che sarebbe inutile chiedere medicine agli inglesi: la nostra malattia è molto diversa.
È vero che i sintomi sono simili: folle in delirio intorno a 44 polpacci sudati. Ma la storia clinica che c’è dietro è assai differente. È qualcosa che ci portiamo dalla notte dei tempi, delle nostre rispettive civiltà. Semplificando: gli inglesi hanno inventato il libero mercato, noi siamo famosi nel mondo per alcuni antichi proverbi come Divide et Impera, Panem et Circenses, e più recentemente per prodotti doc come la mafia, il fascismo e il corporativismo. Ebbene, se hai pazienza ti spiego in che modo il calcio è lo specchio di tutto questo. Sì, lo so, tu a quest’ora sei già in riunione. Io invece sono ancora qui, l’espresso non arriva. Neanche a pagarlo col supplemento rapido. Non mi resta che rimuginare, su questa panchina, fingendo che tu sia qui con me.
Il calcio professionistico inglese è nato, ed è sempre stato, un’economia di mercato. Contrariamente a quanto si potrebbe credere, per molti decenni è stato un piccolo mercato. I calciatori non guadagnavano molto più di un operaio specializzato. Tanto che iniziarono prestissimo (1908) a sindacalizzarsi.
Del resto le squadre non avevano moltissimo da offrire. Erano (piccole) società private, e possedevano gli stadi – quegli leggendari stadi proletari, dove si stava in piedi aggrappati a una sbarra. Le piccole squadre campavano vendendo biglietti ai tifosi e i gioiellini alle squadre più forti. Le squadre più forti, per mettere a libro paga i fuoriclasse, dovevano vendere più biglietti. Economia di mercato, senza tanti fronzoli.
Quando negli anni Cinquanta il calcio inglese si aprì al resto del mondo, alcuni di questi operai-calciatori scoprirono una cosa curiosa: che potevano far fortuna all’estero. Ti ricordi del gigante buono della Juventus, John Charles? Beh, lì da te Charles è conosciuto come “The first rich British footballer”, il primo calciatore britannico a far soldi. E non li fece in Inghilterra, no. Li fece qui da noi. Nel 1957 la Juventus gli offrì quattro volte il tetto massimo consentito in Gran Bretagna per un calciatore.
Ora, dimmi tu: secondo la più elementare logica della domanda e dell’offerta, è possibile che negli anni Cinquanta l’Italia avesse un mercato così competitivo da attirare i calciatori britannici? No, non è possibile. Il fatto è che in Italia, già nel 1957, non c’erano squadre-imprese affidate a manager con l’ossessione di quadrare i bilanci. Ma c’erano gli Agnelli, che volevano offrire ai loro concittadini e sudditi un gioiellino. Eravamo ancora in un’economia da mecenati rinascimentali, capisci? Il signore della città che sborsa milioni per questioni di prestigio. Pensa a come il vecchio Agnelli chiamava i suoi gioiellini: Raffaello, Pinturicchio… O pensa, se preferisci, al questore edile che nell’antica Roma dilapidava le sue fortune in Circenses per farsi eleggere Console. Cinquant’anni dopo siamo ancora lì, alla Roma dei Cesari o alla Firenze dei Medici. Forse non ne usciremo mai, come questo Intercity che arranca, sul binario steso un secolo fa.
 Ma del resto, c’è mai stata una vera economia di mercato, in Italia? Se togli le oligarchie del vecchio capitalismo famigliare, il sommerso di mafia e camorra, gli interessi corporativi e le storiche lottizzazioni tra partiti, cosa resta? Di sicuro non il calcio. Nessun imprenditore ha mai cercato di fare fortuna col calcio. Le squadre di serie A, B, persino C, sono quasi sempre in mano a qualche industriale che aveva soldi da sbattere via – letteralmente: da sbattere via. Quando Tanzi prese il Parma, Cecchi Gori la Fiorentina, Moratti l’Inter, non pensavano certo di lucrare. Il loro primo interesse era farsi belli davanti ai concittadini. Altri più avveduti, come Berlusconi, hanno utilizzato il calcio come veicolo promozionale per lanciare altri prodotti. Il calcio italiano non è autonomo, non se lo può permettere. Gli stadi sono in affitto: li mantengono i contribuenti. Anche la sicurezza negli stadi è a carico nostro. I tifosi non sono un pubblico pagante, libero di decidere se una squadra merita o no di essere seguita. La tifoseria italiana è l’erede della plebe romana: deve credere ciecamente ai suoi colori, acclamare i suoi tribuni o calpestarli.
Ma del resto, c’è mai stata una vera economia di mercato, in Italia? Se togli le oligarchie del vecchio capitalismo famigliare, il sommerso di mafia e camorra, gli interessi corporativi e le storiche lottizzazioni tra partiti, cosa resta? Di sicuro non il calcio. Nessun imprenditore ha mai cercato di fare fortuna col calcio. Le squadre di serie A, B, persino C, sono quasi sempre in mano a qualche industriale che aveva soldi da sbattere via – letteralmente: da sbattere via. Quando Tanzi prese il Parma, Cecchi Gori la Fiorentina, Moratti l’Inter, non pensavano certo di lucrare. Il loro primo interesse era farsi belli davanti ai concittadini. Altri più avveduti, come Berlusconi, hanno utilizzato il calcio come veicolo promozionale per lanciare altri prodotti. Il calcio italiano non è autonomo, non se lo può permettere. Gli stadi sono in affitto: li mantengono i contribuenti. Anche la sicurezza negli stadi è a carico nostro. I tifosi non sono un pubblico pagante, libero di decidere se una squadra merita o no di essere seguita. La tifoseria italiana è l’erede della plebe romana: deve credere ciecamente ai suoi colori, acclamare i suoi tribuni o calpestarli.Non che in Gran Bretagna sia sempre stato tutto rose e fiori: con tutta la nostra guerriglia domenicale, un massacro come Hillsborough in Italia non c’è ancora stato (forse è quello che ci manca per voltar pagina davvero). Ma dopo Hillsborough il sistema del calcio inglese ha mostrato gli anticorpi. I club hanno capito che per sopravvivere dovevano evolversi. Hanno tolto le sbarre e hanno montato le poltroncine sugli spalti. Hanno dimezzato i biglietti, e hanno scoperto l’economia dei diritti tv. Hanno investito in sicurezza, perché non potevano contare sui bobby della Regina per ogni minimo tafferuglio. È stato pesante, ma l’alternativa era fallire. E per chi fallisce non c’è perdono.
In Italia un perdono, un condono, c’è sempre. C’è sempre un padre amoroso, ansioso di rimetterti i peccati. Le stesse squadre non sono imprese, ma entità metafisiche che passano liberamente da un fallimento all’altro, da una proprietà all’altra. Per loro non valgono le regole dell’economia o del buon senso: non so quale altra società al mondo abbia il diritto di spalmare i propri debiti su una distanza di trent’anni. Perfino gli intellettuali si inginocchiano ai riti della plebe: guai se gli tocchi i colori, gli stendardi, i gonfaloni. Siccome sugli spalti non c’è vera economia, si fa il possibile per trovarci qualcos’altro: cultura, senso di appartenenza, e tutte le altre baggianate che servono a coprire la realtà più evidente.
E la realtà più evidente è che il calcio vive, da un secolo e più fuori dall’economia, finanziato dallo Stato, perché lo Stato ha bisogno di una valvola per il disagio del proletariato urbano. Quei vecchi pensatori oggi in disuso, che nell’Ottocento davano per imminente la rivoluzione, erano meno ingenui di quello che pensiamo. Vivendo nelle prime città industriali, si guardavano attorno e vedevano una rabbia, un’energia, che nulla sembrava poter contenere. Prima o poi quest’energia avrebbe trasformato il mondo. Era chiaro.
Ma avevano fatto i conti senza il calcio. Questa pesissima varietà di oppio dei popoli, di fronte al quale la Chiesa cattolica è solo un placebo per bambini e vecchiette. Chi poteva immaginarselo, a metà Ottocento. Proletari di tutto il mondo, fatevi la guerra. Palermo contro Catania, ultrà contro poliziotti, passatevi il tempo. Ché alternative, per voi, non ne abbiamo.
A meno che non ne abbia una tu, caro Scalfarotto.
Ma tu non mi ascolti. A quest’ora il tuo meeting è finito, e magari stai già prendendo un altro treno.
Anche il mio, finalmente, è arrivato. Saluti.
Solo, un’ultima cosa:
non crederti al sicuro.
No, cos'hai capito, non è una minaccia. È una constatazione. È vero che il calcio inglese funziona meglio. Ma certi problemi del calcio italiano sono sintomi di un malessere di tutta l’Europa occidentale. Dopotutto la Storia non ha sensi di marcia obbligati. E se quelli avanti, per una volta, fossimo noi?
La guerriglia urbana settimanale, la gestione camorristica dello sport, la società dell’avanspettacolo, non sono necessariamente retaggi di un passato. Forse sono il futuro: anche il vostro futuro.
Può essere una mia impressione, ma ultimamente è il calcio inglese ad essersi accostato al modello italiano. I grandi club stanno cominciando a monopolizzare il campionato: non era mai successo. Il Chelsea è in mano a un miliardario russo che sbatte via capitali per questioni di prestigio, e forse per riciclare un bel po’ di denaro sporco. Non è detto che tra un po’ non sia l’Home Office a telefonare al Viminale, per chiedere come si risolvono certi affari.
E al Viminale, gli eredi di una sapienza di generazioni di treni in ritardo, probabilmente gli risponderanno che certi affari non si risolvono: si gestiscono e basta.
Adesso ho veramente finito. Scusa per lo sfogo, e buon lavoro.
- campioni
10-07-2006, 17:47Berlusconi, calcio, fratelli d'I., generazione di fenomeni, Ligabue, mondiali, OttantaPermalinkI meri fatti sono questi: Zidane ha perso la testa e Trezeguet ha preso una traversa.
Il risultato, indiscutibile, e' che siamo Campioni del Mondo. Tutti cinquanta milioni e rotti quanti siamo. Campioni. Ce lo meritiamo? Non troppo. Lo meritavano i francesi? Men che meno. C'era il rigore? No (ma ce n'era un altro nel secondo tempo). C'era il fuorigioco sul gol annullato? Non lo so, qui tutti hanno urlato e non si e' capito niente.
Cos'ha detto Materazzi a Zidane? In francese si dice provo'. Se la pazzia di Zidane potra' insegnare a milioni di piccole pesti francesi a non reagire alle provo', tanto meglio. Noi dopo Baggio abbiamo imparato a tirare i rigori.
Antropologia spicciola: i francesi (studenti) urlano piu' degli italiani, ma urlano solo nei momenti piu' intensi. Hanno un Dio: Zizou. E vari idoli: Henry, Barthez, e via scendendo. Quando Zizou impazzisce, restano gelati. Non glielo perdoneranno mai. Ancora tra quarant'anni spiegheranno ai loro figli che la finale l'ha persa lui.
(Non e' cosi' vero.
Negli ultimi dieci minuti, con un uomo in piu', il centrocampo italiano non riusciva a spingere. Ma la difesa teneva. Zidane avrebbe pascolato fino al 120', e poi avrebbe segnato il suo bel rigore. Ma Trezeguet avrebbe preso la traversa ugualmente).
Per contro, gli italiani commentano le azioni. Non hanno nessun Dio a cui raccomandarsi, ma soltanto calciatori che potrebbero sempre dare un po' di piu'. Dai Zambrotta, dai Gattuso, spingi Pirlo, non far cazzate Materazzi, e dove cazzo e' Totti, e' sceso in campo o no? La nazionale si critica fino all'ultimo minuto secondo.
Questo forse manca ai francesi: un po' di sano senso critico. Zidane ne avrebbe avuto bisogno. Ma e' antropologia da due soldi.
Come ci si sente a vincere per un soffio, all'ultimo minuto, lo sappiamo gia'. Di sicuro avremmo preferito vincere come i nostri genitori. Tre botte al Brasile, due alla Polonia, tre alla Germania. Quella era gente seria. Noi siamo quelli che siamo, e si sa.
Siamo, per dirla con una parola che vuol dir tutto e niente, berlusconiani. Dove "Berlusconi" ormai e' un concetto che col povero S. B. non ha niente a che fare. Ma il tormentone di quest'anno, dal Caimano in poi, e' stato questo: Berlusconi ha vinto, siamo tutti figli suoi.
Siamo immaturi e un po' ignoranti. Tatuati e pasticcioni. Abbiamo prosperato in un clima moralmente discutibile, dove gli arbitri finivano chiusi negli spogliatoi e noi credevamo che fosse ok. Abbiamo peccato di parole, di opere, e soprattutto di omissioni. Ci sarebbe piaciuto essere persone piu' serie, ma alla fine non siamo altro che noi.
D'altro canto, non siamo necessariamente peggio degli altri. E siccome saremo ancora noi, per molti anni, tantovale farvelo vedere: se c'e' bisogno lottiamo, su ogni pallone, se c'e' bisogno mandiamo a casa i padroni di casa, e neanche gli armadi d'ebano francesi ci fanno paura.
Non siamo Dei, siamo terzinacci. Ma neanche voi siete Dei, mettetevelo in testa. Noi siamo campioni perche' non crediamo piu' a nessun intervento divino, di manager o arbitro o centravanti miracolato. Crediamo solo in noi stessi, e anche poco.
C'e' questa vecchia idea asfissiante, questa riduzione della Storia d'Italia ai minimi termini, per cui gli anni di piombo finiscono al Santiago Bernabeu. Di vero c'e' questo: negli anni Ottanta ci siamo tutti un po' montati la testa. Abbiamo vissuto al di sopra delle nostre capacita', e stiamo ancora pagando.
Succedera' di nuovo? Io spero di no. Vorrei che questa vittoria avesse un sapore diverso. Il riscatto per una generazione che ha fatto melina per troppo tempo. Che viveva di illusioni e rimediava solo figuracce (2002 e 2004).
E' una generazione che non mi sta simpatica, ma alla fine e' la mia. Sono io. Non posso mica inventarmi diverso da quel che sono. Sono come tutti voi, uno che e' cresciuto un po' troppo lentamente. In ogni caso sono cresciuto, e adesso si tratta di farvela vedere. Si tratta di lavorare, tutto qua. Non c'e' nessun regista miracoloso a cui passar la palla. Da qui in poi stacco, senno' divento Ligabue.
- italian stallions
06-07-2006, 16:51Americana, calcio, mondiali, società dell'avanspettacoloPermalinkMa insomma questa World Cup la guardano, gli americani. Perche'? Cosa ci trovano? E' l'unico sport in cui non sono obbligati a vincere: pure, si sciroppano partitacce di nazioni esotiche come Ucraina o Portogallo; mandano giu' serafici l'umiliazione di farsi buttare fuori da Ghana o Boemia; non si smuovono dal video, anche se nessuno segna per due ore, una cosa impensabile in qualsiasi altro sport. Perche'?
Ebbene, sentite un po' questa. Gli americani guardano il soccer perche' e' divertente. Proprio cosi'.
E' divertente - l'avreste mai detto? - addirittura fa ridere. Quando un CT disperato getta uno straccio nel secchio, loro si mettono a ridere. Quando l'ennesimo centrocampista si butta giu' dolorante per un contatto, il volto contorto in una maschera tragica (e il 90%, va detto, sono in maglia azzurra), loro si sganasciano. Quando Grosso si mette le mani nei capelli, disperato per un calcio in uno stinco, si sbudellano. Gattuso, poi, fa ridere solo a guardarlo.
Davvero, non si rendono affatto conto della gravita' della cosa. Quando infine Grosso segna, e la diretta per un attimo mostra un'immagine del Circo Massimo che s'infiamma, loro ridono a crepapelle. Non gli passa per la mente il fatto che da qualche parte nello stesso mondo ottanta milioni di tedeschi hanno cominciato a soffrire e cinquanta milioni di italiani hanno le palpitazioni. Non sanno quanti padri di famiglia tedesca stiano seriamente pensando di cambiare localita' balneare per l'agosto, onde evitare l'irridente bagnino romagnolo. Ne' concepiscono il dramma schizofrenico del bagnino romagnolo, che sogna da 24 anni l'umiliazione del crucco, ma nel frattempo teme di non rivederlo per un'intera estate. Non ne sanno niente, loro.
Per loro e' un gioco, in cui nessuno segna quasi mai, ma quando qualcuno segna poi e' finita. E' divertente questa cosa, che il pallone non si puo' toccare con le mani. Le strattonate, i fischi, i tuffi. I portieroni coi loro guantoni.
E l'Europa tutto intorno, che trattiene il sospiro, e' uno spasso.
- lo spettacolo nell'era in cui è da idioti pagarlo
22-05-2006, 09:37calcio, circenses, l'era dell'ottimismo, Moggi, riproducibilità, scandalismiPermalink Bisogna essere scemi
Bisogna essere scemiScusate se continuo a parlarne come se me ne intendessi, ma il calcio è davvero una metafa potente. Come a dire che è tutta una finta, non è di calcio che si sta parlando qui.
Uno dei paradossi del calcio contemporaneo, ad esempio, è la selezione naturale degli utenti più scemi. Intendo dire che come molti altri servizi voluttuari, il calcio, nell'era della riproducibilità digitale e gratuita, è destinato a fare affidamento sugli unici che insistono ancora per pagare, vale a dire quelli che non apprezzano una partita di calcio per quello che è, ma ne fanno un feticcio, deformato da una serie di connotazioni extracalcistiche (attaccamento ai colori, campanilismo, cameratismo, non saper come passare la domenica pomeriggio, ricerca di un senso della vita). Ma i feticisti sono, per definizione, irrazionali e irresponsabili. Spero di non offendere nessuno se li definisco, per amor di brevità, scemi. Ebbene, l'industria del calcio oggi distilla i più scemi tra gli utenti, e ne diventa schiavo.
Cerco di spiegarmi meglio. Il grande problema dell'industria dello spettacolo, oggi, è farsi pagare. Questo, a causa delle tecnologie su cui viaggia lo spettacolo, autostrade dell'informazione, via banda larga o satellitare, che sono meravigliosamente efficienti e indispensabili, ma hanno un grosso difetto: sono insofferenti ai pedaggi. Appena individui un tratto dove mettere un pedaggio, tutt'intorno si mettono a fiorire le scorciatoie. Legali o meno. Di solito meno.
Ora, attenzione: fingiamo per amor di teoria che le persone siano catalogabili unicamente per la loro intelligenza: che non vi siano persone più o meno belle, simpatiche, abbronzate, stronze, furbe, ma solo più o meno intelligenti. Detto questo, chi saranno secondo voi i primi a trovare la scorciatoia per pagare meno un servizio (o non pagarlo affatto)? I più intelligenti e informati. È ovvio.
E chi saranno gli ultimi ad accorgersene e a smettere di pagare? I meno intelligenti.
Può darsi che lo facciano perché sensibili a un concetto di legalità, o per tradizione, per senso di responsabilità, attaccamento alla maglia, eccetera eccetera: ma tutte queste cose nel nostro modello non risultano, il nostro è un modello in bianco e nero in cui appare soltanto questo: chi continua a pagare per vedere una partita di calcio è un deficiente.
Naturalmente non è tutto bianco e nero, ci sono miliardi di sfumature: in alto (bianco puro) abbiamo l'ingegnere trafficone che guarda tutto via adsl sul sito pseudoclandestino – oppure ha clonato SKY – seguono sfumature di neve sempre più sporca (chi va al bar, chi ha approfittato della super-mega-offerta del mese), fino al grigio cupo di chi la partita la paga fino all'ultimo centesimo. E poi le varie sfumature di nero di chi la partita la va ancora a vedere allo stadio: tribuna, gradinate, curva. Nel nostro modello costoro sono i più scemi: pagano relativamente di più per usufruire di meno servizi (niente primi piani, replay, commenti) e per correre più rischi (fila al WC, pioggia, tafferugli, precipita dal terzo anello un ciclomotore). Nella realtà naturalmente non è così: non è idiozia quella che li porta allo stadio alla domenica, ma attaccamento ai colori, sano cameratismo, voglia di dare un senso alla vita… ma tutte queste cose nel nostro modello, purtroppo, non si vedono. Nel nostro modello, ripeto, l'utente che paga di più per usufruire di meno servizi è considerato il deficiente.
Si tratta anche dell'unico tipo di utente che porta soldi alla maggior parte delle squadre – i soldi di Sky e company, com'è noto, se li pigliano le grandi, quindi…
Quindi, diabolicamente, le squadre medie e piccole devono investire sugli utenti scemi: ossia quelli che invece di procurarsi un'adsl, una carta clonata, una carta vera, un amico che ce l'ha, un bar… preferiscono venire allo stadio, per tutti quei famosi motivi: attaccamento ai colori, necessità di passare il pomeriggio della festa scandendo cori a rischio di beccarsi ciclomotori e mazzate. Gli ultras, insomma. Gli unici abbastanza idioti da pagare per quel che vedono: le squadre si sono messe nelle loro mani.
Verso la fine, l'Impero Romano si basava su un tacito accordo tra Imperatore e plebe romana. L'Imperatore manteneva la pace tra i confini e continuava a distribuire razioni di grano gratis da tutte le regioni dell'impero: la plebe mangiava a sbafo e non rovesciava l'imperatore. In sostanza, il bacino del mediterraneo era soggetto all'appetito della plebe romana. Il calcio contemporaneo, che smuove miliardi, è nelle mani delle plebi di una ventina di città, che in virtù della loro idiozia (pagano per vedere ciò che è gratis su tutti gli schermi ad alta definizione del mondo!) possono fare e disfare squadre, cacciare presidenti e allenatori, addirittura creare bolle di illegalità garantita. Se io non posso saldare un debito, dopo alcuni mesi verranno a pignorarmi. Ma se sono il presidente della SS Lazio, posso saldare comodamente in una trentina d'anni. Perché? Perché il presidente ha un po' di plebe dalla sua parte, perché se la sua squadra fallisse quel po' di plebe ruggirebbe forte, e fa paura la plebe quando ruggisce.
Il paradosso, purtroppo, funziona per tutta l'industria dello spettacolo. Prendiamo la musica: perché negli ultimi dieci anni le major sembrano avere investito soltanto su sgallettate improponibili? Perché bisogna essere idioti per pagare una canzone, oggi, e gli idioti non sono sensibili a virtuosismi musicali, non hanno un grande orecchio per la melodia, ma sanno riconoscere un culo se gli balla davanti. Del resto è una corsa disperata: ormai anche un deficiente sa scaricare gratis un mp3 o una suoneria. Il settore musicale è più dinamico – il calcio è più lento. Ci sono un sacco di fattori cosiddetti 'culturali' (le tradizioni, l'attaccamento, il campanilismo) che ancora impediscono una manifestazione di idiozia pura. Ma la strada più o meno è tracciata: pian piano ogni riferimento vagamente culturale verrà via, come la farina dal setaccio, e sulle gradinate vedremo soltanto una congerie di scemi paganti. Giudicate voi quanto siamo vicini o lontani da quel giorno.
Spero di non avere offeso nessuno con questo pezzo, non era mia intenzione, mi state tutti simpatici. Ma mi è ancora più simpatica la realtà.
- la fiaccola sotto Moggi
16-05-2006, 03:12Berlusconi, calcio, circenses, crisi? che crisi?, Moggi, poveri piccoli imprenditori, scandalismiPermalink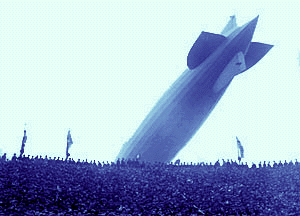
Eppure c'è gente che per il circo mediatico-giudiziario non riesce proprio a scandalizzarsi. Io, per esempio.
Lo confesso, è un mio limite, ci sono tante cose che non mi commuovono: le zingare ai semafori con preghiere di cartone, per dirne una, e un'altra sono i politici in manette. Massì, capisco, è un abuso di potere, lo so, però non mi commuovo. E anche Luciano Moggi può piangere tutte le calde lacrime che vuole, io resto di pietra. Sono giustizialista? Sono forcaiolo? Oppure semplicemente ho un'alta soglia di sopportazione.
Ognuno ha la sua, del resto. C'è fior di giornalisti, là fuori, che sapeva sapeva sapeva e nulla ha scritto, per anni, perché si sa come vanno le cose, finché ora basta, non se ne può più, la soglia di sopportazione è stata oltrepassata. Da chi? Da Moggi e Giraudo? Macché. Dai magistrati che torchiano, dagli intercettatori che non rispettano la privacy, dal circo mediatico-giudiziario.
Per contro, noi populisti forcaioli, è da vent'anni che ci scandalizziamo; da dieci che nel campionato italiano di calcio non ci crediamo semplicemente più: e oggi che c'è da inveire contro il circo mediatico-giudiziario, che ci volete fare, siamo un po' stanchi. Inveite voi, si fa un po' a turno.
Tutto questo in realtà non ha molta importanza. È molto più intrigante chiedersi: Luciano Moggi è un semplice accidente di percorso, o un difetto strutturale? Se è un accidente di percorso, è sufficiente farlo piangere ancora un po', interdirlo fino alla settima generazione, e poi passare ad altro. Ma siccome siete su Leonardo Blog, avete già capito dove voglio parare, vale a dire: secondo me Moggi è strutturale. Il che significa che il catrame e le piume non serviranno proprio a niente: cacciato con infamia un Moggi, ce ne servirà subito un altro. Perché il problema non è tanto Moggi, quanto… la struttura.
E che razza di struttura sarebbe il calcio, sentiamo. Beh, possiamo descriverla in vari modi. Struttura neoliberista: in un universo de-regolato, dove ogni squadra-società-per-azioni è libera di raccattare sul mercato qualsiasi giocatore a qualsiasi prezzo, prima o poi qualcuno doveva arrivarci: gli arbitri costano meno. E come investimento sono relativamente più sicuri. È proprio una semplice questione logica: perché svenarsi per i giocatori? Per gli sponsor, d'accordo, per il pubblico pagante. Ma se poi la squadra all-star non funziona? Se il Real Madrid galattico non quaglia? Se l'Europeo lo vince una squadra qualsiasi, tipo la Grecia? È il bello del calcio, ma comporta rischi economici che una squadra-società-per-azioni non può correre. E se intrallazzare con gli arbitri costa relativamente meno che procurarsi un paio di rinforzi a centrocampo, perché no? Sul serio, perché no? Morale: il calcio non può essere quotato in borsa. Una cosa è il professionismo, un'altra la speculazione, e Luciano Moggi è solo uno di quei manager che hanno agito per il bene degli azionisti, come i soldatini tedeschi obbedivano agli ordini del Führer. Fucilatelo se vi fa sentire meglio, ma il problema non è lui.
Questo in un universo neoliberista. Ma il calcio italiano è davvero in quell'universo? Qualche anno fa scrissi tre pezzi un po' naïf (1-2-3) in cui paragonavo il calcio inglese al calcio italiano, sull'unica base di un libro illustrato che stavo traducendo. La morale era questa: il calcio inglese è nato e si è sviluppato come una piccola industria, semi-artigianale. I calciatori hanno lottato per i loro diritti. Le squadre provinciali campavano costruendo dei campioni e rivendendoli alle Grandi. Le Grandi erano in realtà piccole ditte che si autofinanziavano con i biglietti negli stadi di loro proprietà. E tutto questo, fino agli anni Ottanta, generava ricchezza e la ridistribuiva.
Nel frattempo, in Italia, il calcio prosperava al di sopra delle sue possibilità. John Charles, “the first rich British footballer”, divenne "il primo calciatore britannico ricco" solo in Italia: la Juventus lo pagava quattro volte lo stipendio massimo consentito nel Regno Unito. Che senso avevano, questi ingaggi stratosferici?
Nessun senso strattamente economico. Il calcio non è mai stata un'attività veramente remunerativa in Italia – se così fosse le squadre sarebbero state società indipendenti, e non fiori all'occhiello dell'industriale, del petroliere, del palazzinaro di turno. Il calcio italiano del dopoguerra si è sviluppato come uno status symbol – un'attività in cui buttare un bel po' di soldi per dimostrare ai tuoi concittadini che ce l'hai fatta, sei in tribuna vips. E se avessimo dubbi sulla moralità e sull'effettiva intelligenza della nostra classe imprenditoriale, ci basterebbe fare i conti di quanti padroncini hanno rovinato sé stessi e i loro dipendenti con surreali operazioni di calciomercato. Da Zico all'Udinese all'Europarma di Tanzi, quanti soldi, quante energie buttate. E stiamo a prendercela con Moggi.
Moggi è semplicemente il capo dei briganti, e come tale lo considerava il suo padrone, Gianni Agnelli. Lo stesso che paragonava i suoi calciatori ai pittori del rinascimento: ecco cos'è il calcio in Italia, non un'industria, ma puro mecenatismo. Gli industriali contribuiscono alla pace sociale pagando la loro quota di circenses. Altro che neoliberismo. Stiamo ancora all'evo antico, ai Gladiatori. Oppure il guaio è stato passare troppo in fretta dal Circo Massimo alla Parabola, dal panem et circenses alla Società per azioni.
Rimedi? Si potrebbe cavar fuori il calcio italiano dall'evo antico, obbligandolo a diventare uno sport moderno, in cui tutte le squadre hanno rose di 22 giocatori e, udite udite, lo stesso budget: e si mantengono con il pubblico pagante.
Non c'è bisogno che me lo facciate presente, tutto ciò è frutto di un delirio, il tentativo di tornare a un modello europeo che non esiste più, perché a ben vedere è l'Europa che si sta italianizzando. È il calcio europeo che sta riscoprendo il modello pre-medievale del circo massimo: le squadre come brand mondiali, il calciomercato globale che serve anche a riciclare i soldi della malavita globale (pensare al Chelsea). L'Italia, che ha inventato il fascismo e il berlusconismo, continua ad esportare il peggio di sé. E c'è mercato.
 The passion of the Hrist
The passion of the HristEvviva l'Italia, evviva la Bulgaria, che ci ha fatto dono del Pippero…
Oggi si gioca contro la Bulgaria, e nell'aria sento il ben noto profumo di complotto, ma mi togliete una curiosità?
È da dieci anni che io mi domando una cosa.
USA '94, semifinale Bulgaria-Italia. La prima squadra è la rivelazione del torneo, ai quarti ha mandato a casa i campioni del mondo tedeschi, ma tutto sommato si tratta di Hristo Stoichkov più dieci onesti session men. La seconda, dopo una serie incredibile di espulsioni e infortuni, è un'armata Brancaleone che ormai fa perfino tenerezza, e tra espulsioni e infortuni si trascina di fase in fase soprattutto grazie all'abilità di Baggio a segnare negli ultimi minuti. Voi la ricordate, quella partita? Onestamente.
(USA '94 è vittima di una grande rimozione collettiva. Baresi in lacrime, Zola espulso per aver toccato la palla coi piedi in area, Maradona che sembra volerti entrare in casa e mangiarti, Maradona che esce dal campo mano nella mano con un'infermiera addetta alle urine, e già sente che lo stanno accompagnando al patibolo. Tanti brutti ricordi, ma alla fine sembra ridursi tutto a Baggio che sbaglia un rigore).
Insomma, vi ricordate Italia-Bulgaria del 1994? Vi ricordate che a metà del secondo tempo, con l'Italia vincente per uno o due a zero, il CT bulgaro sostituì, tra tutti, proprio Hristo Stoichkov? Dico a voi, spostatevi per una volta dalla vostra panchina virtuale dell'Italia; provatevi a sedere su quella della Bulgaria. Siete bulgari, ok? Non c'è niente di male, ma nel mondo siete famosi per: gli yogurt, il mistero delle voci di Elio e le Storie Tese, il voto all'unanimità, e per aver tentato di ammazzare un Papa polacco (che non è nemmeno vero). E per Hristo Stoichkov. Uno dei calciatori più forti d'Europa, del mondo di sempre. Vi ha portato ai Mondiali americani a spese della Francia. Ha ancora qualche possibilità di portarvi in finale. Contro il Brasile. Una finale Brasile-Bulgaria, v'immaginate? Beh, a questo punto voi cosa fate? Mandate in panchina Hristo Stoichkov. No, dico. Vi sembra una cosa normale?
Stava male? Non mi sembra che stesse male. Ma io, da CT bulgaro, lo avrei tenuto in campo anche su un piede solo. Cosa facevo, lo risparmiavo per la finale terzo-quarto posto? (nella finale terzo-quarto, i bulgari furono sepolti dalla Svezia).
Adesso, non è che io sia un avido lettore di stampa sportiva, ma non ho mai trovato una spiegazione razionale per quella sostituzione. Faccio appello a chi passa di qui, ce n'è sempre qualcuno più informato di me (sul calcio, ce ne sono parecchi di più informati di me). Voi ricordate l'episodio? Ricordate come lo presentò la stampa? Ricordate se qualche giornalista gridò al complotto? Io ho un bel da cercare, non me ne ricordo. Come se si potesse complottare solo ai danni dell'Italia, mai in favore. Inverosimile – anche solo per la legge dei grandi numeri.
E se non fu complotto, riuscite a trovare qualche altra spiegazione razionale? Se sì, vi ringrazio. È imbarazzante, con tutti i problemi che ci sono al mondo, avere anche una sola cellula del cervello che continua a farsi una domanda stupida dal 1994.
Servizi segreti bulgari… e italiani, via
Sentite come pompa il Pippero!
 Ma quando cresci
Ma quando cresciA un certo punto i calciatori hanno smesso d'invecchiare. Si vede perfino dalle foto. O è un'impressione mia?
Ho qui davanti un almanacco Panini del 1984, con Bruno Conti in copertina. Bruno Conti, per me, è un uomo. È sempre stato un uomo. Mi costa fatica ammettere che quando vinse la Coppa del Mondo aveva la mia età. Riguardandolo, mi accorgo della muscolatura notevole, e dell'addome che sporge lievemente: negli anni Ottanta era ancora un attributo mascolino. E mi sembra un uomo, maturo e affidabile.
In fondo è una questione di punti di vista. Io guardo il mondo da un punto in movimento (anche voi, del resto). Attraverso il mondo precipitando, ma in mancanza d'attrito ho l'impressione di galleggiare fermo, mentre il mondo mi precipita intorno. E le cose più vicine appaiono distorte, una specie di effetto Doppler. A un certo punto la figura del calciatore si è distorta, è passata da eterno adulto (mio padre…) a eterno ragazzo, bambinone, pupo. Quando è successo? Provo a guardarmi indietro. Paolo Maldini.
Paolo Maldini, in effetti, sembrava non crescere mai. Il Tom Cruise, il Michael J. Fox del calcio italiano: quando comincerà ad assomigliare a un adulto? (Se ci rifletto bene, mi accorgo che gli sto chiedendo di invecchiare prima di me, di precipitare più alla svelta). Accanto a lui giocava Franco Baresi, l'ultimo grande adulto. Forse la generazione di mio padre finisce con Baresi (Franco), la mia comincia con Maldini (Paolo). E forse anche la mia è già finita. Da qualche anno in qua i calciatori mi sembrano tutti bambocci.
D'altro canto, non devo neanche dare eccessivo peso alla mia soggettività. Può darsi che siano davvero un po' tutti bambocci. Troppi soldi troppo presto, e un modello di giovanilismo estenuato, perché il calcio è marketing e il marketing punta tutto sul grande target giovanile. L'orecchino, il tatuaggino, l'acconciatura carina… e poi questi addomi concavi, questo nuovo modello di mascolinità fortemente innaturale (gli antropologi di domani guarderanno alle copertine di Men's Health come noi guardiamo le foto delle donne africane che si allungano il collo coi collari o gli aborigeni che si allungano labbra o lobi delle orecchie: "che strani gusti… mah… era la loro cultura").
Tutto questo non mi piace, non mi è mai piaciuto, sin dal primo momento, dal primo spot orientato su di me. Così guardo indietro, ai campioni del Mondo. Quelli sì che erano uomini. Giganti. Poi arriva Gigi Riva e mi scuote un po' di certezze.
Riva è una figura mitica per me, di quelle scolpite nel bianco e nero. Ieri, in un'intervista alla radio che non riesco a lincare, ha detto che Totti ha sbagliato, sì, ma che lui sa quanto le marcature a uomo possano essere esasperanti (il giornalista ricorda che Riva è il solo calciatore a essersi fratturato due gambe in maglia azzurra). Che Totti ha sbagliato, ma ai suoi tempi avrebbe spesso voluto prendere i suoi marcatori a rivoltellate. Che è giusto che Totti paghi, ma ai suoi tempi al fischio finale si metteva a rincorrere i suoi mastini, "e quattro o cinque li ho anche presi, non lo dico per vantarmi". Che non dobbiamo mitizzare la sua generazione, non era affatto più matura di questa. Sottointeso: quel che è cambiato davvero è la prova video.
La prova video. L'ossessione della diretta. Una telecamera fissa su Totti per 90 minuti. Un reality show su Totti. E quanto assomigliano ai calciatori bambinoni, i protagonisti dei reality show. Anche loro tengono stretta la pancia, portano orecchini e treccine, sembrano in grado di reggere lo stress della diretta, finché, prima o poi, sbroccano. Sono lì apposta per sbroccare, d'altra parte. È per questo che li guardiamo.
Bene, ho trovato il colpevole perfetto: il Grande Fratello. La ripresa televisiva moderna, invasiva e pervasiva, che ci rende tutti più patinati e più immaturi. È colpa sua se non vinceremo mai la Coppa del Mondo dei nostri papà (e nemmeno gli Europei). I nostri genitori probabilmente non erano dei santi, né dei campioni di eleganza: ma quando posavano per una foto si presentavano eleganti e ben pettinati. Così anche in campo, dove si picchiavano con meno complimenti di noi: ma il montaggio, compiacente, filtrava e ci restituiva un'immagine di uomini adulti e responsabili. Ma oggi la telecamera sempre in diretta restituisce ogni vaffa, ogni sputo. Tira fuori il peggio da ognuno di noi, perché è quel peggio che ci piace guardare. O no?
O forse no. È difficile descrivere la realtà mentre si precipita. Ma tante filippiche sul bel tempo che fu, si potrebbero riassumere in una sola frase: perdonatemi, sto invecchiando. I calciatori sono tutti più giovani di me, adesso. Non posso che trattarli da ragazzini. E mi dispiace per Totti, davvero. È dura rovinarsi una carriera per dieci minuti di follia.
Del resto i tempi cambiano, le mode si adeguano, e anche la tendenza del pupone irresponsabile potrebbe avere i giorni contati. La "mia generazione" si è ritrovata le strade e le case piene di telecamere, e non ha saputo fare di meglio che salutare con la manina, sputare e mettersi le dita nel naso. La prossima generazione troverà un modo di eludere anche questo controllo. Reagirà, crescerà, in modi e forme che io non posso nemmeno immaginare, e forse nemmeno capirò. Continuerò a precipitare brontolando che non ci sono più i calciatori di una volta, quelli che vinsero il Mundial.
(Ma se i puponi, nelle loro divise attillate, stringessero i denti e andassero avanti, sarei così felice di essermi sbagliato).
 Karaoke esistenziale, ciak! 13
Karaoke esistenziale, ciak! 13Era un piccolo, povero ultrà,
ultrà,
E non l'avrebbe mai più fatto, si sa
No non lo avrebbe mai più fatto
(fino alla prossima volta)
Proprio lui, povero ultrà,
ultrà,
Giurò di non rifarlo mai più, si sa
No non lo avrebbe mai più fatto
(fino alla prossima volta)
Povero vecchio
perse un orecchio in un "incidente"
al reparto saldatura
ma è tutto ochei,
tanto si sa la vita è dura
Povera donna
strangolata nel suo stesso letto
mentre leggeva Tolstoi
ma è tutto ochei,
tanto era vecchia e moriva prima o poi
(di chi è la colpa?)
E cosa dire dell'ultrà,
sì, dell'ultrà,
che non lo avrebbe mai mai mai mai più fatto, si sa
(non fino alla prossima volta)
Perciò signori della corte
ora sapete ogni cosa,
ma prima di condannarmi a morte
date un'occhiata a questo bocciolo di rosa:
Vi amo per quello che siete, amori miei, amori miei amori miei
Ma non sarà mica colpa dell'ultrà,
piccolo ultrà,
lui non lo avrebbe mai più fatto, si sa,
e in mezzo a questo campo siamo al verde, eccetera.
E non scordatevi l'ultrà,
il piccolo ultrà,
che non l'avrebbe mai più fatto si sa
e in mezzo a questo campo siamo al verde,
eccetera.
Eccetera,
Eccetera,
Eccetera,
Eccetera;
Nel mezzo del cammin della partita,
Eccetera.
Dai, liberatemi,
e ritrovatemi,
su liberatemi,
e ritrovatemi,
dai liberatemi, liberatemi, liberatemi
Giurati, liberatemi,
e ritrovatemi, e liberatemi, e ritrovatemi,
e ritrovatemi, ritrovatemi, ritrovatemi,
Ed Eccetera,
Eccetera,
Eccetera,
Eccetera,
Nel mezzo del cammin della partita, Eccetera,
Ed Eccetera,
Eccetera,
Eccetera,
Eccetera,
Nel mezzo del cammin della partita, Eccetera.
The Smiths, Sweet and tender hooligan. (198?)
Note:
1. Non è che la cosa abbia comunque molto senso.
2. In un periodo della sua vita, Morrissey ebbe palazzetti di folle adoranti che si sarebbero bevuti qualsiasi slogan, e lui nei ritornelli cantava “Eccetera”. Credo che si tratti di genio.
3. “In the Midst of life we are in debt” è un modo di dire, la parodia di un verso famoso di Coleridge (che si trova anche su un libro di preghiere anglicano per gli offici funebri), “In the Midst of Life we are in Death. Anche se col tempo la parodia è diventata più famosa del verso originale.
A questo punto si trattava di trovare qualcosa di omologo in italiano: si accettano suggerimenti.
Io, naturalmente, non riuscivo a pensare che a “Nel mezzo del cammin di nostra vita”, che è lievemente più cheap di Coleridge. Poi bisognava parodizzarlo, per cui: “Nel mezzo del cammin della partita”. Che non fa ridere e non vuol dir niente. La situazione finanziaria delle squadre romane, e i conciliaboli a centrocampo ieri sera, mi hanno suggerito una variante: “in mezzo a questo campo siamo al verde”: non c’entra più niente con Coleridge, ma è un endecasillabo. Sì, probabilmente ci sono modi più proficui di impegnare questo settore del mio cervello.
4. Dice: ma come fai a sapere tutte ‘ste cose? Qui c’è un sito con i più strani riferimenti delle canzoni degli Smiths, dove si scopre che alcuni capolavori di nonsense sono in realtà citazioni da un mondo che non conosciamo: per esempio, There is a Kenny Everett (late British 80s comedian) sketch where he is burned at the stake whilst wearing a Walkman, e In the 1968 film "The Killing Of Sister George", one of the murder methods discussed is that of a ten-ton truck…
5. Naturalmente, questo è il mio karaoke, per cui decido tutto io. Per eventuali lamentele, Morrissey può scrivermi. Astenersi filologi.
 Mario viaggia in Porsche
Mario viaggia in PorscheLa fonte di questa storiella è attendibile; ugualmente, non mi va di sputtanare il protagonista, per cui non userò il suo vero nome o cognome: diciamo che è un calciatore molto giovane; che è famoso sia per le sue mattane che per il bel gioco che gliele fa spesso perdonare: e lo chiameremo, per comodità, Mario Antonietto.
Allora: Mario Antonietto viene invitato al matrimonio di un collega, in un’altra città: il promesso sposo chiede a un suo amico di andare a prelevarlo alla stazione. L’amico, comprensibilmente emozionato, tira a lucido il suo mercedes ultimo modello e va ad aspettare Mario Antonietto. Per riconoscerlo, non c’è mica bisogno di una foto (in effetti basta la figurina).
Ed ecco che il campione arriva: saluta, squadra la mercedes e… rifiuta di salirci sopra. Perché? Perché Mario Antonietto viaggia solo su Porsche.
(Il risultato è che arriverà tardi al matrimonio, su una Porsche noleggiata in quattro e quattr’otto dal malcapitato anfitrione).
Mentre il giovane Mario impartisce questa severa lezione di stile, a qualche centinaio di chilometri di distanza la sua squadra versa in pessime acque. Il proprietario, che ha versato milioni su milioni (perdendoli), è vecchio e stanco: vorrebbe vendere, ma i probabili acquirenti giocano a nascondino. Si aggiungano le ispezioni dei finanzieri; le tasse da dilazionare; la borsa, gli stipendi… questo è il mondo in cui lavora Mario Antonietto. Ma lui non lo sa ancora. È giovane e bravo, ed è convinto che il calcio possa dargli tutto, come dava tutto ai suoi predecessori. Se si affacciasse al finestrino sentirebbe l’ancien régime che scricchiola. Ma Antonietto viaggia solo su Porsche. Pressurizzata.
Nelle puntate precedenti (1 – 2) avevo cercato di distinguere tra un modello ‘britannico’ (il calcio come piccola economia reale: i club autosufficienti che producono e distribuiscono ricchezza) e uno ‘italiano’ (il calcio come economia non autosufficiente, foraggiata dallo Stato e dai capitalisti per motivi d’immagine). Forse il modello britannico era più sano, ma presentava anche molti più rischi: dipendeva esclusivamente dal favore del pubblico (dalla soddisfazione dei clienti). Abbiamo visto che già negli anni ’50 il modello italiano poteva permettersi di pagare di più i suoi giocatori: le stelle del campionato inglese, Charles, Greaves, Law, vengono tutti a giocare in Italia. Non sempre si trovano a loro agio, ma arrivano a guadagnare quattro volte il massimo consentito nel Regno Unito. Già, perché nel calcio britannico, come in tutte le economie liberali serie, ci si preoccupava di garantire la libera concorrenza: i club non potevano offrire a un giocatore più di un tot consentito (Maximum Wage).
Il Maximum Wage può sembrare una norma di buon senso: significa accettare che tutte le squadre di un torneo giochino non soltanto con lo stesso numero di giocatori, ma anche con le stesse risorse economiche alle spalle. Eppure in Inghilterra i giocatori lottarono per cinquant’anni (la prima protesta, organizzata da Billy Meredith, è del 1907) per abolire quello che consideravano “un contratto di schiavitù” (Jimmy Hill). Ci riuscirono soltanto nel 1961. Da allora i giocatori – che fino a quel momento erano stati effettivamente commerciati sottocosto – videro lievitare i loro prezzi. Anche grazie all’introduzione della figura dell’“agente”. Gli ingaggi sarebbero ulteriormente lievitati a partire degli anni ’90, grazie a Jean-Luc Bosman.
Il giocatore belga più famoso del mondo (se la gioca con Vincenzino Scifo) è un centrocampista che non ha mai vinto nulla d’importante, salvo una sentenza alla Corte Europea di Giustizia. Bosman si era rivolto alla Corte dopo che la sua squadra (il Liegi) aveva rifiutato di cederlo al Dunkerque malgrado il suo contratto fosse scaduto. La Corte ci mise sette anni prima di deliberare, nel 1995, che il Liegi aveva contravvenuto alle leggi dell'Unione Europea sulla libera circolazione dei lavoratori (non delle merci, è importante) da uno Stato membro all'altro. In Italia la “sentenza Bosman” è famosa soprattutto per un suo corollario, che portò all’abolizione del tetto massimo di giocatori stranieri (comunitari). Da allora le grandi squadre italiane hanno fatto sistematicamente incetta di stranieri (anche perché a volte costavano meno e rendevano, in termine d'immagine, più degli italiani). Ma la “sentenza Bosman” ha fatto molto di più: ha messo il calciatore al centro dell’economia del calcio: specie il fuoriclasse, o quello che comunque attira l’attenzione. E' lui, da Bosman in poi, a decidere il proprio destino.
Se i campioni hanno avuto tutto da guadagnare dalla sentenza Bosman, chi ci ha rimesso? Le squadre medio-piccole, che fondavano la loro economia sul fiuto dei dirigenti: sulla loro capacità di trovare buoni giocatori, crescerli e rivenderli alle grandi squadre. Ma ora le grandi squadre possono aspettare il termine di un contratto per rilevare un “gioiellino”, senza pagare un soldo alla squadra che lo ha cresciuto. Così grandi squadre e “gioiellini” si spartiscono la torta. Ma la piccola squadra non ha più interesse a crescere nuovi gioiellini… sarà un caso, ma a partire dagli anni Novanta il campionato inglese, che storicamente era sempre stato più movimentato di quello italiano (l’albo d’oro registra tante squadre che emergono, vincono tutto, retrocedono, risorgono…) si è polarizzato nella sfida tra quattro-cinque grandi squadre (su tutte, il Man United di Ferguson): in un certo senso si è ‘italianizzato’.
Problema: se il mercato non finanzia più le squadre medio-piccole, ma solo i grandi giocatori e le grandi squadre; se nel frattempo il fenomeno degli hooligan rende necessaria il ridimensionamento degli impianti sportivi: dove troverà il calcio inglese i soldi per andare avanti? Risposta: i diritti tv. A partire dai ’90 il calcio cerca di vendersi sul piccolo schermo. È un processo a cui abbiamo assistito anche da noi: nel giro di pochi anni le trasmissioni televisive si sono moltiplicate. Nel Regno sono andati subito al sodo, cercando di piazzare i diritti del satellite. E ha funzionato?
Insomma. Con Murdoch ha funzionato. Ma Murdoch pagava solo le squadre della Premiership. Quelle delle divisioni minori si sono imbarcate in un affare con il canale ITV. È stato un disastro. Alcune squadre (Bury, York City) si sono trovate sul lastrico; la stessa sorte attendeva al varcale le squadre retrocesse dalla Premiership, che perdevano quindi i contratti con Sky (Derby, Watford); ma anche le squadre medio-piccole che lottano per restare in Premiership sono costrette a indebitarsi, perché i “gioiellini” costano troppo (è il caso del Leeds). Una delle ragioni della crisi è proprio questa: gli ingaggi dei giocatori. Le società si stanno indebitando per pagare la Porsche a Mario Antonietto.
Da che il mondo è rotondo (e la palla pure) ci si lamenta dei calciatori strapagati. Senza riflettere che in fondo guadagnano meno di molti banchieri e proprietari, sudando magari qualcosa di più. Ma proviamo a superare l’antico pregiudizio contro chi mette in mostra il suo corpo per vivere. Proviamo a pensare in maniera veramente aperta, moderna, liberale. È giusto che una persona che siede a una scrivania guadagni milioni d’euro al mese? Sì, se dalla sua scrivania fa girare miliardi. Se produce ricchezza, non importa se ne trattiene un po’. Se invece non ne produce, è solo un parassita: va rimosso.
E un calciatore? È giusto che Ronaldo prenda dieci, venti miliardi? (in realtà non so quanto prende). Dipende. Se il suo nome fa vendere abbastanza biglietti da mantenere uno stadio e chi ci lavora; se le sue giocate fanno vendere abbastanza magliette e scarpette da dare lavoro a migliaia di operai in tutto il mondo (un lavoro, si spera, umano e ben pagato), perché no? Ora, il problema è tutto qui: Ronaldo produce davvero tanta ricchezza? Il calcio è davvero quella gallina dalle uova d’oro su cui tutti hanno puntato negli anni ’90?
Negli ultimi anni abbiamo scoperto che non lo è, almeno non lo è in Italia (ma anche l’Inghilterra si sta allineando). Non produce ricchezza: anzi, non è nemmeno autosufficiente. Ha continuamente bisogno dello Stato, che continua ad accollarsi le spese degli impianti sportivi (negli altri Paesi occidentali, ricordiamolo, gli stadi sono proprietà privata dei club). In passato lo Stato gestiva questi impianti con gli introiti del Totocalcio: in questo modo si poteva dire che il Calcio finanziasse sé stesso, anche se aveva bisogno dello Stato per fare i conti e distribuire le risorse. Quando il rubinetto del Totocalcio si è ossidato, i grandi club hanno puntato su diritti tv e merchandising e, di conseguenza, sui fuoriclasse che attirano l’attenzione. Nella speranza che creassero ricchezza. Speranza vana. Oggi, come cinquant’anni fa, il calcio italiano è un’economia in perdita. Non è nemmeno un’economia: è un bene di lusso di poche grandi famiglie che possono permettersi di dilapidare milioni di euro in spese di rappresentanza.
Tutto questo Mario Antonietto ancora non lo sa (e non vorrei essere in lui il giorno che glielo spiegheranno).
 Calcio di Stato, calcio di Mercato
Calcio di Stato, calcio di MercatoAvvertenza: i livelli di dilettantesimo in questo pezzo sono pericolosamente alti.
Pare dunque che in Italia John Charles sia stato soprattutto un campione di fair play. In Gran Bretagna, invece, merita di essere ricordato per un altro motivo: il libro che sto traducendo afferma che Charles fu “the first rich British footballer”, il primo calciatore britannico “ricco”. Ecco, questo è interessante.
Charles è il primo a sbarcare con successo in Continente: l’offerta bianconera di 70.000 sterline non ha precedenti per il Regno Unito. Non ho capito bene quanto prendesse alla Juventus (gli inglesi fanno i conti in sterline e in settimane, noi in lire e in mesi), ma era quattro volte il tetto massimo consentito in Gran Bretagna. Così, nel 1957 gli italiani spendevano già più soldi per i calciatori degli inglesi. Questo è curioso, perché gli inglesi i soldi non li spendevano soltanto, li facevano anche. Ma gli italiani?
L’impressione che dà il calcio inglese (un’impressione, non una conclusione) è che si sia trattato, per più di un secolo, di una economia reale, che distribuiva ricchezza reale (anche se magari non ne distribuiva parecchia). Il fatto che molta di questa ricchezza non arrivasse ai giocatori non deve stupire: in fondo il loro ruolo era quello degli operai (o al limite, degli artigiani). Del resto i calciatori lo hanno capito presto, e hanno cominciato presto a sindacalizzarsi. Billy Meredith, altro leggendario campione del Galles, fondò una prima “Union” dei calciatori nel 1908. In quel periodo Meredith, ex minatore, giocava nel Manchester United e prendeva 4 sterline alla settimana. Oggi un giocatore della stessa squadra guadagna la stessa cifra in pochi secondi.
A partecipare più da vicino alla distribuzione della ricchezza erano i “Manager”. Attenzione, perché in Inghilterra il “Manager” è anche quello che siede in panchina (e che molto spesso riveste anche la funzione di “coach”). Ma non si limita a allenare la squadra, fare la formazione e studiare gli schemi: il Manager è il vero impresario del club: è lui ad acquistare e cedere i giocatori. Questo, almeno, nello schema classico del calcio inglese, impersonificato da alcuni grandi manager che hanno fatto la storia dei loro club: Herbert Chapman (Arsenal), Matt Busby (Man United), Bill Shankly (Liverpool). Alex Ferguson si inserisce nel solco di questa tradizione: non un semplice “mister” (ovviamente gli inglesi non usano questa parola): è il “Boss”. Le sorti della squadra e dell’intera società dipendono da lui. E la proprietà? C’è, ma in una posizione molto più defilata rispetto al modello italiano. Anche se oggi le cose stanno cambiando (ma un caso Berlusconi-Ancelotti deve risultare ancora abbastanza inconcepibile).
I manager scelgono come spendere i soldi dei club: ma i club, i soldi, dove li trovano? Prima della grande invasione degli sponsor, la principale fonte di reddito era lo stadio. Semplice, no? Se compri buoni giocatori e vinci le partite, la gente ti viene a vedere, e paga il biglietto. Se sei una piccola squadra, puoi crescere dei buoni giocatori e venderli alle grandi. (E se riesci a salire su qualche scalino della Coppa d’Inghilterra puoi farti notare meglio…)
Il classico stadio inglese non è né grandissimo né piccolo: diciamo che è più piccolo dei grandi stadi italiani e più grande degli stadi delle nostre ‘provinciali’. Ogni stadio (meno uno) appartiene a un club. Quando una squadra gioca “in casa”, gioca veramente “in casa”. Coabitazioni come quelle di Milan e Inter a San Siro sono inconcepibili: ci vollero i bombardamenti nazisti perché il Manchester United si abbassasse a giocare nello stadio del Manchester City.
Negli stadi inglesi molto spesso si stava in piedi, appoggiati a una ringhiera: se il manager era bravo e la squadra aveva successo, lo stadio si ingrandiva e magari metteva su una grande tribuna coperta. Poi il manager se ne andava e la squadra tornava piccola: la grande tribuna restava il simbolo del periodo d’oro della squadra (è il caso della grande tribuna del Nottingham Forest, intitolata a Brian Clough, che portò la squadra a due vittorie consecutive in Coppa dei Campioni).
Questo tipologia di stadio fu quasi totalmente smantellata dopo gli ultimi tragici incidenti degli anni Ottanta (Heysel, Hillsborough): lo Stato stanziò fondi ingenti per trasformare tutte le gradinate del Regno (le più importanti, almeno) in tribune con soli posti a sedere. Ma le abitudini non si stroncano dall’oggi al domani: all'Old Trafford di Manchester c’è ancora uno zoccolo duro di tifosi che segue le partite in piedi (contrasti con le autorità a non finire).
E in Italia? Le cose sembrano essere andate molto diversamente. La differenza più macroscopica sono gli stadi: nessun club possedeva il suo (a parte, credo, la Reggiana, che per farlo si è trasformata in Spa, ha venduto azioni ai tifosi e poi è quasi subito retrocessa). Di solito gli stadi sono comunali. Eppure le cose non erano sempre andate così: il primo San Siro, per esempio, fu costruito per iniziativa di Pirelli. Ma il modello “un manager – una società – uno stadio” non ha mai avuto successo. Cosa è andato storto?
Probabilmente l’Italia ha cominciato a giocare a calcio quando era una società ancora troppo povera (e contadina). Il calcio è un bene voluttuario: in Italia non c’era abbastanza pubblico, all’inizio. Poi il pubblico è arrivato, ma non aveva a disposizione abbastanza soldi per far girare la macchina. E così il calcio non è mai riuscito a diventare un’economia reale, ma è diventato subito un problema di ordine pubblico. Era la cittadinanza a doversi preoccupare di edificare gli stadi e tenerli in ordine. Era lo Stato (che presto diventa fascista) a doversi preoccupare di garantire agli italiani la loro quota di successi e vittorie: nasce così la nazionale di Vittorio Pozzo veicolo di propaganda del regime.
Non può fare tutto da solo, lo Stato. E infatti lo aiutano i padroni, in puro stile fascista e corporativo. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Mussolini non favorisce né la Roma né la Lazio (né il Predappio): intervenire a gamba tesa in un argomento tanto frivolo non era nel suo stile. Ma proprio gli anni ’30 vedono l’affermarsi della grande squadra-tipo italiana: la Vecchia Signora. La Juventus è la squadra di Agnelli che deve piacere all’operaio di Agnelli. L’ultimo Agnelli amava chiamare i giocatori coi nomi dei pittori del Rinascimento. Ci sentivi un muto rimprovero ai tempi: nel Cinquecento un principe come lui avrebbe finanziato artisti veri. Ma oggi la propaganda si fa con un centravanti, non con un affresco.
Non c’è spazio, in Italia, per una vera (e piccola) economia del calcio, come non c’è spazio per una vera libera impresa. Il calcio cresce, in Italia, soffocato dall’abbraccio mortale di politica e capitale. È da subito una questione di rappresentanza, di propaganda. Il nostro calciatore non è un operaio o un artigiano: è ancora e sempre il caro vecchio gladiatore, vezzeggiato e poi massacrato. Il suo ingaggio non ha niente a vedere con l‘economia reale e con quanta gente verrà effettivamente a vederlo: è una spesa di rappresentanza. Si spende tanto perché si deve dimostrare di poter spendere tanto: è la logica dei grandi padroni (Agnelli, Berlusconi, il vecchio Moratti), ma anche dei falliti eccellenti (Tanzi, Mantovani, Cecchi Gori). E' una logica rinascimentale, a cui si somma in alcuni casi quella medievale delle lotte tra i Comuni: una squadra che perde diventa una vergogna per l'intera cittadinanza. Il comune, l'ente pubblico, lo Stato, devono provvedere!
Il risultato è che il Calcio, in Italia, soffre di una cronica mania di grandezza che non ha nulla a che vedere con l'indotto che produce. San Siro è l'unico stadio ad avere aumentato i posti a sedere negli anni Novanta (mentre la tendenza mondiale è alla riduzione). Ma questa pretesa di grandezza ha qualcosa a che vedere con l'economia? Italia '90 ci ha resi più ricchi? I club italiani spendono davvero i soldi che guadagnano? Non saranno, anche loro, enti para-statali, protetti dalle municipalità (che mantengono gli stadi) e dal potere politico?
Gli inglesi hanno inventato uno sport, noi ci abbiamo messo la politica. Ma ci abbiamo messo anche il glamour: abbiamo trasformato il calciatore in un uomo di spettacolo. Deve averlo capito il buon John Charles, che era venuto a fare il suo mestiere (tirare calci a un pallone) e si ritrovò a cantare canzoni confidenziali nelle balere.
Poi (quel che è peggio), gli inglesi ci hanno copiato (ma questo, un’altra volta…)
 Avvert: io sono uno che, se dovesse parlare solo di quello che conosce bene, starebbe zitto sempre; ma mi diverto di più così. Se in questo pezzo ci sono strafalcioni, segnalatemeli, ve ne sarò grato.
Avvert: io sono uno che, se dovesse parlare solo di quello che conosce bene, starebbe zitto sempre; ma mi diverto di più così. Se in questo pezzo ci sono strafalcioni, segnalatemeli, ve ne sarò grato.In sé il calcio non significa niente: 22 persone che corrono intorno un pallone; ma se è per questo, diceva tale J. B. Priestley, anche l’Amleto è inchiostro su un pezzo di carta.
Quando poi ti volti indietro e ti accorgi che è già più di un secolo che gruppi di 11 persone si sfidano a pallonate e che la FIFA ha più membri dell’Onu (e forse, in questo periodo, più potere), capisci che un qualche senso dobbiamo trovarcelo. Per esempio, possiamo cercare di capire le “piccole differenze” tra noi e gli inglesi. Gli inglesi, probabilmente, non giocano a pallone meglio di noi. Ma hanno inventato il gioco e, sin dall’inizio, lo hanno usato in un modo diverso dal nostro. Cerchiamo di capire il perché.
Campionato e coppa
La Coppa Italia è inutile. In tutte le nazioni europee calcisticamente ‘mature’, le squadre professionistiche si incontrano in due forme di competizione: Campionato e Coppa. Sono due forme radicalmente diverse. Brutalmente, se il Campionato è la Prosa, la Coppa è la Poesia. In Italia abbiamo una pessima poesia, inutile e ridondante.
Il Campionato, per chi non lo sa, è una forma di torneo in cui ogni squadra incontra tutte le altre, due volte: una in casa e una in trasferta. Il Campionato principale, in Italia, è la Serie A, composta di 18 squadre, che si gioca in 34 giornate.
Caratteristica principale del Campionato è la prevedibilità. Il calendario viene pubblicato all’inizio della stagione, e contiene già le partite che si giocheranno nove mesi dopo. Nessuna squadra viene eliminata nel corso della stagione. I pareggi sono ammessi. Dopo un po’, è ovvio, una classifica comincerà a divaricare le squadre forti da quelle medie, le squadre medie da quelle deboli. Vince la squadra che ha più punti: le quattro squadre che ne hanno meno vengono retrocesse, cioè sostituite dalle squadre che sono arrivate prime in serie B. A un certo punto durante il Campionato può darsi che una squadra risulti già matematicamente vincitrice, o retrocessa: non per questo la competizione si interrompe. Questo avviene, naturalmente, per ragioni economiche: in teoria le società calcistiche in serie A hanno 17 incassi garantiti. Ma il risultato è che il Campionato diventa una incredibile metafora del lavoro quotidiano (non a caso finisce in estate e ricomincia in settembre). Le “giornate” del campionato scandiscono la nostra vita lavorativa: a volte sono noiose, a volte c’è il match clou, a volte i giochi sono fatti ma comunque bisogna continuare a lavorare, tanto i conti si fanno alla fine. E alla fine ci sono le scadenze: i più bravi premiati e promossi, i peggiori retrocessi, e in mezzo tutti noi, gente mediocre e poco organizzata che magari si è esaltata in un match importante ma non ha fatto i compiti quando andava in trasferta contro una provinciale: anche per quest’anno la Coppa Uefa ce la sogniamo.
Se il Campionato assomiglia alla vita di tutti i giorni, la Coppa ne è l’esatto contrario. La Coppa è l’avventura.
Non a caso lo schema-base delle Coppe ricalca quello dei tornei medievali: per esempio, se abbiamo 32 squadre, nel primo turno esse si sfidano nei “sedicesimi di finale”: le 16 vincenti negli ottavi; le otto vincenti nei quarti; le quattro vincenti nelle due semifinali; le due semifinaliste vincitrici in un’ultima finale. Non è consentito il pareggio (un tempo la partita si ripeteva, oggi sono previsti tempi supplementari e rigori); in quattro o cinque sfide una squadra arriva in finale. Le altre si fermano prima. Se il Campionato è la vita quotidiana, in cui tutti, bravi o mediocri, devono recitare la loro parte fino in fondo, la Coppa è l’Avventura di due sole squadre venute da lontano, che si fanno strada tra avversari mediocri (comparse che scompaiono subito) e s’incontrano finalmente nell’ultima sfida.
In Inghilterra la Coppa è (o è stata: le cose stanno un po’ cambiando) il trofeo più prestigioso. Sede della Finale era un non-luogo, uno stadio che non apparteneva a nessuna squadra e, come vedremo, a nessuna città: Wembley. Lo stadio della nazionale e della Coppa.
La Coppa è l’Avventura – ma, come ogni avventura che si rispetti, dev’essere movimentata, e portare l’eroe di fronte ad avversari più forti di lui. E infatti nelle prime fasi della Coppa d’Inghilterra sono le squadre delle serie minori (anche i dilettanti) a sfidarsi: le vincitrici si scontreranno contro le squadre di primo rango. Siccome ogni partita eliminatoria prevede un’andata e un ritorno, la piccola squadra di provincia che riesce ad arrivare più avanti ha l’onore di portare una squadra di rango nel suo stadio privato (particolare non secondario, come vedremo: in Inghilterra quasi tutti gli stadi sono proprietà delle squadre). E la storia della Coppa d’Inghilterra è piena di imprese di squadre blasonate che affondano in qualche fangoso campo di provincia o di quartiere. Quando accade, la BBC è sempre sul posto: le imprese delle piccole meritano gli onori della telecronaca. L’Avventura sovverte, per qualche sabato, le gerarchie imposte dalla Vita Quotidiana. E questo anche economicamente: una squadra di quarta categoria che riesce a portare nel suo stadio un club della Premier League, guadagna in quei 90 minuti più che in tutto il campionato. Per i calciatori è anche un’occasione di mettersi in vetrina.
Nulla di questo in Italia. Fatta l’eccezione per alcuni tornei appena prima della Seconda Guerra Mondiale (nel 1940/41 parteciparono 156 squadre!), la Coppa Italia è una competizione tra le squadre professionistiche delle prime tre divisioni. Nessun rapporto con i professionisti dei club minori, figurarsi coi dilettanti. Nessuna impresa di “provinciale”. (Ma d’altro canto, in Italia chiamiamo “provinciali” anche squadre di città di primo livello, come Verona, Bologna, Perugia…). Nessuna occasione per i giocatori di queste squadre (e infatti in Italia ci si lamenta degli scarsi 'vivai'). Così alla fine quel che resta è una replica di alcune sfide di serie A, ridondante e poco sentita.
Qui la questione si fa sottile. Non è che in Inghilterra una squadra di dilettanti possa battere il Manchester United: ma è importante sapere che ne avrebbe l’opportunità. E che c'è un largo pubblico di sportivi neutrali pronto ad applaudire le imprese delle squadre minori. In Italia il Canicattì non può sfidare e battere la Juventus in un match ufficiale. Non ne ha il diritto. Il nostro calcio, oltre a essere meno poetico, è anche più classista di quello inglese. E, last but not least, economicamente molto più fallimentare (continua, con calma).
 Cinque o sei motivi per incassare con stile
Cinque o sei motivi per incassare con stileAmmesso e persino concesso che di complotto si sia trattato, Madame, penso converrai che noi vittime potevamo incassare con più stile. Non sto parlando del gioco di Trapattoni, ma dei cronisti e commentatori che da due giorni non fanno che insistere su questo punto: "se la fifa è una mafia, perché non ne facciamo parte?" Da questo punto di vista non potrei scrivere qualcosa di più giusto e divertente di Zucconi (anche perché lui lo pagano). Mi sarebbe piaciuto che qualcuno almeno intonasse un piagnisteo sulla morale del gioco, sulla trasparenza dei bei tempi andati, che magari non ci sono mai stati, ma almeno ai ragazzini bisognerebbe raccontare che una volta le squadre vincevano lealmente, no?
Insomma, non dico la morale, ma perfino il moralismo è morto. Il mondiale è un palio di Siena dove la corruzione fa parte della competizione, Carraro è il dodicesimo uomo, che non ha saputo giocare la sua partita nelle tribune d'onore e ai ricevimenti che contano, per cui va licenziato a furor di popolo.
Per quanto mi riguarda, l'eliminazione non mi secca un granché. Convinto come sono che tutta la saggezza del mondo consista nella capacità della volpe di parlar male dell'uva che non riesce a raccogliere, avevo già preparato cinque o sei argomenti per dimostrare che Anzi, È Molto Meglio Così, e li ripassavo l'altro ieri in attesa del golden goal.
Ecco qui:
– Meglio perdere con la Corea che con un'antipatica squadra blasonata, tipo Francia o Inghilterra o Germania, che quando poi vai all'estero ti sfottono (prova a spiegargli che è un complotto degli arbitri, loro che non hanno avuto Piazza Fontana Ustica e Gladio ti daranno del paranoide).
– Perdere contro gli arbitri ci permette di fingere ancora per quattro anni di avere una grande squadra che gioca un grande calcio. Alè, l'illusione continua.
– O invece, al contrario, l'ennesima sconfitta ci costringerà a prendere atto che il nostro è un calcio malato, come diceva il tale.
– E poi tutto sommato, a me questi calciatori italiani in tutina aderente (Coco incappucciato sembrava decisamente un preservativo) non stanno tanto simpatici. Non è solo un fatto di stipendi: sì, guadagneranno un po' di più di un deputato, ma creano senz'altro più indotto e più felicità della maggior parte dei parlamentari. No, è una questione di stile. Non mi piace l'italiano che rappresentano, abbronzato, ben rasato, palestrato, pubblicizza le n i k e, esce con le veline, in ritiro fonde la playstation. Scusate se insisto sul concetto, ma a me piaceva Paolo Rossi, sembrava un mucchietto d'ossa gracili e si alzava più in alto dei brasiliani per segnare di testa. Se non avessi visto lui forse non avrei mai toccato un pallone. L'idea che i muscoli non siano tutto, e che tutti giorni si rimetta la palla al centro e si possano riscattare i propri errori. Rossi veniva da una squalifica, era un modello di riscatto. Vieri, scusatemi, al massimo è un modello di p u t t a n i e r e.
– E non scordiamo la politica, eh? Berlusconi si sarebbe preso tutto il merito. Qualcuno ricorda anche che, statisticamente, un mondiale perso anticipa una crisi di governo. (Bisognerebbe avere l'onestà di ricordare che i mondiali li abbiamo persi quasi tutti, e che i governi ci cadono in media ogni uno-due anni).
-- Così magari ricominceremo a leggere qualcosa di serio sui giornali. Ieri la strage di Gerusalemme (19 ragazzi morti) sul Resto del Carlino era a pagina 21.
– E magari per un po' non sentiremo più l'Inno di Mameli. Devo dire che stavolta si è passato il segno, soprattutto con le giovani generazioni. Mia madre mi riporta che i bambini lo cantano spontaneamente alla scuola materna, compresa la strofa di Balilla, e poi quel bel ritornello, "siam pronti alla morte". Quanto a me, la mia terza l'ultimo giorno di scuola me lo cantò all'unisono in tono di insubordinazione perché non li portavo fuori. Al che io risposi: 1. Se erano pronti alla morte, erano in grado anche di passare gli ultimi cinquanta minuti in aula a parlare dell'esame di licenza. 2. Sembravano proprio una bella classe di balilla idioti e desiderosi di andare a crepare per gli interessi altrui, ero molto deluso. Forse ho esagerato, ma cavolo, era l'ultimo giorno. Poi al tema d'italiano un ragazzo si portò un tricolore e a un certo punto ci s'involtolò dentro. Gli portava fortuna, secondo lui.
A proposito, devo fare ammenda per le mie previsioni e i miei calcoli sballati. Su questo blog di cazzate ne ho scritte molte senza che nessuno me le facesse notare, ma la scorsa settimana ho sbagliato a calcolare una differenza reti e mi avete scritto in cinque. Ragazzi, onestamente ci sono cose più importanti nella vita. Perché, ammesso e persino concesso che di complotto si sia trattato, Madame, penso converrai che ci son complotti ben più gravi da denunciare oggigiorno. Per esempio…
 A casa con sei punti?
A casa con sei punti?"Ma come, dico, è l'undici giugno, beccano un terrorista arabo con una bomba nucleare, c'è il congresso della Fao, la Bossi-Fini, il Polo perde a Verona, Jan è a Gaza e non dà notizie di sé, il Movimento è in crisi e lei mette su un pezzo sul calcio? Ma non si vergogna?"
Un po' sì.
Ho fatto un paio di calcoli e ho scoperto uno scenario tanto beffardo da essere quasi desiderabile – tanto si sa quel che valgono i miei auspici, no? – E allora mettiamo che domani l'Italia spinga con Vieri, Totti, Inzaghi e quanti altri, ma non riesca ad andare più in là dell'Uno a Zero. È plausibile: dopo tutto il Messico è ancora a porte inviolate.
E mettiamo che intanto la ciurma croata riesca ad insaccare… oh, non tante, appena un paio di reti: anche questo è più che plausibile: l'Ecuador ormai non ha più motivazioni (del resto era scarso anche quando le aveva).
Bene, il Messico resterebbe a sei punti, e con tre reti fatte e una subita si qualificherebbe. Massimo rispetto.
Anche la Croazia andrebbe a sei, ma con quattro reti fatte e due subite. E l'Italia? Anche l'Italia, esattamente, sei punti, quattro reti fatte, due subite (e due annullate, ma non contano più). Stessi gol fatti, stessi gol subiti, passa la squadra vincitrice nel confronto diretto, e cioè, come ben sappiamo, la Croazia.
E l'Italia andrebbe a casa. Con sei punti. Il doppio di quelli che fece nel primo girone del 1982 (mondiale vinto) e nel 1994 (mondiale perso in finale ai rigori). Insomma, andrebbe a casa per una beffa del destino, della matematica, del guardialinee. Ma con onore.
Il mondiale intanto continuerebbe, dispensando il suo oppio ad altri popoli: Bekham segnerebbe altri rigori per l'orgoglio britannico, Pochettino farebbe dimenticare agli argentini che non gli funziona più il bancomat, Ronaldo farebbe dimenticare ai brasiliani che il bancomat non l'hanno mai avuto. Ma noi italiani saremmo, per un po', fuori pericolo. Ricominceremmo a preoccuparci dei terroristi arabi con le bombe atomiche, di Gaza, della Fao, del Movimento. Per dire, la ragazza involtolata nel tricolore che dopo la vittoria con l'Ecuador disse alla telecamera: "vittorie così ci fanno sentire fieri di essere italiani" andrebbe a cercarsi qualche motivo un po' più serio, per sentirsi fiera. E per un po' anche l'Inno avrebbe finito di stressarci.
Ma allo stesso tempo, ci ritireremmo con la sensazione che non abbiamo perso. Come quando ci eliminano ai rigori: non è sconfitta, è il Destino, ma noi restiamo i migliori del mondo.
Questa è una convinzione che nessuna sconfitta riesce a toglierci: siamo i migliori. Che importa se i titolari delle nostre squadre sono per metà stranieri. Che importa se comunque queste nostre squadre non vincono nulla. Noi siamo e restiamo i migliori e il nostro campionato è il più bello del mondo.
Questo mi fa pensare a quel romanzo di Fenoglio, "Primavera di bellezza", dove si racconta del giorno in cui l'Italia entra in guerra, e nelle piazze risuona il proclama di Mussolini, e c'è un tale in una piazza che dice: "la Francia è già spacciata, all'Inghilterra do tre mesi". Non mi ricordo se siano tre mesi o più, ma ricordo che i bombardamenti iniziano quasi subito, e solo allora si scopre che l'Italia è senza contraerea.
Allo stesso modo, oggi, l'Italia è senza difesa: basta un infortunio di Nesta e si prende due gol pasticciati in contropiede: Maldini è il monumento di sé stesso, e in quanto monumento non è che si muova un granché. Poi naturalmente tutti a dar contro a quel difensivista di Trapattoni, che forse è l'unico italiano a rendersi conto che non siamo venuti da un altro pianeta, siamo una squadra come le altre.
Ecco, una eliminazione a sei punti ci impedirebbe ancora una volta di fare i conti con la realtà. Il nostro calcio è in crisi, metà delle squadre di serie A non avrebbero i soldi per iscriversi, la bolla delle pay tv è scoppiata miseramente. Le squadre più importanti, che in teoria dovrebbero essere il fiore all'occhiello di grandi gruppi economici, in realtà si finanziano con la speculazione, essendosi quotate in borsa: ovviamente, il valore delle loro azioni non ha nulla a che vedere con l'economia reale. Una volta pagavamo gli stranieri perché giocavano meglio: oggi in realtà li prendiamo perché costano meno dei nostri. Insomma, forse il nostro forse è il campionato più bello del Terzo Mondo.
Ma se domani ci mandassero a casa con sei punti, sapremmo chi è il colpevole. Il guardialinee. L'arbitro. Il regolamento. Trapattoni che non schiera cinque punte. Carraro che non veglia sui misfatti della Fifa. Tutti questi nemici del bel calcio italiano.
E tra quattro anni saremmo pronti a scommettere tutto di nuova sulla nostra nazionale, la favorita di sempre. Forza Italia. La Francia è già spacciata. All'Inghilterra do ancora due rigori.
 Continua da ieri (Nel frattempo l'Ecuador si è rivelata poca cosa, buona a vincere solo a 2000 metri d'altezza. Ma facciam finta di niente):
Continua da ieri (Nel frattempo l'Ecuador si è rivelata poca cosa, buona a vincere solo a 2000 metri d'altezza. Ma facciam finta di niente):...C'è bisogno di ricordare come andò a finire? Non ce la ricordiamo tutti, la partita più tragica, più brutta che abbiamo mai visto? Quando l'Italia prese il suo primo gol con l'Argentina, perse ogni qualità. Non era abituata a un avversario capace di replicare. Schillaci non trovò il gol. Tutti andarono in confusione. L'arbitro fece durare il secondo tempo un'ora intera: nemmeno lui sembrava rassegnarsi all'idea di un'Italia non vincente. Ma l'Italia non vinse più: perse ai rigori. E mi sembra di non averla ancora mandata giù. Come: avevamo lo squadrone più forte, avevamo dominato l'Austria, la Cecoslovacchia, l'Uruguay… Ripensandoci: non è stato più giusto così? quel gran squadrone in realtà aveva dominato qualche squadretta, sembrava dover vincere per procura il suo mondiale fatto in casa, come l'Inghilterra nel '66. Mentre quell'inguardabile Argentina, sconfiggendo il Brasile e poi l'Italia, aveva ripetuto a suo modo la fiaba della piccola squadra sola contro tutti, anzi, Maradona solo contro tutti, che piange all'olimpico dopo aver rovinato la festa di milioni di persone. Per la cronaca, il mondiale lo vinse la Germania. (Questo non se lo ricordano in tanti).
Italia-Brasile, nell''82, e Italia-Argentina, nel '90, sono i due shock che hanno formato il carattere del commentatore sportivo italiano – in un Paese dove i commentatori sportivi sono almeno quaranta milioni. La tendenza all'autodenigrazione, per esempio, deriva da lì: nel 1982 parlammo male dell'Italia e vinse i mondiali, nel 1990 non facevamo che parlare di come fosse forte e li perse. Da allora crocifiggere il CT e la formazione è diventato un vero rito scaramantico, e ne sa qualcosa Sacchi. Per inciso, quattro anni dopo l'Italia fece di tutto per rispettare il copione dell'Ottantadue, con una fase iniziale se possibile ancor più disastrosa. Anzi, forse il romanzo più ricco di colpi di scena della nostra nazionale è proprio USA '94, ma ha il grosso torto di finire male. Perciò di solito ci si ricorda soltanto che Baggio sbagliò il rigore, senza ricordare che fu solo Baggio a portarci fin lì. Da lì in poi la storia non cambia: l'Italia deve giocare male prima di dimostrare che può vincere. Partì male nel '98, giocò malissimo negli europei di due anni fa.
Ma appunto: l'Italia deve giocare male. Se non altro, per rendersi simpatica. Oggi che i calciatori sono dei divi in tutine aderenti, così diversi da quegli operai dell''82, oggi che posano nudi e abbronzati, hanno una sola possibilità di rendersi più umani: perdere, pareggiare, o almeno giocare male. Se oggi prenderanno una batosta dall'Ecuador, domani saremo tutti con loro. Ma stamattina, è ancora un po' difficile. Sono ancora i rappresentanti di quell'Italia caciarona che pretende di essere sempre favorita, di avere le squadre con tutti i più grandi giocatori stranieri, e che alla prima vittoria suona il clacson e si bagna nelle fontane, perché siamo i più forti del mondo. Quell'Italia stravincente che ci siamo immaginati di essere nell''82 e nessuno ce lo ha più levato dalla testa. Mentre io preferirei tifare per una squadra tra tante, che si arrabatta tra tante e dopo mille difficoltà si ritrova in finale. (Forza Italia, comunque).
 Vincere sì, ma soffrendo
Vincere sì, ma soffrendoVa bene, siamo tutti contenti perché la Francia ha preso un gol dal Senegal nella partita inaugurale, e in più anche stavolta l'Italia è tra le favorite. Io onestamente non me ne intendo, ma a questo punto un pronostico voglio farlo: e dico che la Francia andrà lontano, mentre l'Italia oggi potrebbe benissimo pareggiare o perdere, anzi, forse sarebbe meglio così.
Non sto remando contro: tifo Italia, come tutti. Non è una questione politica, Berlusconi non c'entra nulla, o forse sì. È una storia lunga e complicata che adesso cercherò di raccontare.
Parte da quando ero piccolo, e non sapevo di vivere nella quinta potenza mondiale: nessuno me l'aveva insegnato a scuola perché probabilmente nessuno lo sapeva. Dando uno sguardo al mappamondo era molto chiaro come l'Italia, che pure aveva un passato importante, gli antichi romani, ecc., era solo una penisola tra tante, assai meno visibile del Cile, poniamo, o dell'Arabia Saudita, per non parlare del Canada e di quell'altra nazione talmente grande da permettersi di chiamarsi con un nome lunghissimo: U n i o n e d e l l e R e p u b b l i c h e S o c i a l i s t e S o v i e t i c h e.
D'un tratto tutto cambiò, forse perché cominciavo a capire il telegiornale, o forse perché, in un pomeriggio del luglio 1982 la nostra nazionale vinse 3 a 2 contro il Brasile, con tre gol di Paolo Rossi. Quei giocatori italiani di vent'anni fa, dai nomi leggendari, in realtà fino a quel momento erano stati molto criticati, dai giornalisti giù giù sino al più umile cameriere di Bar dello Sport. Era una squadretta difensivista e smorta, che aveva rimediato tre mediocri pareggi con Polonia, Peru e… Camerun (ricordo un funebre titolo della Gazzetta: IL CAMERUN CI FA PAURA). Ad ogni modi una squadra tra tante, destinata a essere macellata tra i grandi nomi del torneo: Argentina e Brasile, per esempio.
Poi, all'improvviso, accadde qualcosa che ricordiamo tutti: la stessa squadretta, senza nulla cambiare, sconfisse Argentina e Brasile, e da quel momento fu a tutti chiaro che avrebbe vinto il mondiale, e infatti lo vinse, e vent'anni da allora mi sembra di che non abbiamo smesso di festeggiare quella vittoria inattesa, indiscutibile, che metteva la nostra penisola sopra a tante altre figure del mappamondo. Da quel momento il calcio, fino ad allora passione tutto sommato innocua, diventò una mania. La gazzetta dello sport incominciò a vendere più del corriere della sera, anche d'estate, e siccome d'estate non succedeva niente, i presidenti cominciarono a far parlare di sé comprando tutti i stranieri che trovavano sul mercato. Il nostro campionato divenne Il Più Bello Del Mondo, perché ci giocavano Zico e Maradona. Coincidenza, proprio negli stessi anni i nostri governanti cominciarono a dirci che sì, d'accordo, la mafia, la corruzione, il mezzogiorno, però malgrado tutto eravamo pur sempre la quinta potenza economica del mondo: i nostri alleati iniziarono a invitarci al G7, Craxi si mise a fare la voce grossa, e così via.
Però attenzione, io non sto dando la colpa a Paolo Rossi, che tornato al calcio dopo un anno di squalifica, tutti davano per cotto e mandò a casa i brasiliani con tre goal: la colpa è nostra, gli italiani hanno ogni tanto questi sussulti di grandeur. Ma la vittoria in Spagna è qualcosa di più: per me è sempre stato il simbolo della riscossa, dell'ottimismo della volontà, del "tu-mi-credi-finito-e-adesso-te-la-faccio-vedere". Ho un debole per le vittorie sofferte, per quel 3 a 2 che l'anno dopo il Torino inferse alla Juventus segnando tre gol in due minuti. Secondo me tutte le vittorie dovrebbero essere sofferte, altrimenti non vale.
Otto anni dopo (dopo una figuraccia in Messico che nessuno rammenta) tutto il mondo fu ospite dell'Italia-quinta-potenza, in un campionato del mondo che non sembrava poter essere vinto da altri. La squadra, intanto, era fortissima, poteva permettersi il lusso di non far giocare Vialli. C'era l'uomo del destino, un tale Schillaci che come lo mettevi su segnava, e partita dopo partita gli avversari iniziavano a scansarlo terrorizzati. C'era una difesa imbattibile, Zenga non prese un gol in cinque partite, record. E soprattutto non c'erano avversari: la Germania era il solito squadrone tutto muscoli, il Brasile stava sperimentando un nuovo ruolo, il difensore, e soprattutto, l'Argentina era inguardabile, figuratevi che aveva perso la partita inaugurale uno a zero col… col Camerun! Tutto il mondo aveva riso di lei.
C'è bisogno di ricordare come andò a finire? (il resto domani)
 Utopia, dice Fazio
Utopia, dice FazioNon si può applicare, e lo stesso Tobin l'ha rifiutata: ciò perché i flussi internazionali di capitali sono immateriali, avvengono grazie a sistemi computerizzati per cui noi conosciamo solo i saldi finali. La Tobin Tax non è realizzabile perché colpirebbe le transazioni, non i saldi finali, non si possono controllare 1-2 miliardi di computer.
Antonio Fazio
Chiaro, no?
Avete capito, ragazzi? Fate su i moduli e le penne, si torna a casa. La Tobin Tax non è materialmente realizzabile: se lo ha detto Fazio, che è un tecnico, sarà vero. Andiamo, su, che fa anche freddo. Stasera che si fa? Mah, si potrebbe guardare Roma-Juventus, il match seguito in diretta da un miliardo di telespettatori, come hanno detto su Rai1.
Ehi, no, aspetta un attimo.
Davvero han detto: “un miliardo di telespettatori?”
No, perché mi sembran tanti. Dopotutto al mondo siamo appena sei miliardi. E una buona metà denutriti, non tutti forse hanno i mezzi o la voglia di guardarsi Davids che morde le caviglie di Totti. Ma Rai1 dice che un terrestre su sei guarderà Roma-Juventus. In diretta. Compresi i cinesi, che immagino tifino la Roma: ha gli stessi colori della bandiera! E per la bandiera val bene la pena di svegliarsi alle cinque del mattino! Uno su sei, certo, che ci vuole?
O forse la stima di Rai1 è un tantino esagerata. È discutibile persino che ci sia un miliardo di televisori funzionanti al mondo. Anche ammesso che ogni televisore sia guardato in media da due spettatori, fa cinquecento milioni di teleschermi sintonizzati sull’Olimpico. Non lo so, io non sono un tecnico, però ripeto, mi sembran tanti.
E adesso che ci penso, anche i computer del prof. Fazio mi sembrano un po’ troppi. Un miliardo o due di computer connessi e funzionanti. Vediamo.
Ammetterete che la stima è un po’ approssimata: fa una bella differenza dire “un miliardo” o “due”. Da un tecnico ci si aspetterebbe un po’ più precisione. È vero che in economia un miliardo più o meno non cambia quasi nulla: ma qui si parla di persone, non di dollari. E ripeto, al mondo di miliardi persone ce n’è appena sei. Dire “due miliardi di computer” significa assegnare un computer connesso e funzionante a un terrestre su tre. Alla faccia del digital devide! Se si pensa che metà di questi terrestri non hanno mai fatto una telefonata in vita loro, bisogna che qualcuno, per la legge della statistica, faccia trading on line contemporaneamente da qualche centinaio di terminali. Non si capisce perché dovrebbe, ma la statistica è così: se Gino mangia due polli e Pino no, mangiano un pollo ciascuno. Su questo tutti i tecnici sono d’accordo.
Poi di colpo Fazio dice “un miliardo”, e trac! Di colpo la media scende da uno a tre a uno e sei. E il cambiavalute della Mongolia esterna a cui per la legge della statistica avevano appena lanciato un Pentium II se lo vede distruggere seduta stante da un paracadutista dell’ufficio stampa della Banca d’Italia. “Ci dispiace, è stato un errore. Il Governatore Fazio aveva sbagliato la stima per eccesso”.
 Restano comunque un bel po’ di computer. E non stiamo parlando di Vic20 o Olivetti ministeriali a carbonella, e neanche di 486: siamo seri, neanche un cambiavalute mongolo si metterebbe a trafficar valuta su un 486. No, bisogna che siano almeno dei Pentium. E ben connessi. D’accordo, ammettiamo pure che al mondo ci siano un miliardo di buoni computer connessi e abilitati al trading on line. Se le cose stanno così. Fazio ci ha appena detto che Echelon è una stronzata. Io a dire il vero lo sospettavo già, ma un parere tecnico fa sempre piacere.
Restano comunque un bel po’ di computer. E non stiamo parlando di Vic20 o Olivetti ministeriali a carbonella, e neanche di 486: siamo seri, neanche un cambiavalute mongolo si metterebbe a trafficar valuta su un 486. No, bisogna che siano almeno dei Pentium. E ben connessi. D’accordo, ammettiamo pure che al mondo ci siano un miliardo di buoni computer connessi e abilitati al trading on line. Se le cose stanno così. Fazio ci ha appena detto che Echelon è una stronzata. Io a dire il vero lo sospettavo già, ma un parere tecnico fa sempre piacere.Avete capito, CIA, FBI, M15, che da mesi cercate affannosamente notizie su Bin Laden in rete? Anche voi, fate pure su tutto e andate a guardarvi la partita. Non si può monitorare un miliardo di computer, l’ha detto Fazio, il governatore della Banca d’Italia.
E a questo punto, possiamo aggiungere, non c’è più nulla da fare. I computer ormai sono troppi, e si moltiplicano a vista d’occhio. Hanno già conquistato il mondo. Impossibile controllarli. Tanto vale abbandonarsi. È l’apocalisse? No, è il parere tecnico della Banca d’Italia. Chi dice il contrario è un utopista.
Anche chi fa notare che i computer abilitati al trading on line nell’Unione Europea devono essere meno, molti meno di un miliardo. E che monitorarli non dev’essere poi così difficile. In fondo un computer non è un pozzo nero, anzi, il problema dei computer è proprio che non cancellano niente. Altrimenti come farebbe la Consob a finanziarsi? Sì, la Consob italiana si finanzia proprio grazie a una bassissima aliquota sulle transazioni valutarie. Quindi, tecnicamente, in Italia la Tobin Tax è possibile. Basterebbe alzare l’aliquota…
E se tecnicamente la cosa è possibile in Italia (la terra degli Olivetti ministeriali a carbonella), non si vede perché non dovrebbe esserlo in Francia (dove è una proposta è già stata approvata), in Germania, in tutta l’Unione Europea. Insomma, proviamo. Non è ancora detta l’ultima parola. In fondo basterebbe assegnare un cookie a ogni transazione valutaria fatta da un terminale. Io non saprei come fare, son mica un tecnico, io. Ma scommetto di conoscere almeno due o tre smanettoni capaci di farlo. E altri due capaci di trovare un bug e perfezionare il sistema. Prof. Fazio, ci ascolti, non sventoli la bandiera bianca. I Robot non hanno ancora vinto. Un altro mondo è ancora possibile. Magari è un po’ difficile da spiegare, però è possibile. E non è utopia, no. È solo una questione tecnica.
È molto semplice applicare la Tobin Tax!
 Quando è ormai il fine settimana, e non vale la pena di iniziare qualche cosa, ma d'altronde senza cliccare il cliccatore si annoia, che si fa?
Quando è ormai il fine settimana, e non vale la pena di iniziare qualche cosa, ma d'altronde senza cliccare il cliccatore si annoia, che si fa?Si va nel sito del Manifesto. Li si trova sempre qualcosa di edificante.
Ieri per esempio ho trovato una recensione di certo Roberto Silvestri su La stanza del figlio di Nanni Moretti, di cui riporto un memorabile stralcio:
Più che la stanza, l'astanza, l'avrebbe chiamata Cesare Brandi, il contrario della realtà nella sua flagranza, preconscio e subconscio compresi. Niente naturalismo né realismo né surrealismo, né iper-realismo. E' mistero morettiano. E poi è il nono film e mezzo di Moretti (c'è un bacio vero, e un inizio di nudo di Laura Morante), il regista bradipo del cinema mondiale... Ma. Se a 15 anni avessi chiesto ai miei: "posso fare il sub?" mi avrebbero mandato a quel paese. Per chi abita nelle città di mare, le prospettive, però, son diverse […]
Certo, stralciare in questo modo non rende onore a una recensione che si prolunga per quasi 8000 caratteri, una monografia quasi (un'arecensione, direbbe Vittorio Panzana). Anche la chiusa, per esempio, è memorabile:
Andrea morendo indica una strada più misteriosa e sottomarina. E mette in guardia da una vita-fotocopia del contratto di Ancellotti: no alla vita agganciata alla produttività.
Ancellotti è il famoso allenatore della Juventus, ma forse il lettore medio ignora i termini del suo celebre contratto. Tanto peggio per lui, che pensa di poter arrivare alla pagina del cinema saltando le fondamentali rubriche sportive. La morale è: ci sono cose peggiori della morte, tipo i contratti a rendimento. Voi del resto ve li immaginate, i critici cinematografici del Manifesto con contratti a rendimento? Un tanto a battuta? Tantovale morire, in effetti.
Credo comunque che volesse dire che il film gli era piaciuto, che secondo lui valeva la pena di andarlo a vedere. Però… non so… ormai la trama me l'ha raccontata… mah.
Gli esilaranti calembour del Manifesto
Ma quel che mi rende ogni volta pieno di ammirazione è la capacità dei redattori del prestigioso quotidiano di saper riassumere tutti i fatti, i drammi e le tragedie del giorno, in sapienti giochi di parole, che strappano il sorriso del lettore nel mentre che lo educano a una visione più disincantata della realtà. Vediamo il titolone di oggi (venerdì). Salto Nel Voto. Mah. Non male, ma hanno fatto di meglio.
È difficile capire il perché, ma mi sembra di notare che l'estro dei redattori dia il meglio di sé in occasione di eventi luttuosi o catastrofici. Questa settimana abbiamo due o tre perle da mostrare:
Muore la scrittrice Luce d'Eramo: Una vita piena di Luce. (Un classico, ma funziona sempre).
Si diffonde il virus dell'afta epizotica, terribile per gli animali e i loro allevatori: Afta Siempre.
E (come in un crescendo wagneriano), così viene commentata la peggiore tragedia della settimana, il rogo di 41 bambini cinesi in una scuola (lavoravano alla preparazione di fuochi artificiali): Cina, pirotecnici compiti in classe.
Haaa haaa haaaa. Certo, detti a voce o anche riportati qui, estrapolati dal contesto, questi sapienti calembour perdono un po' del loro smalto, e diciamolo, non fanno così tanto ridere. Fanno però senz'altro meditare con maggiore lucidità sugli orrori del nostro quotidiano. Le smorfie che ci strappano sono l'espressione della nostra intelligenza critica. Afta siempre allevatori. Oggi è mancata la Luce. La classe… operaia va in paradiso. Heee heee heeee.











